, in cui solo il Sole e la
Luna, considerati pianeti, avevano il proprio epiciclo, ossia la
circonferenza sulla quale si muovevano, centrata direttamente sulla
Terra. Questo modello del sistema solare, che da lui prenderà il
nome di «sistema tolemaico», rimase di riferimento per tutto il
mondo occidentale e arabo fino a che non fu sostituito dal modello di
(310 a.C. circa - 230
a.C. circa). I metodi di calcolo illustrati nell'Almagesto (integrati
nel XII secolo dalle cosiddette Tavole di Toledo, di origine sasanide
e riprese dagli Arabi musulmani) si dimostrarono di una
,
almeno fino all'epoca delle grandi scoperte geografiche.
L'Almagesto contiene anche un catalogo di stelle. Tolomeo fu autore di diverse altre
opere di astronomia. L'"Iscrizione Canobica" e le "Tavole manuali" sono
strettamente collegate alla sua opera principale, mentre le "
" descrivono un modello meccanico del sistema
planetario, costituito da sfere celesti incastonate l'una nell'altra,
che è totalmente assente nell'"Almagesto". Altra
opera importante di Tolomeo è la
, che contiene
un'esposizione delle basi teoriche della geografia matematica e le
coordinate di 8000 diverse località. Una delle
innovazioni di tale opera fu proprio l'
per
l'identificazione dei luoghi sulla superficie terrestre. Il suo
oikoumenè copriva 180 gradi di longitudine, dalle Canarie
(nell'Oceano Atlantico) alla Cina, e circa 80 gradi di latitudine,
dal Mare artico all'Estremo Oriente (India Transgangetica) e
all'Africa centrale. Un'altra opera
scientifica importante di Tolomeo è l'
, che ci è
giunta incompleta. Il
trattato "
" ossia "Degli
effetti [delle configurazioni astronomiche sulla storia degli
individui e delle nazioni]"), conosciuto anche come
"
di Tolomeo, testo fondamentale dell'astrologia classica che sta alla
base dell'astrologia occidentale. Tolomeo è il primo autore classico
ad affrontare l'
: a
differenza di coloro che lo avevano preceduto, organizza l'analisi
delle influenze dei movimenti degli astri in pochi presupposti ben
definiti, istruendo il lettore a dedurre le predizioni utilizzando
. Nelle prime righe del "Tetrabiblos"
Tolomeo si scaglia contro i ciarlatani che, rivestendo in modo
improprio l'astrologia con pratiche magiche e occulte, hanno gettato
fango con predizioni arbitrarie su quella che lui considera una
; il limite delle predizioni astrologiche, secondo l'autore, sta nell'incapacità umana di comprendere completamente il funzionamento delle influenze degli astri che determinano, negli essere umani e negli eventi meteorologici e tellurici, destini ineluttabili. Tolomeo fu anche autore di un'opera di teoria musicale, gli
.
 |
"La scuola di Atene"- Raffaello Sanzio.
In quest'opera Raffaello rappresenta
i grandi filosofi del passato: Platone e
Aristotele al centro, Diogene di Sinope
sui gradini ai loro piedi. Nel gruppo alla
destra di Platone, Socrate che parla con
alcuni giovani, di cui quello con l'elmo
è Alessandro Magno. Epicuro, in basso
a sinistra consulta un testo retto da
un putto. Alla sua destra, Averroè con il
turbante che osserva Pitagora, inginoc-
chiato mentre legge e dietro di lui l'unica
donna, Ipazia di Alessandria. Dalla parte
opposta, di spalle con veste gialla,
Claudio Tolomeo che regge il globo
terracqueo e alla sua destra,
Raffaello stesso. |
- Nell'antichità, la
sapienza era riservata
a pochi. Fra
i filosofi dell'antica
Grecia era diffusa la consuetudine di rivolgersi ad un ampio pubblico con insegnamenti essoterici, manifesti, e di
riservare a gruppi ristretti, agli iniziati, gl'
insegnamenti specifici: quelli
esoterici, nascosti ai più. L'aristocratico Pitagora aborriva infatti l'idea di democrazia, anche solo come principio di condivisione delle conoscenze e quando emersero evidenze che scompigliavano l'ordine descritto dai grandi maestri, vennero
tenute nascoste. Il primo caso fu la scoperta, fra i
pitagorici, dei
numeri irrazionali, come ad esempio il rapporto tra la diagonale di un quadrato e uno dei suoi lati, pari alla radice quadrata di 2, valore non espresso da un numero intero (quindi "perfetto"), ma da un numero con una serie infinita di decimali. La conseguenza fu che
chi avesse
svelato il caso, mettendo in discussione la perfezione della visione pitagorica, potesse essere
ucciso. Altro caso fu il bizzarro movimento dei pianeti nella volta celeste. Probabilmente
l'
osservazione e lo
studio degli
astri è la
più antica delle
scienze. L'
Astrologia, da cui sono nate tutte le scienze, ci è giunta dai
Caldei (caldeo significa "conoscitore delle stelle"), che
si insediarono in Mesopotamia dal 1.500 a.C. e che la ereditarono dai
Sumeri, i
primi agricoltori stanziali: solo l'agricoltura infatti, permette ad una
popolazione di essere stanziale e articolata in una società
complessa, con nuove figure sociali e classi dirigenti assolutiste. L'
oroscopo aiutava quindi gli
agricoltori a
prevedere il
tempo meteorologico e i momenti più
adatti per le
semine che dessero migliori
raccolti. Dall'Astrologia si originò la ricerca delle affinità fra il mondo sotto il cielo e quello sopra, le cause del moto degli astri e fu
Platone a proporre un modello dei
massimi sistemi comprensibile e caratterizzato da moti uniformi e "perfetti" degli astri, con sfere cristalline, una per ogni pianeta più la luna e le stelle, solide e trasparenti, una dentro l'altra con quella delle stelle all'esterno, che contenevano nella loro rotazione attorno alla Terra, immobile al centro del cosmo, in successione la Luna, poi il Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno e da ultima la sfera delle stelle fisse che ruotava però nel senso opposto, come suggerito dalle osservazioni notturne, durante l'anno. Platone riteneva inoltre, giustamente, che la luce mostrata dalla Luna fosse quella riflessa del Sole e confermava gli assiomi pitagorici: 1°) la
circolarità dei moti di tutti gli astri (il cerchio era la figura geometrica che maggiormente racchiudeva i caratteri della perfezione) e 2°) l'
uniformità della loro velocità. Le concezioni astronomiche di Platone erano quindi allineate agli
assiomi pitagorici. Platone era tuttavia molto preoccupato di
non potere spiegare, col suo modello, gli
stazionamenti, i
moti retrogradi e le
variazioni di velocità che venivano riscontrate nell'osservazione dei moti planetari, dovute al sistema solare eliocentrico. Quindi, anche questa informazione era tenuta nascosta e riservata agli addetti, agli iniziati, che erano
esortati a
scoprire le
leggi che
potessero salvare la sua
visione del
cosmo, come riporta Eudemo da Rodi, riferito da Platone ai suoi adepti "...trovare con quali supposizioni di movimenti regolari ed ordinati si potessero rappresentare le evidenze osservate nei moti dei pianeti...". Claudio
Tolomeo cercò i motivi di quei fenomeni, ma pur non considerando l'eliocentricità del sistema solare, come invece aveva intuito Aristarco di Samo, trovò delle correzioni da applicare ai calcoli sui moti planetari, che approssimativamente si rivelarono affidabili. Ma mentre di Platone si dice: "grande fu il contributo di Platone all'astronomia perché fu l'oggetto dell'astronomia nei secoli successivi", la comunità scientifica positivista di fine '800 e inizio '900 ha individuato in Tolomeo il capro espiatorio contro il quale dirigere il proprio risentimento per il cammino erroneo percorso dalla scienza astronomica per più di milleduecento anni. Si potrebbe pensare che nell'antichità, la
riservatezza degli
insegnamenti propedeutici ad un'eventuale "illuminazione" da parte degli adepti, o "iniziati", sia da attribuire alla
volontà da parte di quei maestri, di
selezionare i beneficiari
del loro sapere, preoccupati che la diffusione delle grandi verità potesse essere utilizzata a fini politici e/o militari, come Archimede a Siracusa nelle Guerre Puniche, o economici, come fece Talete con le previsioni astrologiche di un'annata eccezionale per le olive.
 |
Ermes Trismegisto in una
rappresentazione nel
pavimento del duomo di Siena.
|
Probabilmente l'idea diffusa fra i sapienti, era che
solo coloro che cercassero risposte nel mondo spirituale/metafisico potessero essere i depositari del sapere, non comprensibile dalla
massa ignorante
e
incolta, coinvolta in problematiche di ordine materiale, a cui solo la religione trasmetteva un opaco riflesso delle leggi universali. Nelle superstizioni popolari invece, le conoscenze magiche dell'ermetismo affluivano corrotte da interessi materiali, come la convinzione che si potesse tramutare il piombo in oro. L'ermetismo si fa risalire a
Ermete Trismegisto, (Hermes tre volte grandissimo) che per gli Egizi era il dio Thot, colui che portò la scrittura fra le genti, e per gli antichi, ciò che era
scritto era
sacro, così come le tavole della Legge di Mosè sono state considerate scritte da Dio. Per i Greci era Hermes, il Mercurio dei Romani. Probabilmente l'ermetismo è il frutto di un sincretismo di saperi che giunge, attraverso l'antica Babilonia, dall'antico Egitto. A Ermete è attribuita la compilazione della
Tavola Smeraldina, il testo fondamentale degli studi "esoterici" giunti fino a noi. (Vedi
https://culturaprogress.blogspot.com/2020/03/ermetismo-e-alchimia.html)
 |
| Mitra |
- Negli
anni contemporanei alla
nascita del Cristianesimo, vi erano altri culti con tratti simili al cristianesimo: in Iran veniva adorato Mithra, il cui culto seguiva rituali segreti e sacrifici cruenti, i misteri mithraici, riservati ai soli uomini. Nati come culto della vegetazione, si fondavano su due divinità, una delle quali doveva morire per assicurare la fertilità, per poi rinascere. Fu portato in Italia dai soldati dell'esercito romano nel I secolo a.C. e da qui si propagò nei paesi dell'area germanica, in Gallia, Britannia e Spagna. Il Mitraismo prevedeva nel
25 dicembre il giorno di nascita di
Mitra,
figlio di
vergine, che nell'uccisione del toro compiva un
sacrificio che veniva celebrato in cerimonie che prevedevano
pasti comuni.
 |
| Sol Invictus |
C'era poi chi adorava il
Sol Invictus, che incarnava nella divinità solare la visione neoplatonica della luce come espressione divina, ed è di quei tempi la rappresentazione di un giovane Cristo raggiato, come il sole, alla guida del cocchio solare di Apollo con i 4 cavalli dell'iconografia tradizionale. Infine
Simon mago,
figlio di
vergine, nato il
25 dicembre, aveva
grandi poteri taumaturgici che esprimeva compiendo miracoli. Il
cristianesimo non individua più, come nei vecchi culti, le forze della natura come divinità e soprattutto la divinità non è più l'emanazione dello spirito della collettività (nell'antichità ogni gruppo o città aveva una propria divinità), ma è una via
individuale verso una divinità individualizzata, addirittura umana. Questa
presa di
coscienza dell'
ego individuale scatena una
tensione verso la
salvezza dalla
morte, in cui la
fede procura
certezze non dimostrabili razionalmente, ridisegnando la visione dell'oltretomba degli antichi, che accettavano la mancanza di certezze. Quest'ansia di salvezza in una vita beata ed eterna dopo la morte, ha stimolato il
desiderio di martirio, molto evidente nel Donatismo. La società cristiana dei primi tempi, pur essendo ordinata e compatta, è un organismo senza grandi motivazioni teologiche, visto che il messaggio del Cristo si era mantenuto sulla semplicità, motivazioni che stavano a cuore invece a Saul-
Paolo di Tarso, proteso a contenere nel cristianesimo, oltre agli Ebrei che come doveri religiosi dovevano solamente osservare la Legge della Torah, anche i
Gentili (non-Ebrei) ellenizzati, che andavano
coinvolti con elucubrazioni metafisiche che assicurassero una
vita nell'
aldilà. Per cui,
Paolo di Tarso, in contrasto con Simon Pietro e Giacomo fratello di Gesù,
permetterà ai nuovi convertiti di
evitare la circoncisione, consuetudine della Legge ebraica, a favore del battesimo nell'acqua. Sarà poi
Costantino I che, con il
concilio di Nicea, darà un corpo all'
edificio della Chiesa cristiana. I
cristogrammi sono combinazioni di lettere dell'alfabeto greco o latino che formano una abbreviazione del nome di Gesù e vengono tradizionalmente usati come simboli cristiani nella decorazione di edifici, arredi e paramenti. Alcuni cristogrammi sono nati come semplici abbreviazioni o acronimi, anche se sono diventati successivamente dei monogrammi. I principali cristogrammi sono: il Titulus crucis INRI, un acronimo ottenuto dalla frase latina Iesous Nazarenus Rex Iudaeorum, che significa: Gesù di Nazaret, re dei giudei;
 |
Moneta dell'usurpatore Magnenzio
(350-353) con al rovescio il
crismon Chi Rho. |
il Chi Rho o per antonomasia monogramma di Cristo (chrismon o crismon), monogramma costituito essenzialmente dalla sovrapposizione delle prime due lettere del nome greco di Cristo, X (equivalente a “ch” nell'alfabeto latino) e P (che indica il suono “r”); ΙΧΘΥΣ o ICHTHYS
 |
Significato del cristogramma
ICHTHYS, che in greco
significa "pesce" |
(che letteralmente significa “
pesce” in greco), acronimo formato con le iniziali della frase greca: “Gesù Cristo, di Dio figlio, salvatore”, lettere accompagnate o sostituite dal
disegno (stilizzato)
di un pesce; ICXC, un acronimo ottenuto dalla prima ed ultima lettera delle due parole Gesù e Cristo, scritte secondo l'alfabeto greco (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - si noti che la lettera finale sigma viene scritta nella forma lunata che ricorda la lettera latina C); il trigramma di Bernardino da Siena, IHS o Nome di Gesù, formato da tre lettere del nome greco di Gesù (ΙΗΣΟΥΣ).
Nel primo periodo della cristianità, a giudicare dallo studio delle catacombe,
il simbolo della croce, graffiato nel tufo o tracciato con il colore,
si trova abbastanza di rado (essendo strumento di tortura) mentre i simboli della Cristianità erano il pesce, i pani o l'ancora. Più diffuso si ritiene esser stato l'uso della "crux dissimulata", ottenuta ad esempio, interponendo la lettera "tau" maiuscola (T) al centro del nome del defunto.
Dal 92 -
Traiano continua la
penetrazione
romana nell'
area germanica degli Agres decumates, sia come governatore della Germania superiore
(attorno agli anni 92-96), sia come imperatore (tra il 98 ed il 100)
con l'avanzamento oltre il fiume Reno verso est, fino al cosiddetto
limes di Odenwald, tratto di frontiera che collegava il fiume Meno
presso Wörth, con il medio Neckar a Bad Wimpfen. Il successore
Adriano, contribuì all'avanzamento lungo il cosiddetto
limes
dell'Alb. Dopo secoli di ininterrotta dominazione romana, l'
Hispania ne aveva
assorbito totalmente la
cultura latina, ne aveva adottato la lingua, i costumi e le leggi, acquisendo un'importanza fondamentale all'interno dell'Impero romano, tanto da dare i natali a due imperatori: Traiano e Teodosio I (mentre sulla nascita ispanica di Adriano sussistono seri dubbi) e ad alcuni importanti scrittori, fra cui Seneca e Marziale.
- L'apocalisse del Nuovo Testamento della scuola evangelica giovannea, scritta in esilio nell'isola greca di Patmos durante una delle persecuzioni dei cristiani, probabilmente quella di Domiziano (intorno al 95 d.C.), alludeva però a Nerone come Anticristo. Secondo molti studiosi infatti, la persona rappresentata dal citato "Numero della Bestia" altri non è che il multi-gramma di gematria ebraica attribuibile all'imperatore Nerone, autore della persecuzione nella quale morirono sia Pietro che Paolo. Come in greco antico, così anche in alfabeto ebraico i numeri venivano scritti usando le lettere, secondo, appunto la cabala ebraica. Se quindi si utilizzano le consonanti ebraiche del nome QeSaR NeRON si ha: Q (qof) = 100, S (sameckh) = 60, R (resh) = 200, N (nun) = 50, R (resh) = 200, O (waw) = 6, N (nun) = 50 che sommate, danno appunto 666. Una sola nota merita la vocale O che è in realtà legata alla consonante W che è una mater lectionis, cioè una consonante che serviva a evitare equivoci nella lettura.
 |
Domiziano: Musei
Capitolini, Roma,
da QUI. |
Nel 96 -
Assassinio di
Domiziano (Roma, 24 ottobre 51 - Roma, 18 settembre 96), ultimo imperatore della dinastia flavia dall'81, che si era reso estremamente
impopolare per le sue tendenze autocratiche, spezzando l'illusione, creata da Augusto, che l'imperatore fosse solo un
primus inter pares, cioè il primo fra uguali. Quale censore a vita espulse dal Senato a più riprese gli elementi a lui sfavorevoli, determinando una forte situazione di attrito. Ai tentativi di congiura scoperti rispose sempre con fermezza, emettendo numerose condanne a morte che colpirono anche personaggi in vista dell'aristocrazia. Ciò non fece che accelerare i tentativi del Senato di
sopprimerlo, individuando infine un
liberto che aveva accesso alla sua corte come esecutore materiale e l'anziano senatore Marco Cocceio
Nerva quale suo
successore. A Domiziano venne inflitta la
damnatio memoriae, con la distruzione di ogni immagine, iscrizione o dedica che lo potesse ricordare ai posteri. Inizia così l'Età degli
Imperatori adottivi fino al 180 d.C., periodo che inizia con Marco Cocceio Nerva, un senatore già anziano, tradizionalista e uomo di cultura considerato affidabile dall’aristocrazia.
Nerva è nominato imperatore il 18 settembre del 96 d.C., lo stesso giorno in cui il
senato assassinava per mano di un liberto l’imperatore
Domiziano. Dopo un secolo di successioni confuse o addirittura tragiche, con imperatori designati dal principe in carica in quanto suoi famigliari, o dall’esercito o dal senato, il principio dell’adozione fornisce
finalmente un criterio certo e trasparente per regolare le
successioni. Con il principio dell’
adozione, il principe in carica adotta il suo successore con l’approvazione del senato, scegliendolo in base alle
qualità e ai
meriti. Con la loro mentalità pragmatica, i romani avevano infine accettato che, se un principe doveva esserci, almeno fosse l’
optimus princeps, il
principe migliore possibile, la persona più adatta a guidare lo stato. Un uomo moderato, giusto, prudente, equilibrato; attento agli interessi dello stato più che ai suoi; pronto a favorire la concordia e a stroncare le lotte di fazione; severo ma anche amorevole verso il suo popolo, come un padre; devoto agli dèi; non desideroso di essere considerato un dio, ma orgoglioso di venire divinizzato dopo la morte per aver ben governato. Nessun imperatore, naturalmente, poté incarnare appieno questo modello ideale: ma è certo che iniziò in questi anni il
periodo più florido e
pacifico della vita dell’
Impero.
 |
Nerva: Museo Romano-
Germanico di Colonia,
foto di Carole Raddato
da QUI. |
Così, tra il 96 e il 180 d.C. si succederanno le grandi figure di
Nerva (96-98),
Traiano (98-117) con cui l’impero si ingrandisce raggiungendo la sua
massima espansione,
Adriano (117-138),
Antonino Pio (138-161) e
Marco Aurelio (161-180). Con
Commodo, figlio di Marco Aurelio, si
ripristina il
principio dinastico. L’Età degli Imperatori adottivi è il
periodo più
grandioso dell'impero romano poiché gli imperatori perseguiranno una politica di riconciliazione con il senato e le varie forze politiche e sociali di Roma, mirando ad una riorganizzazione dell’amministrazione imperiale.
- Nel 96 Marco Cocceio
Nerva Cesare Augusto (Narni, 8 novembre 30 - Roma, 27 gennaio 98), meglio conosciuto semplicemente come Nerva, è
imperatore romano, primo degli imperatori adottivi, dal 18 settembre 96 fino alla sua morte avvenuta nel 98, è ricordato come uno dei migliori imperatori di Roma.
 |
Traiano: Museo
Archeologico di
Venezia, foto di
Carole Raddato
da QUI. |
Nel 98 - Marco Ulpio Nerva
Traiano (Italica, antica città della Spagna romana vicino all'attuale Siviglia, primo insediamento di romani e italici nella penisola iberica, 18 settembre 53 - Selinunte in Cilicia, 8 agosto 117) è
imperatore romano dal 98 al 117.
 |
Cartina dell'Impero Romano da Ottaviano Augusto a Tiberio, Claudio, Vespasiano e Domiziano fino a Traiano, che nel 117 d.C. lo portò alla sua massima estensione. |
Nacque in provincia, provenendo da una colonia di Italici denominata Italica nella Hispania Bætica (attuale Andalusia, Spagna) dove la Gens Ulpia di cui faceva parte si era trasferita dall'Umbria, in particolare da Todi. Valente militare e popolare comandante, venne adottato da Nerva nel 97, succedendogli due anni dopo. Esaltato già dai contemporanei e ricordato dagli storici antichi come “
Optimus princeps” ovvero il migliore tra gli imperatori romani, da molti storici moderni ed esperti è considerato, in virtù del suo operato e delle sue grandi capacità come generale, amministratore e politico, come uno degli statisti più completi e parsimoniosi della storia e uno dei migliori imperatori romani. Traiano, che aveva continuato la penetrazione romana nell'area degli Agri Decumates come governatore della Germania superiore intorno agli anni 92-96, come imperatore (tra il 98 ed il 100) avanza oltre il fiume Reno verso est fino al cosiddetto
limes di Odenwald, tratto di frontiera che collegava il fiume Meno presso Wörth, con il medio Neckar a Bad Wimpfen. L'impero di
Traiano porterà l'
Impero Romano alla sua
massima estensione nel
117.
- Nel 98 lo storico romano Tacito scrive "De origine situ germanorum", dove riporta i risultati delle "interviste" che aveva fatto ai soldati romani di ritorno dai territori in cui erano insediati i Germani, le cui tribù incontrate dalle legioni romane erano state 40 e più. Tacito era così venuto a conoscenza che le tribù dei germani discendevano dai tre grandi ceppi provenienti dall'Oceanus Germanicus (il mare del Nord), dal Suevicum (territori limitrofi al mar Baltico) e dal Cimbrico (lo Jutland, nell'attuale Danimarca), mentre le antiche migrazioni germaniche erano avvenute lungo due grandi direttrici, dalla Scandinavia a sud-ovest verso il Reno e a sud verso il Danubio. I popoli germanici erano chiamati dai Romani "Germani" poiché una delle prime tribù che conobbero e che sconfissero era quella dei Jerman, proveniente dalla penisola dello Jutland e scesa verso il Danubio superiore, ai confini dell'Impero romano, insieme ai Suebi (genericamente chiamati Marcomanni), Cimbri, Ambroni e Teutoni. Noi sappiamo poi che i i Germani entrarono in contatto con le civiltà celtiche che si erano diffuse in Europa fin dal 1200 a.C. con l'età del ferro (cultura di Golasecca, poi Hallstatt e Nauchâtel). I Celti abitavano l'Italia settentrionale, alcune zone del nord ispanico e i territori intorno ai fiumi Mosa, Reno, Meno, Marna e il territorio dello Champagne: tutti queste popolazioni celtiche erano chiamati dai Romani "Galli". Altri gruppi celtici dominarono invece l'intero corso del Danubio, dalle sorgenti in Svevia fino al Mar Nero mentre i Celti Galati andarono in Asia Minore, prima come soldati di Filippo il Macedone e poi del figlio, Alessandro Magno. A causa delle migrazioni germaniche dal nord Europa, iniziate nel 700 a.C., un buon numero di Celti furono cacciati dai loro insediamenti nel centro europeo, come i Boi che erano prima in Boemia e poi in Baviera (Baiovara), rimasti nei toponimi di quelle regioni, per cui di Celti ne rimarranno in Italia Settentrionale, alcuni fondendosi con gli antichi Liguri, in Francia, nella Galizia iberica, in tutta la Britannia (Scozia inclusa) e Irlanda. Ai tempi di Tacito, i Germani erano ormai diventati agricoltori stanziali e lo storico romano, come già Cesare prima di lui, si occupava esclusivamente dei "Germani occidentali", che sono dunque i primi a essere descritti dettagliatamente dalla storiografia. Tacito testimonia che inizialmente questi Germani non erano interessati ai territori romani. Ogni tanto sommovimenti generati all'interno o indotti da pressioni esterne convogliavano l'aggressività di queste tribù guerriere verso i confini dell'Impero romano, che suscitava in loro cupidigia ma anche paura e riverenza. Ma l'Impero era troppo forte e le tribù troppo deboli per potere consolidare quelle incursioni in vere e proprie campagne militari. Le incursioni erano piuttosto i Romani a effettuarle nelle terre barbare, con risultati terrorizzanti. Fu solo tra il II e il IV secolo che, spinti dalle tribù di nomadi delle steppe che, superiori militarmente, ne occuparono i pascoli, i Germani iniziarono a premere verso i confini dell'Impero. Sappiamo che a partire dalle campagne di Druso, (Nerone Claudio Druso, 39 - 9 a.C., conosciuto come Druso maggiore, militare e politico romano appartenente alla dinastia giulio-claudia in quanto figlio della terza moglie di Augusto, Livia Drusilla e fratello minore di Tiberio) la popolazione dei germani Sicambri (o Sigambri) aveva cominciato a fornire truppe ausiliarie all'interno dell'esercito romano. Sono citate le seguenti unità: I Claudia Sugambrorum tironum veterana, che fu prima in Mesia sotto Vespasiano (nel 77), poi in Mesia inferiore sotto Domiziano (nel 91), Nerva (nel 96-98) ed ancora sotto Antonino Pio nel 139 e nel 145. La troviamo in Siria nel 157; della II e III Sugambrorum se ne ipotizza l'esistenza in base alla presenza della IV; la IV Sugambrorum si trovava in Mauretania Caesariensis sotto Traiano nel 108. Dal 26 gli storici non li citano ma sembra che possano essere affluiti nella federazione dei Franchi. Secondo alcune fonti (fra cui Fredegario) i Franchi Sicambri, che discendevano, attraverso l'Arcadia, dalla tribù israelitica di Beniamino, sarebbero stati gli antenati dei Merovingi.
 |
La Germania Magna nel 98. Clicca sull'immagine per ingrandirla. |
- Gli
Slavi orientali, dell'Europa orientale (stanziati nel bacino del Dnepr centrale e superiore e distinti dagli Slavi occidentali, i Venedi-Sclavini) conosceranno tardi la differenziazione di ceti e classi. Fino al I sec. d.C. tra loro si conserverà un sistema comunitario non molto diverso da quello di mille anni prima. Infatti soltanto nel
I-
II secolo si formano le
grandi famiglie patriarcali, proprietarie di tutti gli strumenti produttivi e in grado di avvalersi del servizio di forze schiavili, per quanto ancora nel VI sec. il diritto comune proibiva l'asservimento di propri connazionali, sicché si deve pensare che tali schiavi o erano nemici catturati in battaglia o venivano comprati sui mercati esteri dalle famiglie più facoltose. Nell'Europa centrale furono soprattutto le
tribù Slave nella
Germania nord-orientale che, a seguito della disgregazione progressiva della comunità primitiva, si dedicarono ampiamente ai commerci con l'impero romano, la Scandinavia e l'Europa orientale.
- Sàrmati e Romani non ebbero sempre rapporti pacifici e anzi spesso si fronteggiarono in lunghe guerre fin dai tempi di Augusto. Sul finire del I secolo-inizi del II d.C., Roxolani e Iazigi (alleati per tutto il I secolo d.C. di Roma) si schierarono contro i Romani con i Daci per difendere questi ultimi da Traiano che intendeva conquistarne i territori, e fu proprio Traiano a sconfiggerli durante la campagna. I Sàrmati erano un popolo iranico e quindi, come gli Sciti, facevano parte della famiglia linguistica iranica (famiglia linguistica indoeuropea). Aperti alla cultura e alla religione persiana, si dividevano probabilmente in quattro tribù: Iazigi, Roxolani (o Rossolani), Aorsi e Alani. In origine abitavano le steppe lungo il Volga, le regioni pedemontane degli Urali meridionali e la steppa del Kazakistan occidentale. Nei loro territori d'origine essi si scontrarono con i Battriani, i Parti e i Sogdiani. In diversi periodi e a diverse ondate essi si spinsero verso occidente.
Nel 115/117 - Seconda guerra giudaica o Guerra di Kitos (Rivolta contro Traiano). La maggioranza dei rabbini e della popolazione aveva accettato la sottomissione a Roma come fase transitoria e necessaria in quanto voluta da Dio in preparazione dell’avvento dell’età messianica, mentre in una produzione letteraria fra il 70 e il 135 d.C., fra cui l’Apocalisse di Baruc e il Quarto libro di Esdra, ci si interrogava sulla distruzione del Tempio e sul suo significato, con allegorismi vari, fra cui la lotta fra il Leone e l'Aquila, in cui il leone è il Messia e l’aquila che soccombe è l’Impero Romano. Questo accumulo di tensione sfociò nella grande rivolta tra il 115 e il 117 d.C., che coinvolse numerose e importanti comunità giudaiche in Egitto, Cirenaica, Cipro e Mesopotamia. Essa colse di sorpresa le autorità imperiali e lo stesso imperatore Traiano, che usò la mano pesante nei confronti dei Giudei della Mesopotamia, volendoli punire in modo esemplare. Anche la Giudea, pur non avendo partecipato alla rivolta, ebbe dei contraccolpi. Il controllo del territorio venne rafforzato con lo stanziamento di un secondo contingente permanente.
Nel 116 - Mentre era in Cilicia preparando un'altra guerra contro la Partia, Traiano, che spesso cavalcava sotto la pioggia esponendosi agli stessi disagi dei soldati, si ammala. La sua salute declinerà durante la primavera del 117, forse a causa di un colpo apoplettico o di una malattia infettiva contratta in Mesopotamia, finché l'8 agosto muore a Selinunte, in Cilicia (odierna Gazipaşa, in Turchia), per un edema polmonare o un infarto cardiaco causatogli dalla sua malattia. Non è certo che abbia effettivamente nominato Adriano suo successore, ottimo governante ma di cui conosceva le differenze caratteriali rispetto a sé. La moglie Plotina dovrebbe comunque avere contribuito in qualche modo alla sua elezione a imperatore se Traiano lo avesse effettivamente adottato in punto di morte.
 |
Adriano: Museo delle
Terme, Roma. Foto di
Livioandronico2013
da QUI. |
Nel 117 - Publio Elio Traiano
Adriano, noto semplicemente come Adriano (Italica, antica città della Spagna romana vicino all'attuale Siviglia, primo insediamento di romani e italici nella penisola iberica, 24 gennaio 76 - Baia, frazione di Bacoli, comune della città metropolitana di Napoli e parte dei Campi Flegrei, 10 luglio 138), è
imperatore romano della dinastia degli imperatori adottivi dal 117 alla sua morte. Successore di Traiano, fu uno dei "buoni imperatori" secondo lo storico Edward Gibbon. Colto e appassionato ammiratore della cultura greca, viaggiò per tutto l'impero e valorizzò le province. Fu attento a migliorare le condizioni dei militari e, essendosi recato lungo la frontiera germano-retica degli
Agri Decumates, contribuirà all'avanzamento del
limes con la costruzione della
linea dell'
Alb, a sud di Stoccarda e a nord dei monti dello Schwäbische Alb, le Alpi sveve, da Rottweil verso Lautlingen, Burladingen,Gomadingen, Donnstetten, Ursprig, Heidenheim, Lauchheim, Oberdorf, Dambach, Theilenhofen, Ellingen, Ober-hochstatt, Pförring, dotandolo di
torri di
guardia paragonabili a quelle del
limes del Taunus-Wetterau-Odenwald, con la costruzione di numerosi forti in pietra, oltre al consolidamento di quanto fatto dai suoi predecessori. Vedi anche "Romani e Germani - I - Dall'antichità al limes degli Agri Decumates nella Germania romanizzata"
QUI.
Nel 122 -
In
Britannia viene eretto il
Vallo di Adriano per contenere gli assalti dei Celti (in particolare i Pitti).
Nel 131/136 - Dopo varie ritorsioni, l'Imperatore Romano Adriano rinomina Gerusalemme "Aelia Capitolina" e proibisce la circoncisione. Simon Bar Kokheba (Bar Kochba) capeggia gli ebrei nella terza guerra Giudaico-Romana, vasta rivolta ebraica contro Roma come reazione contro le azioni di Adriano. In seguito, la maggior parte della popolazione ebraica è annientata (circa 580.000 morti) e Adriano rinomina la provincia di Giudea "Syria Palaestina" intendendo cancellare il nome di Iudea sostituendolo con quello che deriva dal greco "Phalastine" e sta ad indicare la "terra dei Filistei" e tenta di sradicare l'Ebraismo. Sarà l'ultima rivolta, che vedrà, con la capitolazione di Masada, la fine delle ribellioni contro Roma e il completamento dell'espulsione del popolo Ebraico dalla Palestina. La tragedia dell'epoca di Adriano segnò per i Giudei la fine del sogno di uno stato indipendente e il rinvio definitivo dell'arrivo di un Messia. La realizzazione di questa aspirazione coincide con la nascita del sionismo nell'Ottocento e alla proclamazione dello stato di Israele nel 1948.
- Visto che la corruzione sessuale dei costumi si stava diffondendo sempre più, l' imperatore romano dal 117 al 138 Adriano (Italica, 24 gennaio 76 - Baia, 10 luglio 138), che pur amava sinceramente il ragazzo Antinoo, in linea con la cultura greca dove la componente omosessuale aveva radici profonde, promulga leggi severe per ostacolare tale corruzione.
Nel 138 - Adriano muore nella sua residenza di Baia di edema polmonare, a 62 anni come il predecessore Traiano. Cassio Dione Cocceiano riporta in un brano della "Storia romana": «Dopo la morte di Adriano gli fu eretto un enorme monumento equestre che lo rappresentava su una quadriga. Era così grande che un uomo di alta statura avrebbe potuto camminare in un occhio dei cavalli, ma, a causa dell'altezza esagerata del basamento, i passanti avevano l'impressione che i cavalli ed Adriano fossero molto piccoli.». In realtà non è certo che il monumento funebre sia stato iniziato dopo la morte dell'imperatore e molto probabilmente fu iniziato da Adriano nel 135 e, dopo la morte, terminato dal successore, adottato ufficialmente prima di morire, Antonino Pio. La struttura fu, nei secoli, trasformata ripetutamente e oggi è uno dei monumenti più famosi di Roma: Castel Sant'Angelo, che è infatti anche denominato Mole Adriana. Esistono teorie secondo cui il sarcofago in porfido dell'imperatore (in particolare il coperchio) sia stato riutilizzato come vasca del fonte battesimale di San Pietro in Vaticano. In merito alla sua divinizzazione
postuma, voluta dal suo successore Antonino Pio, si oppose fieramente
tutto il Senato, che non aveva dimenticato come Adriano avesse
diminuito l'autorità dell'assemblea e ne avesse mandato a
morte alcuni membri. Alla fine si giunse ad un
compromesso: il senato non si sarebbe opposto alla divinizzazione del defunto imperatore se Antonino avesse abolito l'organo di governo dell'Italia formato da quattro giudici circoscrizionali, i consulares («consolari», cioè ex consoli), o legati Augusti pro praetore («delegati di Augusto con comando ‘propretorio’»), con funzioni giurisdizionali in Italia, funzioni che erano state appannaggio dell'ordine senatorio.
 |
Busto di Antonino Pio
conservato a Monaco
di Baviera. |
- Nello stesso 138 Cesare Tito Elio Adriano
Antonino Augusto
Pio, nato come Tito Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino (Lanuvio, 19 settembre 86 - Lorium, 7 marzo 161), è eletto
imperatore romano fino al 161. Imperatore saggio, l'epiteto
pius gli venne attribuito per il sentimento di amore filiale che manifestò nei confronti del padre adottivo che fece divinizzare. Il suo principato è stato
caratterizzato da
pace interna e
floridezza economica, mentre l'unico fronte in movimento era in Britannia, dove Antonino avanzava oltre il Vallo di Adriano, facendo erigere un altro vallo più a nord, che però fu abbandonato dopo solo vent'anni dalla sua costruzione. Antonino mantenne sempre un
atteggiamento deferente verso il
Senato, amministrò saggiamente l'impero evitando sperperi e non avviò nuove costruzioni importanti o riforme urbanistiche. Fu attento alle tradizioni religiose senza però perseguitare i culti non ufficiali. In questo periodo l'impero ottenne il pieno
consenso delle élite cittadine e delle province, che beneficiavano ampiamente della
Pax Romana.
 |
Valli di Adriano e Antonino. |
Nel 142 - Costruzione in Britannia del Vallo di Antonino, iniziata nel 142 (sotto Antonino Pio imperatore) e completata nel 144. Il vallo si estendeva per 39 miglia (pari a 63 chilometri) da Old Kirkpatrick nel West Dunbartonshire sul Firth of Clyde a Bo'ness sul Firth of Forth. La fortificazione fu costruita per rafforzare il Vallo di Adriano, posto 160 km più a sud come confine settentrionale della Britannia. I romani, anche se riuscirono a insediare accampamenti e fortilizi temporanei a nord del vallo, non arrivarono mai a conquistare e sottomettere le tribù indigene celtiche, in particolare i Pitti, che resistettero ed infersero danni alla fortificazione.
Dal 145 - Durante il principato di
Antonino Pio
(precisamente negli anni 145/146) molte delle
torri e dei
forti in
legno disposti lungo il
limes germanico sono ricostruiti interamente
in
pietra mentre
avanza il
limes stesso degli
Agri Decumates di oltre 30 km ad est della
precedente linea dell'Odenwald-Neckar, con una
linea statica di uomini nelle
fortificazioni detti appunto limitanei dal termine latino
limes.
 |
Carta degli Agri Decumates
nel 90, sotto Domiziano. |
Gli Agri Decumates o Decumates Agri erano una regione della provincia romana della Germania superior, comprendente l'area della Foresta Nera tra il fiume Meno, le sorgenti del Danubio e il corso del Reno superiore fra il lago di Costanza e la sua confluenza col Meno, e corrispondente all'odierna Germania sud-occidentale (Wurttemberg, Baden e Hohenzollern). A sud-est i Decumates confinavano con la Rezia, provincia importante dal punto di vista militare. L'unica testimonianza antica del nome Agri Decumates proviene dal "De origine et situ Germanorum" di Tacito. Il significato della parola "decumates" è andato perduto ed è oggetto di contesa. Secondo lo storico britannico Michael Grant si riferiva probabilmente all'antico termine celtico indicante la suddivisione politica dell'area in "dieci cantoni", d'altra parte i Romani ridisegnavano
il territorio conquistato attraverso il sistema della centuriazione,
ossia la suddivisione del territorio in lotti atti ad essere lavorati
da cento famiglie di coloni, a loro volta suddivisi da decumani,
vie che delimitavano gli spazi ogni dieci famiglie. L'ager
centuriatus
veniva tracciato dall'agrimensore, che individuava l'umbilicus
agri,
cioè il punto in cui si sarebbero incrociati due assi stradali
perpendicolari tra loro: uno era generalmente in direzione est-ovest
ed aveva il nome di "decumano
massimo" (in latino, decumanus
maximus),
che collegava quindi le due porte dell'insediamento in direzione
est-ovest, la dextera
e la sinistra,
mentre il secondo
asse correva in direzione nord-sud ed era detto "cardo
massimo" (cardo
maximus),
per cui l'insediamento romano risultava così diviso in quattro
parti chiamate quartieri,
termine che in seguito ha assunto il significato di nucleo con
proprie caratteristiche storiche e geografiche all'interno di un
agglomerato urbano. Di regola, all'incrocio delle due direttrici
principali si trovava il forum,
ossia l'agorà,
la piazza principale della città. In particolare, per quanto
riguarda le fondazioni di insediamenti coloniali, il territorio era
suddiviso in appezzamenti in cui ciascun lotto costituiva il fondo
per cento famiglie di coloni (da cui il motivo del termine
"centuriazione"), delimitato da cardi
paralleli al cardo
maximus
e ogni dieci famiglie
da un decumanus
(variante di decimanus,
derivato di decĭmus,
"decimo"),
"la strada della decima parte", parallelo al decumanus
maximus.
Per ragioni pratiche, l'orientamento degli assi non sempre coincideva
con i quattro punti cardinali e a volte si basava sull'orientamento
di vie di comunicazione preesistenti (così per le centuriazioni
lungo la via Emilia) o su altre caratteristiche geomorfologiche.
Sembra quindi plausibile che "Agri
Decumates" si riferisse
a territori suddivisi in lotti assegnati a coloni coltivatori.
Decumanus maximus e cardo
maximus erano così denominati anche nell'ambito degli
accampamenti romani, detti castra, all'incrocio dei
quali non vi era il forum, bensì il cosiddetto praetorium,
ossia la tenda del comandante. Solitamente l'impostazione urbanistica
assegnata all'accampamento veniva conservata nella futura planimetria
del municipium o della civitas. Alcune tra le
principali città italiane (Torino, Pavia, Aosta, Napoli, Verona,
Potenza) ed europee (Vienna e York) sono esempi di accampamenti in
posizioni strategiche divenuti civitas.Secondo Tacito la regione era originariamente abitata dalla tribù celtica degli Elvezi ma ben presto, probabilmente sotto Ariovisto, vi si stabilirono i germanici Suebi (o Svevi), prima di emigrare, attorno al 9 a.C., nella moderna Boemia. L'area era stata colonizzata sotto la dinastia flavia (69-96) e la costruzione durante quel periodo di una rete di strade aveva facilitato la comunicazione tra le legioni e migliorato la protezione contro le tribù di invasori. Lungo il percorso passante per Rheinbrohl - Arnsburg - Inheiden - Schierenhof - Gunzenhausen - Pförring erano state costruite delle fortificazioni di frontiera (limes). I più importanti insediamenti romani erano Sumelocenna, Civitas Aurelia Aquensis, Lopodunum e Arae Flaviae, le odierne Rottenburg am Neckar, Baden-Baden, Ladenburg e Rottweil.
- Cesare Tito Elio Adriano Antonino Augusto Pio, nato come Tito Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino (Lanuvio, 19 settembre 86 - Lorium, 7 marzo 161), imperatore romano dal 138 al 161, visse in un momento cruciale della storia di Roma: l'apogeo dell'impero o nel cosiddetto secolo d'oro e gli imperatori che regnarono dopo di lui durante quel secolo, presero il nome da lui. La successione di Antonino ad Adriano si rivelò stabilita da tempo e priva di possibili colpi di mano: Antonino continuò a sostenere i candidati di Adriano ai vari pubblici uffici, cercando di venire incontro alle richieste del Senato, rispettandone i privilegi e sospendendo le condanne a morte pendenti sugli uomini accusati negli ultimi giorni di vita da Adriano. Uno dei primi atti
ufficiali di governo (acta) fu la divinizzazione del suo
predecessore, alla quale si oppose fieramente tutto il senato, che
non aveva dimenticato come Adriano avesse diminuito l'autorità
dell'assemblea e ne avesse mandato a morte alcuni membri. Alla fine
si giunse ad un compromesso: il senato non si sarebbe opposto alla divinizzazione del defunto imperatore se Antonino avesse abolito l'organo di governo dell'Italia formato da quattro giudici circoscrizionali, i consulares («consolari», cioè ex consoli), o legati Augusti pro praetore («delegati di Augusto con comando ‘propretorio’»), con funzioni giurisdizionali in Italia, funzioni che erano state appannaggio dell'ordine senatorio. Le controversie tra individui di rango sociale diverso e tra
comunità, in una regione fittamente abitata e urbanizzata come
l’Italia, con aree extra-urbane dense di proprietà rurali
produttive, dovevano essere frequenti, e spesso esulavano dalle
competenze dei magistrati di una singola città. Infatti negli anni
sessanta del II secolo d.C. appaiono attivi su ampi e variabili
distretti regionali d’Italia, degli iuridici («giudici»
o «consulenti giudiziari») di rango senatorio. Fu
anche per aver cercato un accordo con il senato
(l'imperatore, se avesse voluto, avrebbe potuto mettere a tacere le
polemiche facendo intervenire i soldati) che Antonino ricevette
l'inusuale titolo di Pio (pius),
col significato di detentore di un rapporto
favorevole con gli dèi. In questo periodo l'impero
ottenne il pieno consenso delle élite cittadine e delle province,
che beneficiavano ampiamente della Pax Romana. Adeguandosi alle usanze Antonino rifiutò il titolo di padre della patria (pater patriae), ma poi finì con l'accettarlo nel 139 insieme con un secondo consolato, seguito da un terzo e da un quarto (120 il primo, 139 e 140 il secondo e il terzo, 145 il quarto). Ligio alla religione e agli antichi riti, nel 148 celebrò solennemente il novecentesimo anniversario della fondazione di Roma. « Certi teologi dicono che il divino imperatore Antonino non era virtuoso; che era uno stoico testardo, il quale, non contento di comandare agli uomini, voleva anche essere stimato da loro; che attribuiva a se stesso il bene che faceva al genere umano; che in tutta la sua vita fu giusto, laborioso, benefico per vanità, e che non fece nient'altro che ingannare gli uomini con le sue virtù; e a questo punto esclamo: «Mio Dio, mandaci spesso di queste canaglie!» » (Estratto dalla voce Virtù del Dizionario Filosofico di Voltaire).
Nel 160 - Giunge all'apice, con Galeno, la scuola medica Romana.
 |
Marco Aurelio: Musei Capitolini di Roma. |
Nel 161 - Dopo la
morte per un malore del settantacinquenne
Antonino Pio, gli succede
Marco Aurelio (Roma, 26 aprile 121 - Sirmio, 17 marzo 180), il cui nome completo era, nelle iscrizioni: IMP(erator) • CAES(ar) • M(arcus) • AVREL(ius) • ANTONINVS • AVG(ustus), che è stato un imperatore, filosofo e scrittore romano. Su indicazione dell'imperatore Adriano, era stato adottato nel 138 dal futuro suocero e zio acquisito
Antonino Pio che lo aveva
nominato erede al trono imperiale. Nato come Marco Annio Catilio Severo, divenne Marco Annio Vero (Marcus Annius Verus), che era il nome di suo padre, al momento del matrimonio con sua cugina Faustina, figlia di Antonino, e assunse quindi il nome di Marco Aurelio Cesare, figlio dell'Augusto (Marcus Aurelius Caesar Augusti filius) durante l'impero di Antonino stesso. Marco Aurelio fu imperatore dal 161 sino alla morte, avvenuta per malattia nel 180 a Sirmio secondo il contemporaneo Tertulliano o presso Vindobona.
Fino al 169 mantenne la
coreggenza dell'impero assieme a Lucio Vero, suo fratello adottivo nonché suo genero, anch'egli adottato da Antonino Pio. Lucio Ceionio Commodo Vero (Roma, 15 dicembre 130 - presso Altino, gennaio 169) più noto semplicemente come Lucio Vero, fu un imperatore romano e governò insieme al fratello d'adozione Marco Aurelio dal 161 sino alla morte. Nell'investitura di
Marco Aurelio quale
nuovo imperatore,
Lucio Vero fu contestualmente scelto come
co-
imperatore, evento senza precedenti nell'Impero romano. Ufficialmente entrambi avevano lo stesso potere, ma in pratica Marco Aurelio esercitò la propria influenza sul collega. A Vero fu dato il controllo dell'esercito, a riprova della fiducia che correva fra i due. Per rafforzare tale alleanza, Marco Aurelio dette in moglie sua figlia Annia Aurelia Galeria Lucilla a Vero che da lei ebbe tre figli. Anche se non sembra mostrare affetto personale per Adriano nei Colloqui con se stesso, Marco lo rispettò molto e presumibilmente ritenne suo dovere metterne in atto i suoi piani di successione. E così, anche se il Senato voleva confermare solo lui, egli rifiutò di entrare in carica senza che Lucio ricevesse gli stessi onori. Alla fine il senato fu costretto ad accettare e nominò Augusto, Lucio Vero. Marco divenne, nella titolatura ufficiale, Imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto, mentre Lucio, rinunciando al suo
cognomen di Commodo, ma assumendo il nome di famiglia di Marco, Vero, divenne Imperatore Cesare Lucio Aurelio Vero Augusto. Questa era la
prima volta che
Roma veniva
governata da
due imperatori contemporaneamente. Fin dalla sua ascesa al principato, Marco ottenne dal
Senato che Lucio Vero gli fosse associato su un piano di parità (
diarchia), con gli stessi titoli, ad eccezione del pontificato massimo che non si poteva condividere. La formula era innovativa: per la prima volta alla testa dell'impero vi era una
collegialità e una parità totale tra i due
principes. In teoria i due fratelli, entrambi insigniti del titolo di
Augustus, ebbero gli stessi poteri ma in realtà Marco conservò una preminenza che Vero mai contestò. A dispetto della loro uguaglianza nominale Marco Aurelio ebbe maggior
auctoritas (autorità) di Lucio Vero. Fu console una volta di più di Lucio, avendo condiviso l'amministrazione già con Antonino Pio e solo Marco divenne
Pontifex Maximus e questo fu chiaro a tutti. L'imperatore più anziano deteneva un comando superiore al fratello più giovane: "Vero obbedì a Marco... come il tenente obbedisce a un proconsole o un governatore obbedisce all'imperatore".
- Dal 161 l'Impero romano, ormai in pace da lungo tempo subisce una serie di
attacchi contemporanei lungo molti dei suoi fronti. I Pitti nella Scozia premevano contro
il vallo di Antonino, la Spagna subiva le continue scorrerie dei
pirati mauri mentre in Germania, tra l’alto Danubio ed il Reno, i
Catti e i Cauci penetravano oltre le frontiere e lungo le coste,
invadendo la Gallia Belgica e gli Agri Decumates. Inoltre il nuovo sovrano partico Vologese III,
divenuto re nel 148, occupava l’Armenia, ponendo sul suo trono il
fratello Pacoro, per poi invadere la vicina provincia romana di Siria
nel 161. Nell'Europa centro-orientale il mondo
barbaro era scosso da forti agitazioni interne e da movimenti
migratori tra le sue popolazioni che tendevano a modificare gli
equilibri con il vicino mondo romano. Vandali, Burgundi, Alemanni, Longobardi, Angli, Sassoni, Juti, Franchi e altre tribù ancora attaccheranno i romani già nello stesso II sec.
Per eventuali approfondimenti vedi "Storia dell'Europa n.30: dal 90 al 161 e.v. (d.C.)"
QUI.
 |
Carta del 178-179 durante le
guerre Marcomanniche. |
Nel 166 - Con Marco Aurelio imperatore (dal 161 al 180), si diffonde dal
confine persiano, dove si combattono i Parti, un'
epidemia di
peste.
Dal 167 - Le
guerre marcomanniche, o
guerre marcomanne, come sono state definite nella "Historia Augusta",
costituiscono un lungo periodo di conflitti militari combattuti
dall'esercito romano contro le popolazioni germano-sarmatiche
dell'Europa continentale (dal 167 al 189 circa). I
Marcomanni (uomini della
marca) erano
Suebi che, valicato il Meno, avevano preso possesso del
paese fra il Reno e il Danubio superiore, sgombrato dagli Elvezi, che
divenne così una marca di confine sueba. Loro alleati
contro i Romani erano i
Quadi, d'
origine suebica, che avevano
strappato la Moravia ai Volcae Tectosages, stirpe gallica. Le
guerre marcomanniche rappresentano un evento storico di
fondamentale importanza poiché rappresentarono
il preludio alle
grandi
invasioni barbariche del III-IV-V secolo. All'interno e ai margini della massa
germanica si erano verificati movimenti e mescolanze di popoli, tanto
da portare a trasformazioni di natura politica, con l'avvento di un
fenomeno nuovo tra
i Germani: interi popoli (come Marcomanni,
Quadi e Naristi, Vandali, Cotini, Iazigi, Buri ecc.), sotto la
pressione dei Germani orientali, su tutti i
Goti, furono
costretti a ristrutturarsi e ad organizzarsi in sistemi sociali più
robusti e permanenti, ovvero
si raggrupparono in
coalizioni
("confederazioni") di natura più che altro
militare, con la conseguenza che il
limes renano-danubiano finì
per essere sottoposto a una maggiore pressione. Tale trasformazione
fu anche, se non soprattutto, indotta dalla vicinanza e dal confronto
con la civiltà imperiale romana, le sue ricchezze, la sua lingua, le
sue armi, la sua organizzazione. Fatto sta che alle
tribù
germaniche guerriere con
capi eletti democraticamente tipiche dei
secoli precedenti
subentrarono coalizioni (come quella degli
Alemanni, dei Franchi, etc.)
rette da
aristocrazie guerriere,
prefigurazione della futura nobiltà feudale. Alla fine la pressione
violenta di altri popoli migranti (Goti, Vandali, Sarmati) finì per
costringere queste
confederazioni di popoli confinanti con
l'Impero Romano, che di fronte a loro non disponevano di ampi spazi
su cui trasferirsi, a decidere di dare l'
assalto direttamente alle
province renano-
danubiane. Nel
168, la pace che era stata concordata l'anno prima con i barbari non
lasciava però tranquillo Marco Aurelio, che decise di recarsi di
persona (insieme al fratello Lucio Vero) lungo il
limes pannonico
per controllare quali fossero le reali intenzioni dei barbari. Nel corso di questi primi anni di guerra Marco
potrebbe aver iniziato a scrivere i “Colloqui con se stesso”,
unica opera pervenutaci dell'"
imperatore filosofo", opera che pur non raccontando in modo evidente le guerre di questi
anni, comunica al lettore tutto il disagio di
Marco Aurelio
uomo, in relazione a quegli eventi infausti.
Nel 169 - Agli inizi dell'anno, il
co-
imperatore Lucio Vero è colpito
da infarto e
muore a soli due giorni di viaggio da Aquileia, lungo la strada
che conduceva da Concordia Sagittaria ad Altino mentre i due imperatori
avevano deciso di far ritorno a Roma, dietro le insistenti pressioni
del fratello Lucio. Marco Aurelio dovette così tornare a Roma per le esequie del fratello. Il
grosso dell'esercito, anche in mancanza dei due imperatori, potrebbe
essersi andato a concentrare lungo i confini della piana del Tisza, poiché Marco avrebbe voluto punire i
Sàrmati per aver compiuto, l'anno precedente,
un'incursione nella provincia della Dacia, ora che aveva concluso dei trattati di pace con le popolazioni suebe (Quadi, Marcomanni e
Naristi) che gravitavano lungo i confini del medio Danubio. Il
conflitto sarmatico si rivelerà molto
difficile per i Romani. All'inizio del
170 era annunciata la
profectio
dell'Imperatore, un cerimoniale religioso che celebrava
la partenza dell'Imperatore romano in vista di una nuova campagna
militare e mentre
Marco Aurelio giungeva lungo il
limes pannonicus e
lanciava
una nuova e
massiccia offensiva al di là del Danubio
contro i Sàrmati
Iazigi (chiamata
expeditio
sarmatica), una grossa
coalizione di
tribù germaniche,
capeggiata da Ballomar, re dei Marcomanni,
sfondava il
limes
pannonico e batteva un esercito di 20.000 armati lungo la cosiddetta via dell'Ambra,
forse nei pressi di Carnuntum (in Austria). I
Romani
ottennero comunque determinanti
vittorie, sia sui
Sàrmati che
sui Germani, ma capirono che i Suebi (o Svevi)
Marcomanni e
Quadi
ormai costituivano il
principale avversario da tenere sotto controllo.
Dal 170 - La tribù germanica dei Vandali (Wandili), dopo una prima migrazione dalla Scandinavia nei territori
dell'attuale Polonia (tra i bacini dell'Oder e della Vistola)
intorno al 400 a.C., sotto la pressione di altre tribù germaniche si spostano più a sud, dove combattono e sottomettono la
popolazione celtica dei Boi (stanziati in quella regione che da loro ha preso il nome di Boemia) circa nel 170. Il termine "Vandali"
potrebbe essere un'erronea citazione dei "Victohali",
visto che secondo Eutropio (che aveva 40 anni nel 363/387) la Dacia era in quel periodo abitata da Taifali, Victohali e dai Goti Tervingi. Le popolazioni vandaliche di Asdingi,
Silingi e Lacringi, al tempo della guerre marcomanniche (anni 171-175)
si stabilirono a sud dell'arco carpatico. Nel II secolo d.C., all'interno e ai
margini della massa germanica si erano verificati movimenti e
mescolanze di popoli, tanto da portare a trasformazioni di natura
politica: intere popolazioni (come Marcomanni, Quadi, Naristi,
Cotini, Iazigi, Buri ecc.), sotto la pressione dei Germani
orientali (su tutti i Goti), furono costrette a riorganizzarsi in
sistemi sociali più evoluti e permanenti, ovvero si raggrupparono
in coalizioni (confederazioni) di natura soprattutto
militare, con la conseguenza che il limes renano-danubiano
finì per essere sottoposto ad una costante e maggiore pressione.
Tale trasformazione fu anche indotta dalla vicinanza e dal
confronto con la civiltà imperiale romana, le sue ricchezze, la
sua lingua, le sue armi, la sua organizzazione. Alla fine la violenta
pressione di altri popoli migranti (Goti, Vandali e Sarmati) finì
per costringere queste confederazioni di popoli confinanti con
l'Impero Romano, che di fronte a loro non disponevano di ampi spazi
su cui trasferirsi, a decidere di dare l'assalto direttamente
alle province renano-danubiane. E fu così che anche gli
stessi Vandali, parteciparono a questa iniziale fase di
sfondamento delle frontiere romane. La popolazione vandala era, a sua
volta, divisa fra tre principali etnie: Asdingi (dal nome della
casata principale), Silingi e Lacringi. La prima testimonianza
storica di un loro scontro con l'Impero romano avvenne, quindi,
secondo quanto riferiscono Cassio Dione Cocceiano e la "Historia
Augusta", durante il periodo delle cosiddette guerre marcomanniche
(dal 166/167 al 188/189), al tempo degli imperatori Marco
Aurelio, Lucio Vero e Commodo. Sappiamo infatti da Cassio Dione in "Storia romana", LXXII, 12, che il "ramo"
dei Vandali Asdingi mosse verso sud-est, guidato dai loro re Raus e
Raptus e che alla fine stipularono un trattato di alleanza con i
Romani, stanziandosi a nord-est della Dacia, nel bacino dei Carpazi. La sconfitta segnò una svolta
nella storia dei Vandali che dovettero così fornire armati
all'Impero Romano in qualità di alleati, anche dopo la morte
di Marco Aurelio nel 180.
 |
| La Germania nel II - III secolo. |
- I Sàrmati, distinti in Iazigi, Roxolani (o Rossolani), Aorsi e Alani, come altre popolazioni barbariche, a partire dal II-III secolo ottennero di stabilirsi nel territorio dell'Impero e in cambio dovettero fornire soldati all'esercito romano. Già Marco Aurelio aveva impiegato un contingente di questi ottimi cavalieri in Britannia. Le tribù Slave orientali ridussero fortemente i loro rapporti commerciali con Roma, preferendo quelli con le tribù sarmatiche o altre tribù slave e parteciparono alle guerre anti-schiavistiche contro Roma, unendo parte delle loro forze a quelle dei Marcomanni, nella seconda metà del II secolo, mentre alla fine del secolo, le terre degli Slavi occidentali (i Venedi-Sclavini) furono attraversate dai Goti, con cui in parte si fusero.
 |
Commodo rappresentato
con gli attributi di |
Nel 180 - In marzo, quando la nuova stagione di guerra stava per cominciare, Marco Aurelio cade gravemente ammalato e muore non lontano da Sirmio (il 17 marzo 180), come ci informa il contemporaneo Tertulliano nel suo "Apologeticum". Poco prima di morire, la "Historia Augusta" riferisce che chiese al figlio Commodo di «non trascurare il compimento delle ultime operazioni di guerra». Commodo, figlio di Marco Aurelio, gli succede alla guida dell'impero: viene così ripristinata la successione ereditaria. Cesare Lucio Marco Aurelio Commodo Antonino Augusto, nato Lucio Elio Aurelio Commodo (Lanuvium, 31 agosto 161 - Roma, 31 dicembre 192), è stato un imperatore romano, membro della dinastia degli Antonini; regnò dal 180 al 192. Così come Caligola e Nerone, è descritto dagli storici come stravagante e depravato.Figlio dell'imperatore filosofo Marco Aurelio, Commodo fu associato al trono nel 177, succedendo al padre nel 180. Avverso al Senato e da questi odiato, governò in maniera autoritaria, esibendosi anche come gladiatore e in prove di forza, facendosi soprannominare l'"Ercole romano". Amato dal popolo e appoggiato dall'esercito, al quale aveva elargito consistenti somme di denaro, riuscì a mantenere il potere tra numerose congiure fino a quando venne assassinato nel 192.
Commodo contro gli Iazigi (180-182/3) - L'offensiva da parte di Commodo in terra sàrmata continuò. Neppure la morte dell'imperatore ritardò la progettata spedizione nella piana del Tisza. I Sàrmati Iazigi (nuova expeditio sarmatica), i suebi Buri ("expeditio Burica"), i germani Vandali ed i Daci liberi, furono battuti più volte negli anni successivi. Commodo, che aveva deciso di abbandonare il teatro delle operazioni militari nell'ottobre del 180, contro il parere del cognato Claudio Pompeiano, lasciò che fossero i suoi generali (come Pescennio Nigro, Clodio Albino, il figlio di Tigidio Perenne e Valerio Massimiano per citarne alcuni) a portare a termine le operazioni di guerra. E così nel 180 al termine della prima campagna militare, dopo la scomparsa del padre Marco Aurelio: « Commodo concesse la pace ai Buri, una volta che inviarono i loro emissari. In precedenza si era rifiutato di farlo, a dispetto delle loro frequenti richieste, perché erano [ancora troppo] forti, e perché non era la pace che volevano, ma la garanzia di una tregua per consentire loro di fare ulteriori preparativi [di guerra], ma ora che erano esausti, decise di fare la pace con loro, ricevendo ostaggi e la restituzione di numerosi prigionieri dagli stessi Buri e 15.000 dagli altri [popoli vicini], costringendoli poi a giurare che non avrebbero mai più abitato o utilizzato per il pascolo la striscia di territorio distante fino a cinque miglia dalla vicina Dacia. Contemporaneamente il governatore Sabiniano dissuase 12.000 Daci dal loro scopo [di attaccare la provincia] che, cacciati dai loro territori erano sul punto di aiutare gli altri [popoli], promettendo che avrebbe dato loro alcuni territori nella provincia della Dacia. » (Cassio Dione Cocceiano, Storia romana, LXXIII, 3). Commodo dispose infine, prima di rientrare a Roma, di abbandonare i territori della Marcomannia, certamente per meglio fronteggiare i vicini Iazigi, poiché le economie di forze degli eserciti romani messi in campo, non permettevano nuovi arruolamenti ed ulteriori dispiegamenti di truppe. Del resto potrebbe essersi reso conto che mantenere territori a nord del Danubio, avrebbe certamente causato dei danni economici all'economia dell'impero, come se n'era accorto in passato lo stesso Augusto, quando decise di abbandonare definitivamente i territori della Germania Magna dopo la disfatta di Teutoburgo del 9 d.C.. Commodo aveva intuito che si trattasse di territori ricoperti da foreste ed acquitrini, ragione più che valida per abbandonare quei territori di Marcomanni e Quadi. Ciò non significava che Marcomanni e Quadi fossero liberi di agire senza il consenso di Roma. In realtà queste popolazioni, insieme a Naristi e Cotini, costituivano una forma di "catena clientelare" posta a protezione dei confini danubiani. L'obbiettivo strategico finale di sottomettere al volere di Roma tutti i territori a nord del Danubio, rimase incompiuto, anche se molte di queste popolazioni mantennero fede ai patti di amicizia ed alleanza con il popolo romano per un trentennio, fino all'invasione degli Alemanni del 213. Per queste vittorie Commodo ricevette una quarta ed una quinta acclamazione imperiale oltre al titolo onorifico di Germanicus et Sarmaticus Maximus e, probabilmente, decise l'inizio dei lavori della famosa Colonna di piazza Colonna a Roma per onorare il padre appena scomparso. Ed i lavori terminarono dopo una decina d'anni, poco prima della sua morte.
Tertia expeditio germanica (189?) - La "Historia Augusta" riferisce, infine, di una terza spedizione germanica (189?) a cui però Commodo non prese parte, come sembra dimostrare la monetazione del periodo. Quadi e Marcomanni potrebbero essersi ribellati nuovamente, ma il pronto intervento dei governatori provinciali delle due Pannonie riuscì a sedare ogni possibile focolaio di rivolta. E Commodo, rimasto a Roma a godersi i giochi gladiatorii, potrebbe essersi accontentato della ottava acclamazione ad Imperator.
Nel 192 -
L'imperatore Commodo è assassinato. Amato dal popolo e appoggiato dall'esercito, al quale
aveva elargito consistenti somme di denaro, riuscì a mantenere il
potere tra numerose congiure fino a quando venne assassinato in un
complotto ad opera di alcuni senatori, pretoriani e della sua amante
Marcia, finendo strangolato dal suo maestro di lotta, l'ex gladiatore
Narcisso, cospirazione che portò al potere Pertinace. Sottoposto a
damnatio memoriae dal senato, venne riabilitato e divinizzato
dall'imperatore Settimio Severo, che voleva ricollegarsi alla
dinastia antoniniana cercando il favore dei membri superstiti della
famiglia di Commodo e Marco Aurelio. Con la fine
della dinastia degli Antonini, nell'Impero romano si conclude
un periodo universalmente riconosciuto come prospero e ricco. Nei
primi due secoli dell'Impero la contrapposizione tra autorità
politica e potere militare si era mantenuta, anche se pericolosamente
(al prezzo di guerre civili), all'interno di un certo equilibrio,
garantito anche dalle enormi ricchezze che affluivano allo Stato e ai
privati tramite le campagne di conquista. L'economia dell'impero
romano nei primi due secoli si era basata sulla conquista militare
di nuovi territori e sullo sfruttamento delle campagne da
parte di schiavi, perlopiù prigionieri di guerra. L'acquisto di
enormi quantità di prodotti di lusso provenienti dalle regioni
asiatiche era stato regolato con monete, soprattutto d'argento
(monete romane sono state trovate anche in regioni molto lontane),
tanto che la continua fuoriuscita di metallo prezioso (non
bilanciata dalla produzione delle miniere, visto che i
giacimenti erano ormai in esaurimento dopo secoli di sfruttamento)
finì per determinare nel Tardo Impero una rarefazione dell'oro e
dell'argento all'interno dei confini imperiali. La suddivisione
della società nelle tre classi tradizionali: senatori, cavalieri (grandi proprietari terrieri e militari, che
disponevano della proprietà terriera e di riserve di monete
d'oro; classe o ordine costituita da Gaio Sempronio Gracco che poteva accedere alla magistratura di giudice) e dei plebei, cambierà il proprio assetto con la
crisi del III secolo, che seminerà i germi del Medioevo. Durante il secolo
d'oro del Principato adottivo, il mondo romano aveva abbracciato le
idee principali della filosofia greca, non seguendo una particolare
corrente, ma secondo l'eclettismo, ovvero raccogliendo all'interno di
essa alcune idee principali. Il disprezzo per le ricchezze e la
gloria mondana resero lo stoicismo una filosofia adottata
sia da imperatori (come Marco Aurelio, autore dei "Colloqui con se
stesso") che da schiavi, come il liberto Epitteto. Cleante, Crisippo,
Seneca, Catone, Anneo Cornuto e Persio furono importanti personalità
della scuola stoica, alla quale si ispirò anche Cicerone. A partire
dall'introduzione dello stoicismo a Roma da parte di Panezio di
Rodi (185 a.C. - 109 a.C.), ha avuto inizio il periodo dello Stoicismo medio, che si differenzia dal
precedente per il suo carattere eclettico, in quanto influenzato sia
dal platonismo che dall'aristotelismo e
dall'epicureismo. Queste concezioni
eclettiche vedevano l'uomo al centro dell'universo secondo
l'ideale della humanitas classica e secondo l'idea romana dell'homo
faber, per cui ognuno è l'artefice del proprio destino e non
ci sono dèi o fato che possano intervenire. Conseguentemente ci si
interrogava sul ruolo degli Dèi negli affari umani e si metteva in dubbio la loro stessa esistenza. La crisi della
religione romana, intesa come politeismo greco-romano, stava
intensificato i propri effetti nell'età imperiale, anche se questo
politeismo non pretendeva che gli abitanti dell'Impero fossero
obbligati a venerare esclusivamente il pantheon degli dèi romani.
Fin dai tempi di Giulio Cesare e dei suoi rapporti coi culti druidici
dei Galli, l'amministrazione
romana era tollerante in campo religioso, per cui
accoglieva culti provinciali e stranieri. Unica condizione era
che non mettessero in pericolo l'unità imperiale. E così,
soprattutto da Oriente, si riversarono sull'Occidente romano e
quindi su Roma, una notevole quantità di culti misterici,
quali quelli di Cibele (la "Grande Madre" dalla Frigia),
Baal (da Emesa, a cui fu devoto lo stesso imperatore Eliogabalo),
Iside e Osiride (dall'Egitto), Mitra (dalla Persia), che
raccolse numerosi seguaci fra i militari e nel quale si
ravvisava il Sol invictus, l'invitto dio della luce a cui furono devoti gli imperatori Aureliano, Diocleziano e Costantino I.
 |
| Settimio Severo |
Dal 193 - Con la
scomparsa di
Commodo, ucciso da una congiura, si apre un periodo di instabilità politica caratterizzata da una
guerra civile durata
cinque anni, dal 193 al 197, con
scontri tra
legioni acquartierate in diverse regioni dell'Impero, ciascuna delle quali sostiene il
proprio generale come
nuovo imperatore. Ha la meglio
Settimio Severo, originario della Tripolitania, in Africa, governatore della Pannonia. L'ascesa di
Settimio Severo costituisce
uno spartiacque nella storia romana; è considerato infatti
l'iniziatore della nozione di "dominato" in cui
l'imperatore non è più un privato gestore dell'impero per conto del
Senato, come durante il principato, ma è unico e vero dominus,
che trae forza dall'investitura militare delle legioni
(anche se anticipazioni di questa tendenza si erano avute durante la
guerra civile seguita alla morte di Nerone e con Traiano). Fu
iniziatore di un nuovo culto che si incentrava sulla figura
dell'imperatore, ponendo le basi per una sorta di "monarchia
sacra" mutuata dall'Egitto e dall'oriente ellenistico di
Alessandro Magno. Fu così che Settimio Severo adottò il titolo di
Dominus ac Deus, (Signore e Dio) al posto di quello di
princeps (Augusto definiva il princeps come il primo
degli uguali, cioè i senatori), e regolò i meccanismi di
successione assegnandosi il titolo di Augustus ed
usando quello di Caesar per il suo successore
designato. Sua moglie Giulia Domna, di origine siriaca, promosse attivamente l'arrivo a Roma di culti monoteistici solari, che sottolineavano l'
analogia tra ordine imperiale e
ordine cosmico. Settimio Severo pose le basi per il successivo
sistema autocratico fondato sugli
imperatori militari,
creando la prima forma di
autocrazia militare,
togliendo potere al
Senato. Si racconta infatti che,
poiché aveva preso il potere con l'aiuto dei militari, ricambiò
l'ostilità senatoria ordinando l'
esecuzione di
29 senatori, accusati di corruzione e
cospirazione contro di lui e sostituendoli con suoi favoriti,
soprattutto africani e siriani. Inoltre attribuì e ampliò i poteri
degli ufficiali dell'esercito investendoli anche di cariche pubbliche
che erano solitamente appannaggio del senato. Appena giunto a
Roma avviò l'
epurazione della
guardia pretoriana, che dopo essere stata per due secoli reclutata in Italia e in piccola parte nelle province più romanizzate,
fu smantellata e riorganizzata con quadri e organici a lui fedeli,
tratti dal contingente danubiano. Da allora in poi l'accesso alla
Guardia Pretoriana, un tempo avente un prerequisito geografico e
culturale, sarebbe stata appannaggio dei soldati più battaglieri,
quelli dell'Illirico nel III secolo. Insediò
una
legione ad
Albano Laziale, a dispetto della tradizione che
voleva l'Italia libera dagli eserciti e utilizzò i
proventi della vendita delle terre confiscate agli avversari politici
per creare una cassa imperiale privata, il
fiscus. Il
fiscus era distinto dall'
aerarium, la cassa dello
Stato che doveva coprire i costi della complessa e articolata macchina
burocratica e amministrativa dell'Impero. Diede impulso agli studi di
diritto e nominò il più importante giurista del tempo, Papiniano,
Praefectus urbi, con poteri di polizia e repressione criminale
su Roma. Il nuovo ordine
promosso da Settimio Severo si scontrò presto con i problemi
derivanti dallo scoppio di nuove guerre. Già l'imperatore Caracalla
dovendo guerreggiare contro i Parti a oriente e i Marcomanni lungo
il confine renano-danubiano, aveva notevolmente gravato sulle finanze
statali con l'
arruolamento sempre più massiccio
di mercenari
germani nell'esercito e la
diminuzione del
metallo prezioso nelle
monete, che causò
inflazione. Le campagne
militari contro i Parti combattute dagli Imperatori erano dettate da
esigenze strategiche di controllo dell'area ma anche da esigenze
politiche, per perpetuare l'affermazione di un sacro primato del potere imperiale romano su un insieme di popoli, sulla scia di Alessandro il Grande. Settimio Severo divenne generale romano ma
proveniva da una
famiglia di
re-
sacerdoti di Emesa, città santa e capitale del
culto del Dio solare "El-Gabal", il "
Sol invictus" dei
Romani e sentiva molto la sua "sacra missione".
 |
Carta dell'Impero Romano e delle
sue province nel 210. L'Italia è
suddivisa in regioni dal 6, da QUI. |
Saccheggiata Ctesifonte, capitale dei
Parti, Settimio Severo tornò a Roma, portando con sé la Legio II
Parthica, la seconda delle tre legioni che aveva formato in Siria (Legio I Parthica, Legio II Parthica e Legio III Parthica,
fedeli a lui e al dio solare El-Gabal). La dinastia dei
Severi portò questo il culto del "Sol invictus"dall'Oriente a Roma e, seppur si
trattasse dell'Imperatore che aveva vinto una guerra civile e
sconfitto i Persiani emulando Alessandro Magno, dovette trovare delle resistenze. Prevedendole e per consolidare il proprio
potere, Settimio Severo fece risiedere la II Legio Parthica nei Castra Albana, sui Colli Albani. Da Roma il
culto del Dio adorato dall'Imperatore e dai suoi soldati ebbe modo di
diffondersi, specialmente nei
ranghi dell'
esercito, al comando
del quale venivano scelti adoratori del Dio Solare, il cui vicario e sacerdote era
l'Imperatore stesso. Non tutte le legioni si convertirono al nuovo
culto e la discriminazione nella scelta dei comandi volta a
escludere i non devoti alla divinità orientale, dovette alienare le simpatie di quest'ultimi al giovane e ultimo discendente di Settimio Severo,
Severo
Alessandro,
assassinato dal suo successore
Massimino il Trace nel
235 d.C.,
anno in cui inizia l'
anarchia militare, la
ribellione al
culto solare.
Per eventuali approfondimenti vedi "Storia dell'Europa n.31: dal 161 al 193 e.v. (d.C.)"
QUI.
 |
| Caracalla |
Nel 211 - A Settimio Severo succede come
imperatore romano il figlio
Caracalla (imperatore dal 211 al 217), nato a Lugdunum (Lione), in Gallia, il
4 aprile 188, da Settimio Severo e
Giulia Domna, Augusta e detentrice di un
potere mai raggiunto da una
donna romana. Il suo vero
nome era Lucio Settimio Bassiano ma il padre Settimio Severo l'aveva
fatto cambiare in Marco Aurelio Antonino per suggerire una parentela
col vecchio imperatore Marco Aurelio. Fu in seguito soprannominato
"Caracalla" dal nome della tunica con
cappuccio di origine gallica che spesso indossava e che fece conoscere ai
Romani. Aveva un fratello, Publio Settimo Geta.
Nel 212 - Dopo circa quarant'anni, i Catti germanici tornano a sfondare il limes romano e per la prima volta sono menzionati gli Alemanni, una confederazione di tribù di Suebi (chiamati Svevi nel medioevo) nella regione del Wetterau (in Assia), dinanzi al limes. Era dai tempi di Marco Aurelio, durante le Guerre marcomanniche (166/167-188) che le tribù germaniche non esercitavano una pressione così forte lungo i confini settentrionali dell'Impero romano. Le invasioni barbariche del III secolo (212/213-305), secondo tradizione, ebbero inizio con la prima incursione condotta della confederazione dei Suebi Alemanni (o Alamanni) nel 212/13, sotto l'imperatore Caracalla, inaugurando un periodo ininterrotto di scorrerie all'interno dei confini dell'impero romano per fini di saccheggio e bottino, da genti armate appartenenti alle popolazioni che gravitavano lungo le frontiere settentrionali: Pitti, Caledoni e Sassoni in Britannia; le tribù germaniche di Frisi, Sassoni, Franchi, Alemanni, Burgundi, Marcomanni, Quadi, Lugi, Vandali Iutungi e Goti (Tervingi, Grutungi e Gepidi); le tribù daciche dei Carpi e quelle sarmatiche di Iazigi, Roxolani ed Alani, oltre a Bastarni, Sciti, Borani ed Eruli dai fiumi Reno e Danubio fino al Mar Nero.
Nel 212/213 - Caracalla promulga la "Constitutio Antoniniana", con la quale
estende la cittadinanza romana a tutti gli individui liberi
dell'impero, un atto di difficile interpretazione, anche perché non
ci è giunto il suo testo originale. L'Editto, pur con tutti i suoi
limiti, presentava dei caratteri altamente innovativi, destinati ad
avere una profonda ripercussione sui futuri assetti sociali ed
economici dell'Impero. Il provvedimento ebbe infatti riflessi
nell'economia erariale, perché estendeva il sistema fiscale ai nuovi
cittadini e aumentava la decentralizzazione del potere: il fulcro
ormai si spostava da Roma e dalle province di tradizionale
appannaggio senatorio a quelle più decentrate, dove maggiore era
la presenza degli eserciti. A partire dagli anni 213-214, si ebbero nuove incursioni in Dacia e in Pannonia inferiore, lungo il tratto danubiano attorno ad Aquincum, da parte dei Vandali. L'Imperatore Caracalla, costretto ad intervenire di persona, riuscì a chiedere aiuto agli alleati Marcomanni, opponendoli ai vicini Vandali che si stavano dimostrando da qualche tempo particolarmente ostili.
Nel 217 - Macrino, prefetto del pretorio, elimina Caracalla e si autoproclama imperatore. Il suo regno durò solo quattordici mesi. Il prefetto del pretorio era secondo in comando all'imperatore e responsabile per le uniche forze militari presenti nella città di Roma: la guardia del corpo dell'imperatore, ovvero i pretoriani. Questa era la massima carica che un personaggio dell'ordine equestre potesse raggiungere a quei tempi: naturalmente i membri dell'ordine equestre non facevano parte dell'aristocrazia. Macrino fu spodestato da Eliogabalo, autore di una discussa riforma religiosa e assassinato da una guardia pretoriana nel 222. Gli successe il cugino Severo Alessandro, ucciso nel 235 da una rivolta dei soldati lungo il confine renano. Si assisteva quindi a una sempre più chiara tendenza di dominio dell'esercito nel processo di scelta e acclamazione dell'imperatore. I cambiamenti nelle istituzioni, nella società, nella vita economica e, di conseguenza anche nel modo di pensare e nella religione furono così profondi e fondamentali, che la "crisi del III secolo" è sempre più vista come lo spartiacque che contrassegna la differenza fra il mondo classico e quello della tarda antichità, che già porta in sé i germi del Medioevo. Durante i circa 50 anni della crisi, più di una ventina di imperatori si succedettero sul trono, regnando a volte contemporaneamente su parti diverse del territorio. Si trattava in genere di comandanti militari che venivano proclamati imperatori dalle proprie legioni e riuscivano a mantenere il potere per una media di due o tre anni, prima di essere a loro volta assassinati dal loro successore. La crisi si arrestò solo con una serie di imperatori che provenivano dai ranghi militari e dalla provincia della Dalmazia, che grazie alla loro abilità militare riuscirono a riunificare l'Impero e a difenderne efficacemente i confini. La drastica riforma imposta da Diocleziano nel 284, permise la prosecuzione dell'Impero per quasi altri due secoli come "tardo impero romano".
- Tra il II e il III secolo d.C. la castrazione per motivi religiosi aumenta, specie sotto gli imperatori di origine siriaca che privilegiavano il culto della dea Cibele al punto che lo stesso Eliogabalo (imperatore romano appartenente alla dinastia dei Severi dal 218 al 222) si evirò per diventare sacerdote della dea.
- Particolarmente rilevante è la
presenza degli eunuchi alla corte dell'imperatore che
affida loro non solo la custodia delle sue donne, com'era
nella tradizione orientale, ma anche compiti di particolare fiducia.
Questa particolare posizione dell'eunuco nella società romana, per
cui per un verso rientra nella figura dello schiavo ma per un altro
assume le funzioni di un importante personaggio della vita
pubblica dipende da quella che l'antropologo Claude Meillassoux
ha definito come la desessualizzazione dello schiavo. Agli schiavi
nel mondo romano, considerati pure e semplici "cose" come
fossero una merce, era proibita la parentela. Moses Israel Finley
definisce gli schiavi come dei "senza-famiglia" poiché non
possono contrarre matrimonio legittimo e gli eventuali figli
divengono proprietà del dominus che potrà farne ciò che
vuole: tenerli o venderli. «Gli schiavi privi di importanza sociale
non hanno né mogli né figli perché i loro amori e la loro
procreazione sono come quelli delle bestie di un gregge: il padrone
si rallegrerà nel vedere il gregge che si accresce: tutto qui».
Questo processo di disumanizzazione culmina con la castrazione con
cui viene esclusa per lo schiavo divenuto eunuco ogni possibilità di
procreare.
Nel 222 - Marco Aurelio Severo Alessandro Augusto
(Arca Caesarea, 1º ottobre 208 - Mogontiacum, 18 o 19 marzo 235),
nato come Marco Bassiano Alessiano (Marcus Bassianus Alexianus) ma
meglio noto semplicemente come
Alessandro Severo
(Alexander Severus), è nominato
imperatore romano, l'ultimo della
dinastia dei Severi, che regnerà dal 222 al 235, anno della sua
morte. Adottato dal cugino e imperatore Eliogabalo, dopo il suo
assassinio Alessandro salì al trono. Data la sua giovane età (fu
imperatore a tredici anni), il potere fu effettivamente esercitato
dalle donne della sua famiglia, la nonna Giulia Mesa e la madre
Giulia Mamea. Passato alla storia come esempio di
buon
imperatore, rispettò le prerogative del Senato e si prese
cura dei sudditi, non aumentò il carico fiscale e favorì il
sincretismo religioso, infatti nel suo larario trovò posto anche una
statua di Gesù Cristo, insieme a quella di Abramo. Come Antonino
Pio, di
carattere fu
mite e
buono, ebbe
nobili
inclinazioni. Anche quando giudicò su colpe gravissime, non
inflisse la pena di morte. L'imperatore
non fu però
all'
altezza dei
problemi militari che dovette
affrontare. Nel 229 la dinastia dei Sasanidi incominciò un'offensiva
che strappò ai Romani la Cappadocia e la Mesopotamia, fino a
minacciare la Siria. Severo riuscì ad arginare l'invasione, ma
dovette rapidamente trasferirsi sul fronte del Reno per difendere la
Gallia dall'aggressione dei Germani. Nel 235 fu assassinato dai suoi
stessi soldati durante una campagna contro le tribù germaniche, in
quanto stava trattando un accordo col nemico ed essi trovavano troppo
esitante la sua condotta in guerra.
 |
| I Goti nel 230. |
Nel 230 - I
Goti arrivano a
contatto con il mondo romano nella zona che va dalla foce del Danubio al Regno del Bosforo Cimmerio, regno ellenistico
situato nelle penisole di Crimea e di Taman'. I
Goti
(in latino
Gothones) erano una federazione di
tribù
germaniche orientali, secondo le loro stesse tradizioni
originari
dell'isola di Gotland e della regione di Götaland in
Svezia, che
a ondate erano sbarcati sulle coste del Mar Baltico e da qui si erano spinti a sud sottomettendo le popolazioni che avevano trovato sul loro
percorso. Due tribù strettamente apparentate, i Gutar e i Götar, che
rimasero in Scandinavia, sono annoverate fra i Goti con i nomi di
Gotlandi e Geati. Sappiamo che
la prima
suddivisione interna della federazione gotica, fu tra le
due maggiori tribù (si pensa che in totale le tribù fossero non meno di dodici), i
Tervingi a occidente e i
Greutungi a oriente, che successivamente, dal III/IV secolo, saranno denominati
Visigoti (Goti dell'ovest) e
Ostrogoti (Goti dell'est), mentre i
Gepidi erano il ramo gotico settentrionale. Gli
Eruli, che erano una popolazione germanica di incerta origine (per alcuni erano
dell'Halland in Svezia, mentre secondo altri della vicina isola
danese di Selandia, se non dello Jutland stesso), si erano spostati,
contemporaneamente ai Goti, nella regione
compresa tra il fiume Dnepr e il mar d'Azov. I
Sàrmati, a causa dell'arrivo degli Eruli e dei Goti nei loro territori,
si erano spartiti a destra e a sinistra dei nuovi arrivati.
 |
Carta del III secolo con Sarmazia,
Illiria e Anatolia, con le direttrici
delle incursioni delle popolazioni
germaniche e sarmatiche.
|
Nel 234 - Nell'ultimo anno di principato di Severo Alessandro,
gli Alemanni attaccano in massa le difese romane e da lì in poi gli scontri non cesseranno più: sul Reno contro Alemanni e Franchi e lungo il Danubio, a causa della pressione di nuove stirpi germaniche (Vandali, Burgundi e Longobardi), contro i
Goti, in particolare sulle frontiere della Dacia e della Mesia, oltre alle continue pressioni dei Sàrmati.
 |
Gaio Giulio Vero
Massimino, noto
come Massimino il
Trace, il primo
imperatore barbaro,
da: QUI. |
Nel 235 - A seguito dell'
assassinio,
da parte dei suoi soldati e del suo
successore, dell'imperatore
Alessandro Severo, ultimo imperatore della dinastia dei Severi, a Moguntiacum (l'odierna Magonza), capitale della provincia della
Germania Inferior,
Massimino
Trace è acclamato
imperatore, malgrado la forte
opposizione del
Senato e l'
ostilità della
popolazione. L'omicidio avvenne lungo il
limes settentrionale, al ritorno dal fronte orientale, dopo tre anni di campagne contro i Sasanidi della Persia. Massimino è stato il
primo barbaro a raggiungere la
porpora imperiale grazie al
solo consenso delle legioni; era nato senza la cittadinanza romana e non aveva percorso alcun
corsus honorem. Al "
Sol invictus", il Sole invincibile, il cui primo vicario e sacerdote era stato l'Imperatore Settimio Severo, non tutte le legioni si erano convertite e la discriminazione nella scelta dei comandi, volta a escludere i non-convertiti, dovette alienare le simpatie al suo discendente Alessandro Severo. Il 235 d.C. è quindi l'
anno in cui viene fatta iniziare di solito l'
anarchia militare, che fu anche una
ribellione di quella parte di società romana che
non voleva soggiacere al
culto solare orientale, dopo trent'anni di dominio di questa.
Le legioni fedeli
a Massimino il Trace, stanziate nei confini occidentali, sul Reno e sul Danubio, non seguivano il culto solare, mentre era già presente fra loro una forte
componente barbarica che preferiva una
politica tollerante, esente da carichi religiosi e affine all'agnosticismo degli imperatori del secolo
precedente, con successioni al Principato non ereditarie. Dopo aver preso il potere, Massimino lanciò l'
ultima grande offensiva romana in
Germania con effettivi in gran parte germanici, contro gli Alemanni, che da allora rimasero tranquilli per vent'anni, ma perse la guerra e la vita contro i futuri Imperatori Gordiano I e Gordiano II, che avevano i comandi e l'appoggio dell'Africa romana, regione di
provenienza di Settimio Severo, dove il culto del Dio solare era
invece diffuso. Con il loro discendente Gordiano III, la pressione dei barbari sui confini era aumentata e necessitavano quindi eserciti fedeli e coesi. Sia l'Imperatore Filippo l'Arabo
che il suo successore Decio, erano stati generali dell'esercito di Gordiano
III, fedeli al
dio solare, che pur non pretendendo esclusiva
devozione e quindi non configurandosi come un monoteismo, prendeva
senz'altro
il primo posto nel Pantheon dell'Impero Romano. È
significativo che proprio sotto
Decio cominciarono le
persecuzioni
contro i cristiani. La pressione dei
barbari lungo le frontiere settentrionali e quella, contemporanea,
dei Sasanidi in Oriente, si erano non solo intensificate, ma avevano
diffuso la
sensazione che l'impero fosse totalmente
accerchiato
dai nemici. Si rivelavano
ormai inefficaci gli strumenti della diplomazia tradizionale, usati
fin dai tempi di Augusto e basati sulla minaccia dell'uso della forza
e sulla fomentazione di dissidi interni alle diverse tribù ostili
(la politica del “dividi e impera”) per tenerle impegnate le une
contro le altre. Si rendeva necessario reagire in tempi brevi con la
forza, schierando armate tatticamente superiori e capaci di
intercettare il più rapidamente possibile ogni possibile via di
invasione dei barbari, strategia resa difficoltosa dal
dover
presidiare immensi tratti di
frontiera con
contingenti
militari per lo più
scarsi. La causa
principale della
crisi del III secolo può essere ricercata
nella fine dell'idea di Impero tipica delle dinastie giulio-claudia
ed antonina, basata sulla collaborazione tra l'imperatore, il potere
militare e le forze politico-economiche interne, al fine di espandere l'impero, mentre nel III secolo d.C. tutte le
energie dello Stato venivano
spese non per ampliare, ma
per difendere
i
confini dalle invasioni barbariche. Con l'esaurimento dei proventi ottenuti dalle conquiste, il peso economico e l'energia politica delle legioni
finirono per pesare all'interno dell'Impero, con il risultato che l'
esercito, che era stato il
fattore principale della potenza economica romana, finì per diventare
un
peso sempre più schiacciante, mentre la sua
prepotenza
politica non poteva essere arginata da alcuna istituzione. La
cosa più sorprendente di questa gravissima crisi è che
l'Impero sia riuscito a superarla. Molti degli imperatori che vennero via via proclamati dalle legioni
successivamente, non riuscirono neppure a metter piede a Roma, né
tanto meno, durante i loro brevissimi regni, a intraprendere riforme
interne, poiché permanentemente occupati a difendere il trono
imperiale dagli altri pretendenti e il territorio dai nemici esterni.
La
crisi, generalizzata in tutto l'impero, non fu solo
politica, ma anche
economica e
sociale. L'economia dell'impero romano nei primi due secoli si
era basata sulla conquista militare di nuovi territori e sullo
sfruttamento delle campagne da parte di schiavi, perlopiù
prigionieri di guerra. Ora, in
mancanza
di nuove
conquiste, di nuovi
schiavi e di
bottini
di guerra, le spese dello Stato, sempre più impellenti per
rispondere militarmente alle pressioni delle popolazioni esterne
dell'impero, furono coperte con un progressivo
aumento delle
tassazioni, proprio quando la diminuzione del numero di schiavi
minava le possibilità economiche dei cittadini. Gradualmente la
ricchezza, l'importanza politica, sociale, istituzionale e culturale
si era livellata tra il centro e le province dell'Impero romano,
sebbene con disparità ancora evidenti (in genere le province
orientali erano economicamente più sviluppate di quelle
occidentali). La
pressione
fiscale divenne
insostenibile per molti
piccoli proprietari,
costretti a indebitarsi e quindi a vendere le proprie terre, per
andare a
lavorare in condizioni di
semischiavitù sotto i
grandi proprietari (
colonato). Per questo fenomeno e per il
calo demografico determinato dalle perdite umane nei numerosi
conflitti,
molte terre furono
abbandonate e cessarono
di essere produttive (fenomeno degli
agri deserti). Le
difficoltà di comunicazione in seguito ai numerosi conflitti avevano
in diversi casi reso indispensabile la
riscossione diretta delle
tasse da parte dell'
esercito stesso, causando abusi e
trasformandosi a volte in un vero e proprio diritto al
saccheggio. Lo spopolamento di
intere regioni fu inoltre causato anche da elementi climatici e
sociali: i
contadini, infatti,
non conoscevano la
rotazione delle
colture e via via che la terra diventava improduttiva si dovevano
spostare verso altre aree. Si diffusero così i latifondi scarsamente
produttivi e il ceto dei contadini liberi si assottigliò, sostituito
prima dagli schiavi e successivamente, dai coloni affittuari. La
scarsa capacità
di acquisto delle classi subalterne, impediva
una qualsiasi crescita del mercato economico. Mancava inoltre
qualsiasi politica di sussidi statali all'agricoltura e alle
manifatture. Fin dalla riforma di Settimio Severo, i
soldati
romani costituivano una
casta (
ereditaria)
di
privilegiati mentre gli altri, soprattutto gli agricoltori,
si trovavano oberati dalle tasse e di conseguenza in
molti cercarono di
abbandonare la
terra per trasferirsi in città. Fin dalla fine del
III secolo e ancor più nel secolo successivo, lo
Stato cercò
di approntare una serie di meccanismi e disposizioni
legali tese a
impedire l'abbandono della terra da parte dei
contadini non proprietari che, a vario titolo, la coltivavano, creando così la
servitù della gleba. Mentre per questi
fattori l'impero si andava gradualmente impoverendo, le situazioni
ai
confini si stavano facendo sempre più critiche, con
richieste di
tributi per sostenere la
macchina militare, che
sempre con maggiori difficoltà venivano ottenuti. Le
aree
spopolate vennero in seguito
concesse ad alcune
popolazioni
barbariche che per si stabilirono nell'Impero come
foederati. Le continue scorrerie da parte dei barbari
nei vent'anni successivi alla fine della dinastia dei Severi avevano
messo in ginocchio l'economia ed il commercio dell'Impero romano.
Numerose fattorie e raccolti erano stati distrutti, se non dai
barbari, da bande di briganti e dalle armate romane alla ricerca di
sostentamento, durante le campagne militari combattute sia contro i
nemici esterni, sia contro quelli interni (usurpatori alla porpora
imperiale). La scarsità di cibo generava, inoltre, una domanda
superiore all'offerta di derrate alimentari, con evidenti conseguenze
inflazionistiche sui beni di prima necessità. A tutto ciò si
aggiungeva un costante reclutamento forzato di militari, a danno
della manovalanza impiegata nelle campagne agricole, con conseguente
abbandono di numerose fattorie e vaste aree di campi da coltivare.
Questa impellente richiesta di soldati, a sua volta, aveva generato
una implicita corsa al
rialzo del prezzo per ottenere la
porpora
imperiale. Ogni nuovo imperatore o usurpatore era costretto,
pertanto, ad offrire al proprio esercito crescenti donativi e paghe
sempre più remunerative, con grave danno per l'
aerarium imperiale,
spesso costretto a coprire queste spese straordinarie con la confisca
di enormi patrimoni di cittadini privati, vittime in questi anni di
proscrizioni "di parte". La crisi era
aggravata, inoltre, dall'
iperinflazione causata da anni di
svalutazione della moneta, già sotto
gli imperatori della dinastia dei Severi, che per far fronte alle
necessità militari avevano
ampliato l'
esercito di un
quarto e
raddoppiata la
paga base. Le spese militari
costituivano il 75% circa del bilancio totale statale, in quanto
poca era la spesa "sociale", mentre tutto il resto era
utilizzato in progetti di prestigiose costruzioni a Roma e nelle
province. A ciò si aggiungeva un
sussidio in grano per coloro che
risultavano
disoccupati, oltre ad
aiuti al
proletariato di
Roma (congiaria) e
sussidi alle
famiglie italiche (simile
ai moderni assegni familiari) per incoraggiarle a generare più
figli. I giacimenti di
metalli preziosi erano ormai in esaurimento, dopo secoli di
sfruttamento e finì per determinarsi, nel Tardo Impero, una
rarefazione dell'
oro e dell'
argento all'interno dei confini
imperiali, accelerando così la perversa spirale di diminuzione della
quantità effettiva di metallo prezioso nelle monete coniate dai vari
imperatori. Inoltre,
l'instabilità politica ebbe pesantissimi effetti anche sui traffici
commerciali, per cui l'
ampia rete commerciale attiva
nei due secoli precedenti
fu interrotta. L'agitazione
civile e i conflitti la resero poco sicuri i viaggi per i commercianti e la crisi
monetaria rese gli scambi molto difficili. Ciò produsse
profondi
cambiamenti che proseguirono
fino all'
età medioevale. I
grandi latifondisti, non più in grado di esportare con successo i
loro raccolti sulle lunghe distanze, cominciarono a produrre cibi per
la sussistenza e il baratto locale e per non importare alcuni prodotti, cominciarono a produrre beni localmente, spesso sulle
loro stesse proprietà di campagna, dove tendevano a rifugiarsi per
sfuggire alle imposizioni dello Stato. Nacque
in tal modo una "
economia domestica" autosufficiente
che sarebbe diventata ordinaria nei secoli successivi, raggiungendo
la sua forma finale in età medioevale. La crisi economica aveva comportato una
diversa
suddivisione della
società. Delle
tre classi tradizionali dei
senatori,
cavalieri e
plebei, senatori e
cavalieri (grandi proprietari terrieri e militari, che disponevano
anche delle riserve di monete d'oro) erano
confluiti nella classe privilegiata degli
honestiores,
mentre artigiani e piccoli commercianti, colpiti dalle difficoltà
economiche e dalla svalutazione delle monete d'argento, erano
confluiti nella classe degli
humiliores che andava man
mano perdendo i propri diritti. Pene diverse erano infatti previste per
honestiores e
humiliores e le
possibilità di scalata sociale erano fortemente ridotte per quest'ultimi, che sempre più
spesso rinunciavano volontariamente alle proprie
libertà per affidarsi alla protezione dei grandi proprietari
terrieri ed evitare l'arruolamento forzato nell'esercito, mentre i piccoli artigiani e commercianti delle città si spostavano verso le grandi proprietà della campagna alla ricerca
di cibo e di protezione. Diventarono perciò cittadini semi-liberi, noti
come
coloni, legati alla terra e con le successive riforme
imperiali, la loro posizione divenne ereditaria, il modello per la
servitù della gleba, la
base della
società feudale medievale.
Nel 238 -
In opposizione all'esoso governo di Massimino, si ribellano
nella provincia d'Africa Gordiano I e Gordiano II
(rispettivamente nonno e zio del futuro imperatore Gordiano III), che
sono riconosciuti co-imperatori dal Senato, mentre al nipote è
promessa la pretura, il consolato ed il titolo di Cesare.
Contemporaneamente Massimino ed il figlio sono proclamati "nemici
pubblici". L'azione dei due Gordiani sarà però, repressa in
meno di un mese da Capeliano, governatore della Numidia e fedele
seguace di Massimino. I due co-imperatori persero la vita, ma la
pubblica opinione ne conservò la memoria come di
letterati amanti della pace e vittime dell'oppressione di
Massimino. Nel frattempo, Massimino era in procinto di marciare su
Roma ed il Senato elesse co-imperatori Pupieno e
Balbino. Questi senatori non erano personaggi popolari e la
popolazione di Roma, ancora scioccata dalla fine dei due Gordiano,
pretese che il figlio tredicenne di Antonia Gordiana prendesse il
nome del nonno, Marco Antonio Gordiano e che fosse nominato
Cesare. Pupieno e Balbino
sconfissero Massimino Trace principalmente grazie alla diserzione di
alcune legioni, in particolare la Legio II Parthica, che
assassinò Massimino. Il regno di Pupieno e Balbino fu minato fin
dall'inizio da ribellioni popolari, dal malcontento nelle legioni ed
anche da un enorme incendio che divorò Roma nel
giugno del 238. Il 29 luglio Pupieno e Balbino furono uccisi
dai pretoriani e Gordiano, giovanissimo, fu proclamato imperatore,
riconosciuto anche dal Senato. In suo onore furono organizzati gare
sceniche e ginniche. Marco Antonio Gordiano Pio, meglio noto come
Gordiano III (Roma, 20 gennaio 225 - Circesium, 11
febbraio 244), è stato imperatore romano dal 238 alla sua morte,
avvenuta durante una campagna militare in Oriente contro i Sasanidi.
A causa della sua giovane età (salì al trono a tredici anni e regnò
fino a diciannove), il governo dell'impero fu nelle mani di reggenti
appartenenti all'aristocrazia senatoriale, che si dimostrarono
capaci. Gordiano funse da simbolo dell'unità dell'impero,
riscuotendo il sostegno del popolo. La storiografia ne dipinge quindi
un ritratto estremamente positivo, forse anche in opposizione al suo
successore Filippo l'Arabo.
- I
goti Greutungi
assunsero il nome di Ostrogoti (Goti dell'est) quando riconobbero
l’autorità degli Amali,
la loro dinastia reale, considerati come i più valorosi tra i loro
guerrieri. Stando ad una loro leggenda, gli Amali discendevano da un
antico eroe le cui gesta gli erano valse il titolo di Amala (ossia
"potente"). La stirpe degli Amali fornì i seguenti re
Ostrogoti: Ostrogota, (principe e condottiero vissuto all'epoca degli
imperatori Gordiano III, imperatore romano dal 238 al 244 e Filippo
l'Arabo, imperatore romano dal 244 al 249), Winitario (circa 380),
Hunimundo (circa 390), Torismondo (circa 400), Valamiro circa (447 -
465), Widemero o Vidimero (circa 473), Teodemiro (468 - 474),
Teodorico il Grande (474 - 526), Atalarico (526 - 534), Teodato (534
- 536). Inoltre tra gli Amali si annovereranno anche le regine
Amalasunta e Matasunta. Alla morte di Teodato, avvenuta nel 536, gli
Amali si estinsero definitivamente.
Nel 242 -
Inizia la
predicazione di
Mani, fondatore del Manicheismo, che sarà crocifisso nel 276. Dal punto di vista dottrinale il manicheismo può essere considerato una forma di
gnosticismo dualistico, che contrappone su uno stesso piano il Male (le Tenebre, il Diavolo) e il Bene (la Luce, Dio): il dio venerato dalle religioni sarebbe in realtà un demonio, mentre il vero dio sarebbe un
deus absconditus, un dio nascosto. In campo etico, il manicheismo prevede un ascetismo molto rigoroso sia dal punto di vista sessuale che alimentare, arrivando a proibire il matrimonio e l'uso di determinate bevande. La chiesa manichea è composta dai "perfetti" (gli asceti, che costituiscono la vera e propria Chiesa) e dagli "imperfetti" (uditori o catecumeni). Questa dottrina ha suscitato grande interesse anche fra molti intellettuali, a partire da Agostino di Ippona, che però in seguito ne divenne il più acerrimo nemico, scrivendo ben dieci opere contro di essa. Subito osteggiata dagli imperatori Romani e Persiani, ebbe breve diffusione in Occidente, ma sopravvisse per secoli in Asia Centrale e Cina. In seguito il termine Manicheismo fu utilizzato per indicare posizioni cristiane dualiste (collegabili a quelle di
Marcione) diffuse nell'alto e basso medioevo (vedi Manichei medievali) come, tra gli altri, i Bogomili ed i
Càtari.
Nel 244 -
Marco Giulio Filippo Augusto, meglio noto come Filippo l'Arabo
(Trachontis, 204 circa - Verona, 249), è imperatore romano per
cinque anni, dal 244 alla sua morte. Sono poche le notizie sui cinque
anni e mezzo di regno di questo imperatore nato di umili origini e
passato alla storia per aver celebrato il primo millennio
di Roma e per la sua origine araba. Dopo una
breve campagna sul fronte danubiano, di nuovo in subbuglio per la
minaccia delle popolazioni germaniche, Filippo si recò a Roma per
consolidare i rapporti con il senato e per celebrare con grande
sfarzo, il 21 aprile 247, le feste del millenario di Roma. Sui
confini, però la situazione divenne drammatica, i Goti passarono il
Danubio e invasero la Mesia. Vari usurpatori vennero acclamati dalle
truppe e così, nel 249 anche il regno di Filippo terminò nel sangue
e il suo posto fu preso dal senatore Messio Decio, comandante delle
truppe sul fronte danubiano.
 |
Carta dell'impero romano con in
verde i territori perduti di Dacia e Agri
Decumates nel III sec. Sono indicate,
sempre in verde, le direttrici delle
migrazioni dei Sassoni, dei Franchi,
degli Suebi Alemanni, Iutungi,
Marcomanni e Quadi, degli Iazigi di
origine sarmatica, dei Carpi di stirpe
dacica, dei Goti Tervingi e dei Borani,
di stirpe incerta. Da: QUI. |
Dal 248 - Durante una nuova incursione di
Goti, ai quali era stato rifiutato il contributo annuale
promesso da Gordiano III, si associarono anche i
Vandali,
portando
devastazione nella provincia di Mesia inferiore: « Sotto l'impero di quel Filippo […]
i Goti malcontenti che non si pagasse più loro il tributo, si
trasformarono in nemici da amici che erano. […] Ostrogota, re dei
Goti, marciò contro i Romani alla testa di trentamila armati a cui
si aggiunsero anche guerrieri taifali, asdingi e tremila Carpi,
quest'ultimo popolo assai bellicoso e spesso funesto per i Romani. »
(Giordane, De origine actibusque Getarum, XVI, 1-3.). L'invasione alla fine fu fermata
dal futuro imperatore di origine illirica e allora generale dell'Imperatore Filippo l'Arabo,
Decio Traiano, presso la città di Marcianopoli, rimasta sotto assedio dei barbari per
lungo tempo. La resa dei barbari fu motivata sia dall'ignoranza dei
Germani in fatto di macchine d'assedio che, come
suggerisce Giordane, «dalla somma versata loro dagli
abitanti». Nel III secolo inizia anche l'
espansione di alcune tribù slave nella
Boemia (nome che deriva da "territorio dei Boi"), a danno dei Celti.
Dal 250 - Dopo il primo assalto avvenuto durante l'epoca di Marco Aurelio, un'altra pesantissima e ancor più devastante epidemia di peste colpisce i territori dell'Impero nel ventennio 250-270. Si è calcolato che il morbo abbia mietuto milioni di vittime e che alla fine la popolazione dell'Impero si fosse ridotta del 30 per cento, da 70 a 50 milioni di abitanti. Il prezzo da pagare per la sopravvivenza dell'Impero fu molto alto anche in termini territoriali: a partire dal 260, gli Imperatori che si susseguirono dovettero abbandonare definitivamente, gli Agri decumates oltre il Reno (con Gallieno imperatore) e la provincia delle Tre Dacie (con Aureliano imperatore, nel 271 circa).
Nel 251 - Insieme al figlio Erennio Etrusco, muore l'imperatore ex senatore e generale Gaio Messio Quinto Traiano Decio (201 - 1º luglio 251), imperatore romano dal 249, durante la battaglia di Abrittus, che regnerà così per soli due anni. Furono avvenimenti torbidi quelli che seguirono la morte di Decio, che aveva dovuto sostenere dure lotte coi Goti giunti sino a Filippopoli. Gli eserciti romani lasciarono le frontiere per marciare verso l'interno e i barbari passarono dovunque i confini. I Goti, oltre a spingersi via terra a sud del Danubio, arrivavano anche per mare in Asia Minore. Alemanni e Franchi si rovesciarono sulla Gallia, attaccata per mare dai Sassoni. D'altra parte l'esercito imperiale era per buona parte formato da Germani con aspetto e organizzazione divenuti sempre più barbarizzati e si era persa quella superiorità che gli veniva dall'armamento e dalla disciplina romana.
 |
Valeriano su sesterzio. Di
Classical Numismatic Group,
|
Nel 253 - Il nuovo imperatore
Valeriano (imperatore dal 253 al 260),
spartì il potere
con
il figlio Gallieno (imperatore dal 253 al 268), affidando a quest'ultimo la parte occidentale e riservando per sé quella orientale, come in passato era già avvenuto con Marco Aurelio e Lucio Vero (dal 161 al 169). Intorno al 253 gli
Eruli si
erano uniti ai
Goti nell'attacco a Pessinunte ed Efeso, che
distrussero. In seguito presero parte, insieme ai
Gepidi (i Goti settentrionali) e ad
altre tribù, all'imponente coalizione guidata dai
Goti che
saccheggiò le province romane della regione balcanico-anatolica. Da
queste basi, Goti ed Eruli partirono per compiere varie incursioni e
spedizioni di pirateria lungo le coste prima del mar Nero e poi
dell'Asia minore. Nel 257 e nel 258, Valeriano emanò due editti, che prevedevano la confisca dei terreni religiosi e la
condanna dei seguaci del Cristianesimo; a differenza dei suoi predecessori diresse il proprio
attacco alla
gerarchia ecclesiastica piuttosto che ai semplici fedeli. Tra le vittime di questa persecuzione vi furono infatti papa Stefano I, papa Sisto II, il vescovo di Cartagine Cipriano (messo a morte nel settembre del 258 e con la fine della sua corrispondenza manca un'importante fonte storica di quel periodo), Dionisio di Alessandria e san Lorenzo martire. Il momento più cupo del suo principato fu raggiunto nel 260, quando
Valeriano stesso fu
sconfitto in battaglia e preso prigioniero dai Sasanidi,
morendo in
prigionia senza che fosse possibile intraprendere una spedizione militare per liberarlo.
 |
| L'imperatore Gallieno. |
Se da un
lato l'impero romano sembra abbia attraversato, sotto Gallieno, uno
dei periodi più "bui" della sua storia, questo imperatore
rappresentò il punto di svolta nel tragico periodo della crisi del
III secolo, che era seguito alla dinastia dei Severi. Non è un caso
che proprio
Gallieno sia stato il primo a regnare per quindici
anni (sette con il padre ed otto da solo), cosa assai rara se si
considera il primo periodo dell'anarchia militare (dal 235 al 253).
Era, infatti, dai tempi di Settimio Severo (193-211) che un
Imperatore romano non regnava tanto a lungo. Gallieno
riformò l'esercito: resosi conto dell'impossibilità di proteggere contemporaneamente tutte le province dell'impero con una statica
linea di uomini posizionati a ridosso della frontiera, Gallieno
sviluppò una pratica che era iniziata verso la fine del II secolo
sotto Settimio Severo (con il posizionamento di una legione, la legio
II Parthica, a pochi chilometri da Roma, ovvero posizionando una
riserva strategica di
soldati ben addestrati
pronti ad
intervenire dove servisse nel minor tempo possibile (contingenti di cavalleria erano stanziati a
Mediolanum, Sirmio, Poetovio e Lychnidos). In accordo con queste
considerazioni, Gallieno attorno agli anni 264-268, o forse poco
prima, costituì questa riserva strategica centrale (che sarà alla
base della futura riforma dell'esercito di Diocleziano), formata
prevalentemente da
unità di cavalleria pesante dotate di armatura
(i cosiddetti
promoti, tra cui spiccavano gli
equites Dalmatae, gli
equites Mauri et Osroeni), poiché queste percorrevano distanze
maggiori in minor tempo della fanteria legionaria o ausiliaria. Ed
ogni volta che i barbari sfondavano il limes romano e s'inoltravano
nelle province interne, la "riserva strategica" poteva così
intervenire con forza dirompente. La
base principale scelta da
Gallieno per la nuova armata
fu posta a Milano, punto
strategico equidistante da Roma e dalle vicine frontiere
settentrionali della Rezia e del Norico. Si trattava di un'iniziativa
resasi necessaria anche a causa della perdita degli Agri decumates
tra il Reno ed il Danubio, che aveva portato i vicini Germani a
trovarsi più vicini alla penisola italica, centro del potere
imperiale. La predisposizione
per la cavalleria riguardava non solo le forze ausiliarie ed i
numeri, ma anche le legioni
stesse, dove il
numero di
cavalieri passò
da 120 a 726 per legione. Sembra infatti che
Gallieno abbia aumentato il contingente di cavalleria interno alla
legione stessa, dove la prima coorte era composta da 132 cavalieri,
mentre le altre nove di 66 ciascuna. Questo incremento fu dovuto
proprio alla necessità di avere un esercito sempre più "mobile".
La riforma di
Gallieno inoltre,
toglieva ai
senatori ogni
carica militare;
se in passato
i comandanti delle legioni (
legatus legionis)
provenivano dal Senato a parte quelli che comandavano le legioni
egiziane, ora
provenivano dalla
classe equestre (
praefectus
legionis). Con le riforme
apportate da Gallieno infatti, era mutata sia la composizione sociale
dei comandanti militari e dei loro diretti subalterni, già monopolio
aristocratico, che quella degli ufficiali intermedi, un tempo
privilegio dell'ordine equestre: dopo il 260 il comando delle legioni
e la carica di tribuno militare fu assegnata a ufficiali di carriera
spesso di bassa origine sociale. Era ora possibile, anche per un
semplice legionario che si distinguesse per abilità e disciplina,
scalare i diversi gradi dell'esercito: centurione,
protector,
dux,
fino a ottenere incarichi amministrativi prestigiosi, quale quello di
praefectus,
comandante militare. La
riforma
eliminò inoltre, in modo definitivo,
ogni legame tra le
legioni e l'Italia, poiché i nuovi comandanti, che erano spesso
militari di carriera partiti dai gradi più bassi e arrivati a quelli
più alti, erano interessati più al proprio tornaconto o al massimo
agli interessi della provincia d'origine (in particolare a quelle
Illiriche, vedi quanti Imperatori illirici), ma non a Roma.
I
generali che comandavano questa forza quindi,
avevano nelle
loro mani un potere incredibile e non è un caso che
futuri
augusti come Claudio II il Gotico o Aureliano ricoprissero questo
incarico prima di diventare imperatori. Il periodo in cui
Gallieno regnò da solo (260-268) fu caratterizzato anche da un
rifiorire delle arti e della cultura, con la creazione di un
ponte tra la cultura classica dell'epoca degli Antonini e quella
post-classica della Tetrarchia. Tale periodo vide un
cambiamento
nella visione dei
rapporti tra
uomo e
divino e
tra uomini, un
movimento che consciamente
tentò di far
rinascere la
cultura
classica ed
ellenica, come si può osservare dalla monetazione e
dalla ritrattistica imperiale. « In verità
Gallieno si segnalava, non lo si può negare, nell'oratoria, nella
poesia ed in tutte le arti. Suo è il celebre epitalamio che risultò
il migliore tra cento poeti. [...] si racconta che abbia recitato:
"Allora andate ragazzi, datevi da fare con il profondo del cuore
tra voi. Non le colombe i vostri sussurri, né l'edera i vostri
abbracci, né vincano le conchiglie i vostri baci". » (Historia Augusta,
Gallieni duo, 11.6-8.) . Fu questo periodo
che vide fiorire il
Neoplatonismo, il cui maggior
rappresentante,
Plotino, fu
amico personale di Gallieno e della moglie
Salonina. I ritratti di Gallieno si rifanno allo stile
classico-ellenistico di quelli di Adriano, ma la nuova spiritualità
è evidente dallo sguardo verso l'alto e dalla palese immobilità del
ritratto, che danno un senso di trascendenza e immutabilità. Lo
stesso imperatore rinnovò i legami con la cultura ellenica
rafforzati da Adriano e Marco Aurelio, recandosi in visita ad Atene,
diventando arconte eponimo e facendosi iniziato ai misteri di
Demetra. Tale slancio verso
il trascendente e la divinità è rimarcato dalle emissioni
numismatiche di Gallieno. Lì dove l'imperatore si trovava per far
sentire la propria presenza in zone dell'impero minacciate, la zecca
locale coniava monete in cui gli dei (tra cui Giove in diverse
incarnazioni, Marte, Giunone, Apollo, Esculapio, Salus...) venivano
ritratti come protettori dell'imperatore, direttamente o tramite gli
animali che li rappresentavano. Un posto particolare fu quello del
Sole Invitto, che venne identificato come
comes Augusti,
"compagno dell'augusto": tale divinità era particolarmente
venerata dai soldati, ancor di più da quelli orientali, dei quali
Gallieno cercava il favore e il sostegno. Secondo una interpretazione
storica che pone attenzione alla reazione psicologica delle
popolazioni rispetto alla fede religiosa,
col tempo le nuove
religioni assunsero sempre più importanza per le loro
caratteristiche escatologiche e soteriologiche in risposta alle
insorgenti esigenze della religiosità dell'individuo, al quale la
vecchia religione non offriva che riti vuoti di significato. Sempre
secondo questa interpretazione storica la critica alla religione
tradizionale veniva anche dalle correnti filosofiche dell'Ellenismo,
che fornivano risposte intorno a temi propri della sfera religiosa,
come
la concezione dell'anima e
la natura degli dèi.
Nella congerie sincretistica dell'impero del III secolo, permeata da
dottrine neoplatoniche (Plotino),
gnostiche,
orfiche
e
misteriche (misteri eleusini che trovò seguaci prima in
Adriano e poi Gallieno), il
Cristianesimo si consolidava.
Dal 256 - Nuove
minacce per l'Impero romano da parte di
Germani e Sàrmati, causate principalmente da un
cambiamento nella
struttura
tribale della loro società rispetto ai precedenti secoli: la
popolazione, sottoposta all'urto di altri popoli barbarici
provenienti dalla Scandinavia e dalle pianure dell'Europa orientale,
necessitava di una struttura organizzativa più forte, pena
l'estinzione delle tribù più deboli. Da qui la necessità di
aggregarsi in
federazioni etniche di
grandi dimensioni, come
quelle di
Alemanni, Franchi e
Goti, per difendersi da altre
bellicose popolazioni barbariche o per meglio aggredire il vicino
Impero romano, la cui ricchezza faceva gola. I Germani occidentali presentano nuovi aggruppamenti etnici che, sotto l'influsso della civiltà romana, costituiscono più salde formazioni politiche.
Dai Suebi ebbero specialmente
origine gli Alemanni (cioè: uomini di molte stirpi), che comparvero fra il Meno e il Danubio e, forzato dopo lunghe lotte il
limes, varcarono il Reno occupando l'Alsazia e il Palatinato. I
Sassoni dall'Elba inferiore si estesero sino al centro della Germania e poi verso ovest e sud, incorporando molte tribù in uno stato potente.
Non si trattava comunque allora, di
spostamenti di massa di intere popolazioni come quelli che si
sarebbero verificati nei secoli successivi, quando l'irruzione
degli Unni nello scacchiere europeo avrebbe indotto molte tribù
germaniche a cercare nuove sedi d'insediamento all'interno
dell'Impero romano. Lo sfondamento del
limes
renano-danubiano fu favorito anche dalla grave crisi interna che
travagliava l'Impero romano, fra cui l'epidemia di
peste. Roma, infatti, attraversava un periodo
di grande instabilità interna, causata dal continuo alternarsi di
imperatori ed usurpatori (nell'
anarchia militare). Le
guerre interne consumavano importanti risorse
negli scontri tra i vari contendenti e sguarnivano le frontiere, facilitando lo
sfondamento da parte delle popolazioni barbariche che si trovavano
lungo il
limes. Fra le
popolazioni Slave occidentali (i Venedi-Sclavini) delle regioni danubiane, carpatiche, lungo la costa settentrionale del mar Nero, del Dnepr e del Volga si verificavano gli stessi mutamenti socio-economici già presenti presso i Germani e anche lì l'accentuarsi delle stratificazioni sociali indurrà a partecipare alle guerre danubiane verso la metà del III secolo, tanto che uno degli imperatori romani di quel periodo porta il titolo di "venedico". Daci, Alani, Carpi e soprattutto Goti attaccarono l'impero romano, mentre le
tribù Slave orientali (dell'Europa orientale), ridussero fortemente i loro rapporti commerciali con Roma, preferendo quelli con le tribù sarmatiche o altre tribù slave orientali e parteciparono alle
guerre anti-
schiavistiche contro Roma, unendo parte delle loro forze a quelle gotiche nel III e IV secolo. Le basi geopolitiche fondamentali per le offensive dei cosiddetti "barbari" contro l'impero romano, nel III secolo, furono le regioni fra il Danubio, il Reno, l'Elba e la costa settentrionale del mar Nero. Indispensabile, per la riuscita di queste campagne militari, fu l'
alleanza tra i
ceti nobiliari germanici e slavi e le
grandi masse popolari, schiavili e semischiavili, che consideravano i "
barbari" come loro
liberatori.
 |
Franchi Salii, Franchi Ripuarii
e Alemanni, da: QUI. |
Sul Reno inferiore appare nel sec. III la potente
federazione dei Franchi (nome che alcuni pensano derivi da “arditi”), continuazione degli antichi Chiauci, frutto dell'unione di
tribù germaniche stanziate lungo la sponda destra del corso inferiore del Reno,
fra le quali vi furono probabilmente anche i
Brutteri e i
Sicambri
(o Sigambri). Questa
sorta di
federazione si formò attraverso una serie di imprese
militari che via via aggiunsero ad un nucleo originario i territori
di popolazioni confinanti, senza soffocarne tuttavia l'influenza e
l'autonomia. E' consuetudine suddividere i Franchi in
due grandi
gruppi.
1)
I
Franchi Salii, così
chiamati perché abitavano la regione, negli attuali Paesi Bassi,
prossima al
fiume Sala,
l'odierno Ijssel, il più orientale dei tre rami principali in
cui si divide il Reno prima di sfociare in mare, gli altri due sono
il Nederrijn e il Waal; anticamente era chiamato dai Romani con il
nome Isala (o Sala), il cui nome si pensa derivi dal germanico “i
sala”, che significa "acqua scura". Oggigiorno si getta,
attraverso il Ketelmeer, nell'IJsselmeer, un lago artificiale che
deve il suo nome al fiume IJssel che ne è tributario, nome
caratterizzato dal digramma IJ che in olandese è una lettera
dell'alfabeto che si scrive in maiuscolo). 2) I
Franchi Ripuari,
(probabilmente da “ripa”, la riva del Reno), stanziati più a sud
lungo la sponda destra del corso inferiore del Reno, in un'area oggi
facente parte della Germania, nei territori di Colonia, Treviri,
Francoforte). Nel corso del III secolo d.C. i Franchi sono ricordati
per i loro tentativi, spesso con
gli
Alemanni (dal
germanico “uomini di molte stirpi”, una federazione di tribù germaniche, perlopiù Suebi, stanziati sud dei Franchi fino al Danubio) di superare i confini
stabiliti con l'Impero Romano. Nel
254 Gallieno, che allora
aveva la carica di Cesare, fermò uno di questi tentativi di
invasione. Ancora Gallieno nel
257 intervenne
contro i Franchi nei pressi di Colonia mentre Aureliano (che sarebbe
divenuto imperatore nel 270) comandava una legione che li affrontò e
sconfisse presso Mogontiacum (Magonza). Altre imprese dei Franchi
verso le Gallie e la Penisola Iberica si svolsero negli anni
successivi e furono fermate dagli interventi di Postumo e di
Aureliano. Fu negli anni successivi alla morte di Aureliano (nel
275)
che i Franchi, ancora con gli Alemanni, riuscirono ad invadere la
Gallia portando ovunque la devastazione dei saccheggi finché non
furono fermati da Probo e, nel
288, da Massimiano.
 |
La Dacia persa dai Romani nel
271, da: QUI. |
Dal 257 -
La popolazione germanica dei
Goti conquista la
Dacia, territorio dell'impero romano.
Per eventuali approfondimenti vedi "Storia dell'Europa n.32: dal 193 al 257 e.v. (d.C.)"
QUI.
 |
L'Europa centrale nel 258-260 con i
percorsi delle migrazioni delle
delle confederazioni dei Franchi,
dei Suebi Alemanni, Marcomanni
e Quadi, dei Sàrmati Iazigi.
Immagine da: QUI. |
Nel 260 - Con Gallieno imperatore si
abbandonano definitivamente gli
Agri Decumates, posti a est del Reno e a nord delle sorgenti del Danubio, alla confederazione degli
Alemanni, che giungono fino alle porte di
Mediolanum (Milano),
nella primavera del 260 e che le legioni dell'imperatore romano
Gallieno, riescono a respingere nella
battaglia di Milano, in cui Gallieno si
rende conto dell'impossibilità di proteggere contemporaneamente tutte
le province dell'impero con una linea statica di uomini posizionati a
ridosso della frontiera (detti appunto limitanei dal termine latino
limes) ora che il fronte è stato sfondato definitivamente. Perciò Gallieno formalizza e migliora una pratica che si era già diffusa dalla fine del II secolo sotto
Settimio Severo, che aveva fatto acquartierare una legione, la Legio
II Parthica, a pochi chilometri da Roma: si trattava infatti di una
riserva strategica di soldati ben addestrati (detti
comitatenses)
pronti ad intervenire dove serviva nel minor tempo possibile.
Gallieno costituì questa
riserva strategica centrale (che
sarà alla base della futura riforma dell'esercito di Diocleziano)
formata prevalentemente da unità di
cavalleria pesante,
ovvero composte da cavalieri dotati di armatura pesante (i cosiddetti
promoti, tra cui spiccavano gli
equites Dalmatae
e gli
equites Mauri et Osroeni), poiché questi
percorrevano distanze maggiori in minor tempo della fanteria
legionaria o ausiliarie. Ogni volta che i barbari sfondavano il
limes
e s'inoltravano nelle province interne, interveniva la "riserva
strategica". La
base principale scelta da Gallieno per la nuova
armata fu proprio
Milano,
punto strategico equidistante
da Roma e dalle vicine frontiere settentrionali di Rezia e Norico. Si
trattava di un'iniziativa resasi necessaria dalla perdita degli Agri
Decumates tra il Reno ed il Danubio, che aveva portato i vicini
Germani a trovarsi più vicini alla penisola italica, centro del
potere imperiale. Visto il nuovo ruolo strategico della città che diverrà in seguito capitale della parte occidentale dell'impero, per l'occasione Gallieno apre nell'antica Mediolanum una nuova zecca. Inoltre con la
riforma
dell'
esercito operata da
Gallieno (260-268), il
Senato
di Roma finì per essere
escluso non solo sostanzialmente, ma
anche ufficialmente dal
comando militare, in quanto
l'imperatore decretò che le legioni potessero essere guidate anche
da
praefecti di rango equestre, la classe sociale intermedia
fra Patrizi e Plebei istituita da Gaio Sempronio Gracco nel 123 a.C., mentre in precedenza il comando delle legioni era monopolio di legati patrizi, di classe senatoria.
 |
Cartina dell'Impero Romano quando
erano imperatori Valeriano e suo
figlio Gallieno, nel 260. Il Regno
di Palmira e l'Impero delle Gallie
effettuarono una secessione che fu
poi risolta da Aureliano nel periodo
271-274. |
Dallo stesso 260 e fino al 274 circa, l'imperatore
Gallieno
è costretto ad assistere alla successiva
secessione di
due parti dell'impero, una nell'occidente britannico-gallico-hispanico usurpata da
Postumo, governatore delle Germanie superiore ed
inferiore, e poco dopo una nel vicino oriente in seguito all'assassinio del governatore di Palmira, Settimio Odenato, dove, la moglie
Zenobia aveva preso il potere in nome del figlio minorenne Vaballato. Sembra che l'imperatore non avesse potuto
intervenire lungo il fronte germanico-retico a causa della
contemporanea crisi orientale in cui il proprio padre,
Valeriano, era stato catturato dai Sasanidi di Sapore I nella tarda estate. Va precisato comunque che grazie alla
divisione provvisoria
dello Stato romano in
tre parti (a occidente l'impero delle Gallie, al centro Italia, Illirico e province africane e a oriente il Regno di Palmira), l'Impero
riuscirà a
salvarsi dal tracollo. Ne scrive in merito Eutropio: « Avendo così Gallieno
abbandonato lo Stato, l'Impero romano fu salvato in Occidente da
Postumo ed in Oriente da Odenato. » (Eutropio,
Breviarium ab urbe
condita, 9, 11.). In
Oriente Settimio Odenato aveva respinto i Sasanidi e si era ritagliato un dominio
personale, nominalmente controllato da Roma, noto come
“
Regno
di
Palmira”, che era la sua capitale (l'attuale Tadmor in Siria) e che sua moglie Zenobia staccherà da Roma, mentre in Occidente
il
comandante delle truppe renane, Postumo, si era rivoltato uccidendo
Salonino, il figlio di Gallieno di cui era tutore, proclamandosi
augusto e creando l'”
Impero delle Gallie”,
un vero e proprio stato con senato, consoli e magistrature simili a
quelle dell'impero "centrale". Postumo era riuscito a
costituire un impero incentrato sulle provincie della
Germania inferiore e della Gallia Belgica alle quali si unirono poco
dopo tutte le altre province galliche, della Germania superiore,
della Britannia, dell'Iberia e, per un breve periodo, anche quella
di Rezia.
 |
| Profilo di Zenobia da QUI. |
- Nel
Regno di Palmira, la città di Palmira era un'oasi lungo la via carovaniera che metteva in
contatto l'oriente dei Parti con i porti del Mediterraneo, controllati
da Roma, che aveva sviluppato la propria fortuna commerciale sulla sua
equidistanza dai due imperi, spesso in lotta tra loro. Nel 267 il
governatore di Palmira,
Settimio
Odenato, appartenente ad una
famiglia che aveva ottenuto la cittadinanza romana con Settimio
Severo, è assassinato ad Emesa, assieme al figlio Hairan (o Erode o
Erodiano) e al governatore militare
di Palmira, Settimio Vorode, da Maconio, cugino o
nipote di Odenato stesso. Poco
dopo,
la moglie Zenobia prende il
potere in nome del figlio superstite, il minorenne Vaballato, inizialmente sotto l'egida di Roma ma col proposito di staccarsene per creare un impero d'Oriente autonomo, forte dell'appoggio del generale Zabdas e forse con un'intesa coi Persiani. L'imperatore Gallieno
sarà impedito a recarsi
in Oriente sia dall'invasione dei Goti iniziata nel 267, che dalla
grande invasione degli Eruli del 268, anno in cui verrà assassinato. Zenobia, dopo la
morte per
peste dell'imperatore
Claudio il Gotico nel 270,
riuscì ad
estendere il potere del suo
regno
conquistando la
Bitinia e l'
Egitto e nello stesso 270 divenne imperatore Aureliano, che inizialmente riconobbe a
Vaballato i titoli di
vir
clarissimus rex e
imperator dux Romanorum,
tanto che nel regno di Palmira si batterono monete con da un lato
l'effigie di Vaballato,
imperator
dux Romanorum e
dall'altro Aureliano. Nel 271,
risolti i problemi in Italia, Aureliano deciderà di tamponare le falle del sistema difensivo romano e di restaurare l'integrità
dello stato, cominciando proprio dal regno di Palmira, sottomesso nel 272.
- L'
Impero delle Gallie, composto da Gallie, Britannia e Iberia, era retto da usurpatori come Postumo (260-268), Leliano (268), Marco Aurelio Mario (268-269), Vittorino (269-271), Domiziano II (271) e Tetrico (271-274). Costituì un proprio Senato nella sua maggiore città, Augusta Treverorum
(Treviri), per quanto la sua capitale fosse Colonia Agrippina e vi si attribuirono i classici titoli di imperatore, console, pontefice massimo e tribuno della plebe nel nome di Roma
aeterna. Vi si coniavano monete presso la zecca di Lugdunum (Lione) e si aspirava all'unità con Roma, senza mai pensare di marciare contro gli imperatori "legittimi" (come Gallieno, Claudio il Gotico, Quintillo o Aureliano), che esercitavano il proprio principato su Roma (e governavano l'Italia, le province africane occidentali fino alla Tripolitania, le province danubiane e dell'area balcaniche). L'
Impero delle Gallie fu alla fine
riconquistato dall'imperatore
Aureliano (270-275) nel 273/274, quando marciò sulla Gallia e sconfisse Tetrico nella battaglia di Chalons e soppresse la rivolta di Faustino a Treviri.
Nel 261 - Torme di Franchi raggiungono la Spagna. La marea degli invasori è contenuta ma l'unità stessa dell'impero si rallenta e ogni provincia si affida a chi può difenderla.
 |
| I Goti nel III secolo. |
Nel 267 - Dalla regione balcanico-anatolica,
Goti ed
Eruli compiono varie incursioni e spedizioni di pirateria lungo le coste prima del mar Nero e poi dell'Asia minore fino a colpire
Atene nel 267. I
Goti si distingueranno poi in
Visigoti (Wi in gotico = "degni" o "nobili", citati come Goti dell'Ovest, dal tedesco Westgoten, perlopiù
Tervingi) stanziati fra Danubio e Mar Nero, a occidente del Dnestr (Nistro in italiano), mentre i Goti che si erano stanziati lungo il bacino del Dnepr saranno detti
Ostrogoti (Goti dell'Est, dal tedesco Ostgoten, perlopiù
Greutungi).
Gepidi sarà il nome dato ai Goti settentrionali. La divisione fra Ostrogoti e Visigoti
ebbe luogo tra il III e IV sec. nel Ponto, quando i Visigoti, allora
noti come Tervingi, riconobbero l’autorità dei Balti, mentre gli
Ostrogoti, allora noti come Greutungi, riconobbero quella degli Amali.
 |
Carta del 268-270 con le incursioni
dei Goti in Grecia e Asia minore. |
Nel 268 - I
Goti saccheggiano Atene,
Argo,
Corinto e
Sparta a cui seguiranno delle invasioni nella parte occidentale dell'impero romano da parte di Alemanni, Marcomanni, Iutungi, Iazigi e Vandali Asdingi nel 268-271. I goti
Tervingi apparvero la
prima volta come popolo nel
268, quando invasero
l'Impero Romano. L'invasione interessò le province romane della
Pannonia e dell'Illiria, mettendo a rischio l'Italia stessa. In ogni
caso i Tervingi vennero sconfitti nella successiva estate, nei pressi
dell'attuale confine italo-sloveno e definitivamente battuti a
settembre nella battaglia di Naisso. Nei seguenti tre anni vennero
spinti di nuovo oltre al Danubio con una serie di campagne militare
condotte dagli imperatori Claudio il Gotico ed Aureliano. Riuscirono
invece a mantenere il
controllo della
Dacia, provincia
liberata da Aureliano nel 271. Mentre i Goti impegnavano lo stesso imperatore Gallieno in Tracia ed Illirico, una nuova orda di Alemanni riusciva a penetrare nell'Italia settentrionale attraverso il passo del Brennero, approfittando dell'assenza dell'esercito imperiale, impegnato a fronteggiare sia la devastante invasione dei Goti in Mesia, Acaia, Macedonia, Ponto ed Asia, sia l'usurpatore Aureolo, che si era fortificato a Milano. Tornato a Milano, dopo aver affidato il comando della guerra contro i Goti a Marciano, Gallieno si apprestò ad assediare Aureolo, ma Aureolo, che aveva ormai perduto ogni speranza, fece spargere voci nel campo dell'imperatore che inneggiavano contro Gallieno. Alcuni comandanti, stanchi dell'imperatore, ordirono una congiura e dissero al principe che Aureolo aveva tentato una sortita, facendolo così uscire dalla sua tenda.
Gallieno fu
ucciso a tradimento dal comandante della cavalleria dalmata Ceronio o Cecropio insieme al fratello Publio Licinio Valeriano. Alla congiura pare non fosse estraneo il suo successore Claudio II il Gotico (Marco Aurelio Claudio), anche se alcuni storici (anche coevi) affermarono che Gallieno morì in conseguenza di una brutta ferita riportata durante lo svolgersi dell'assedio. Tra gli organizzatori c'era il suo prefetto del pretorio Aurelio Eracliano. « [Cecropio] avvicinatosi a Gallieno mentre stava pranzando, disse che uno degli esploratori aveva appena annunciato l'arrivo di Aureolo con tutte le sue forze. A queste parole, l'imperatore sgomento, chiese le armi e saltò sul cavallo, dando ordine ai soldati di seguirlo, e senza neppure attendere la sua guardia del corpo, si lanciò. Il comandante della cavalleria dalmata, appena lo vide senza armatura, lo uccise. » (Zosimo, I.40.3.). Aurelio Vittore sostiene che Gallieno, sul letto di morte, designò quale suo successore, Claudio. Alla notizia della sua morte, i suoi familiari furono assassinati. Gallieno morì così a cinquant'anni, dopo quindici di regno e fu divinizzato dal Senato per volere del suo successore Claudio II. I primi
contatti diretti tra Romani ed
Eruli sono riferibili alle scorrerie operate da un'orda di Germani (Eruli, Goti e Gepidi, i Goti settentrionali) nei Balcani e alla decisiva battaglia vinta dai Romani guidati dall'imperatore Claudio II nel 268 nei pressi di Niš (Naisso) in Serbia.
 |
Claudio il Gotico, di
Sailko, opera propria
|
- La vittoria di
Claudio II il Gotico (Sirmia, 10 maggio 213 o 214 - Sirmio, l'attuale Sremska Mitrovica in Serbia, luglio 270), il
nuovo imperatore di stirpe illirica, contro i Goti nella battaglia di Naisso del 268, da cui meritò il titolo di
Gothicus Maximus, segnerà una significativa svolta nell'ambito della crisi dell'anarchia militare. Anche se il suo principato (dal settembre/ottobre del 268) durò solo un anno e nove mesi, cercò di risolvere i gravi problemi dell'impero. Gli
ottimi rapporti che ebbe con il
Senato di Roma, che trovarono il fondamento principale nella
gratitudine della Curia romana per l'
eliminazione di
Gallieno, si manifestarono anche dopo la sua morte, con l'elezione ad Augusto del fratello Quintillo. Quindi, dopo la morte di Gallieno (268), fu un
gruppo di
imperatori-soldati di
origine illirica (Claudio il Gotico, Aureliano e Marco Aurelio Probo)
che
riuscirono a
riunificare l'
Impero in un unico blocco, anche se cinquant'anni di guerre civili e continue incursioni barbariche avevano costretto i Romani a
rinunciare sia agli
Agri Decumates (lasciati agli Alemanni nel 260) che alla
Dacia (nel 256/271), attaccata da Carpi, Goti Tervingi, Eruli e Sàrmati Iazigi. L'imperatore Costantino rivendicava
Claudio il Gotico come proprio antenato.
Nel 270 - Aureliano (imperatore nel periodo 270-276) succede a Claudio il Gotico.
 |
Carta delle invasioni nell'Impero
Romano nel periodo 268-271da parte delle confederazioni suebiche
degli Alemanni, Iutungi e Marcomanni, dei vandalici
Asdingi e dai sarmatici Iazigi. |
La popolazione germanica dei
Vandali (Wandili), dopo una prima migrazione dalla Scandinavia nei territori dell'attuale Polonia intorno al 400 a.C., sotto la pressione di altre tribù germaniche si era spostata più a sud, dove aveva sottomesso la popolazione celtica dei Boi, circa nel 170, mentre nel periodo 270 - 330 si era stanziata nell'attuale
Slesia, nel sud della Polonia. Nel 270, mentre l'imperatore
Aureliano si trovava a Roma, per ricevere dal Senato in modo ufficiale i pieni poteri imperiali, una nuova invasione generò il panico, questa volta nelle province di Pannonia superiore ed inferiore, che evidentemente Aureliano aveva sguarnito per recarsi in Italia a respingere l'invasione degli Iutungi. Si trattava dei
Vandali Asdingi, insieme ad alcune bande di
Sàrmati Iazigi, ma il pronto intervento dell'imperatore in persona costrinse queste popolazioni germano-sarmatiche a capitolare e a chiedere la pace. Aureliano costrinse i barbari a fornire in ostaggio molti dei loro figli, oltre ad un contingente di cavalleria ausiliaria di duemila uomini, in cambio del ritorno alle loro terre a nord del Danubio e per questi successi ottenne l'appellativo di
Sarmaticus maximus.
- La
crisi politico-militare del III sec., durata 50 anni e caratterizzata da almeno
tre conflitti, quello
esterno, innescato dalle invasioni barbariche, quello
interno tra l'aristocrazia senatoria ed i comandanti militari e quello
nelle file dell'esercito tra generali, imperatori ed usurpatori, dimostrava la
maggiore importanza dell'elemento militare che doveva difendere l'Impero
rispetto al Senato, che aveva ormai perso non solo autorità, ma anche autorevolezza. Gli
imperatori ormai non provenivano più dai ranghi del Senato, ma
erano i generali che avevano fatto carriera nell'esercito e che erano proclamati dai soldati, ottenendo il potere dopo aver combattuto contro altri comandanti. Con la riforma dell'esercito operata da Gallieno (260-268) il Senato di Roma finì per essere escluso non solo sostanzialmente, ma anche ufficialmente dal comando militare, in quanto l'imperatore decretò che
le legioni potessero essere
guidate anche da praefecti di rango equestre (in precedenza il comando delle legioni era monopolio di legati di classe senatoria). L'insicurezza del territorio comportò anche un
cambiamento nel carattere delle città: queste si erano ovunque sviluppate nei primi due secoli dell'impero e non avevano particolari esigenze difensive, mentre a partire dal III secolo iniziò il cambiamento graduale e discontinuo che avrebbe portato dalle grandi città aperte dell'antichità, alle più piccole città cinte da mura, comuni nel medioevo. Particolarmente
significativa fu la
nuova cinta muraria che l'imperatore Aureliano fece costruire intorno alla stessa Roma, che dopo molti secoli era nuovamente minacciata dalle incursioni dei barbari. La costruzione delle mura iniziò probabilmente nel 271 e si concluse dopo soli due anni, anche se la definitiva rifinitura avvenne verso il 280, sotto l’
imperatore Probo. Il progetto era improntato sulla massima velocità di realizzazione e semplicità strutturale oltre, ovviamente, ad una garanzia di protezione e sicurezza. Queste caratteristiche fanno pensare che un ruolo non secondario, almeno nella progettazione, sia stato rivestito da esperti militari. E d’altra parte, poiché all’epoca gli unici nemici che potevano rappresentare qualche pericolo non erano in grado di compiere molto più che qualche razzia, un muro con robuste porte ed un camminamento di ronda poteva ritenersi sufficiente. Comunque, nessun nemico assediò le mura prima dell'anno 408. La stessa diminuzione del commercio indirizzava inoltre le città verso un sempre crescente isolamento. I grandi centri videro diminuire la propria popolazione: molti grandi proprietari si erano spostati nei loro possedimenti in campagna, diventati in larga misura autosufficienti e che tendevano a sfuggire al controllo dell'autorità centrale; la crisi aveva attratto verso questi nuovi centri economici anche coloro che precedentemente trovavano la propria sussistenza nell'economia cittadina. La pressione fiscale aveva inoltre quasi del tutto cancellato quel ceto di funzionari cittadini, i decurioni, che ne garantivano l'amministrazione ed il legame con Roma.
Nel 271 circa - Aureliano, imperatore dal 270 al 276 succeduto a Claudio il Gotico, abbandona la provincia delle Tre Dacie mentre saranno riconquistati il regno di Palmira nel 272 e l'impero delle Gallie nel 273, staccatisi dall'Impero durante il Principato di Gallieno. L'impero romano sarà nuovamente riunito e le truppe di frontiera di nuovo al loro posto, anche se sotto Aureliano, gli Alamanni giunsero sino a Fano (PU).
- Nel III secolo la
religione pagana si era fortemente
trasformata: sulla spinta della insicurezza dei tempi e dell'influsso dei culti di origine orientale, le sue caratteristiche pubbliche e ritualistiche avevano sempre più perso di significato di fronte ad una più intensa e
personale spiritualità. Si era andato diffondendo un sincretismo venato di
monoteismo e si tendeva a vedere nelle immagini degli dei tradizionali l'espressione di un unico essere divino. Una forma politica a questa aspirazione sincretistica fu data dall'imperatore Aureliano (275), con l'istituzione del
culto ufficiale del
Sol Invictus ("Sole Invitto"), con elementi del mitraismo e di altri culti solari di origine orientale.
Dal 276 - Marco Aurelio
Probo (Sirmio, l'attuale Sremska
Mitrovica in Serbia, 9 agosto 232 - Sirmio, 282) è nominato
imperatore, mentre si verifica un'altra grave
crisi di anarchia militare. Intanto oltre che per l'esercito,
l'impero ha
bisogno dei
Germani anche per reggere la sua crollante economia: si fanno razzie nella Germania per trarne
braccia da lavoro. Inoltre i Germani, sia come prigionieri di guerra (
dediticii) o in seguito a patti come
foederati,
laeti, inquilini,
gentiles, comunque riuniti in gruppi omogenei, vennero collocati nelle provincie spopolate, specialmente da Marco Aurelio, da Gallieno, da Claudio Gotico, da Aureliano, da Probo, da Massimiano e da Diocleziano. Dovevano coltivare le terre e fornire soldati, ricevendo sovente sussidi in denaro. Intanto i
Vandali tornarono ad
invadere i territori imperiali, assieme a
Lugi e
Burgundi,
lungo il tratto dell'alto-medio corso del Danubio. Nel 278,
l'Imperatore Probo affrontò
Burgundi e
Vandali, che
erano venuti in soccorso delle altre tribù germaniche e li
sconfisse in Rezia nei pressi del fiume Lech (chiamato da Zosimo
"Licca"). Al termine degli scontri furono accordate le
stesse condizioni concesse ai Lugi (con la restituzione dei
prigionieri romani e del bottino razziato nelle province romane), ma
quando i barbari vennero meno alle intese, trattenendo una parte dei
prigionieri, l'imperatore li affrontò nuovamente e sconfisse duramente la coalizione
germanica. I Romani catturarono anche il loro
capo Igillo e Probo, per queste vittorie, assunse
l'appellativo di "
Germanicus maximus".
 |
| La Mesia nel 250, da: QUI. |
Nel 280 -
Diocle (244 - 311), il
futuro imperatore Diocleziano, ottiene l'incarico di
dux Moesiae, ossia
comandante dell'esercito stanziato in Mesia, regione corrispondente
all'odierna Serbia e vigila dunque le frontiere del basso Danubio. Nato in Dalmazia e di umili origini illiriche,
Diocle aveva scalato i ranghi dell'esercito romano fino a divenire
comandante di cavalleria sotto l'imperatore Marco Aurelio Caro
(282-283), poiché con le riforme
apportate da Gallieno era
mutata l'
estrazione sociale sia dei
comandanti militari e dei loro diretti subalterni, già monopolio
aristocratico, che quella degli
ufficiali intermedi, un tempo
privilegio dell'ordine equestre. Dal 260 il
comando delle
legioni
e la carica di tribuno militare era assegnata a ufficiali di carriera
spesso di
bassa origine sociale ed era ora possibile, anche per un
semplice legionario che si distinguesse per abilità e disciplina,
scalare i diversi gradi dell'esercito: centurione, protector, dux fino a praefectus, comandante
militare. Diocle era entrato nell'esercito romano poiché l'Illirico era una regione privilegiata di reclutamento di militari e ufficiali di grado inferiore e durante il III secolo, essere un legionario significava, per gli
humiliores, entrare a far parte
della superiore categoria degli
honestiores.
Nel 282 - L'imperatore Probo è rovesciato e ucciso e il prefetto
del pretorio, Marco Aurelio Caro è proclamato imperatore. Diocle è nominato domesticos regens, comandante dei
protectores domestici, la guardia a cavallo dell'imperatore e l'anno seguente sarà nominato console suffetto (in sostituzione del console ordinario).
Nel 283 - Diocle prende parte alla spedizione dell'imperatore Caro contro
i Sasanidi persiani. I Romani ottennero una facile vittoria sul nemico, poiché il sovrano sasanide Bahram II era impegnato a sedare una
rivolta capeggiata dal fratello Ormisda e da alcuni nobili, ma l'imperatore Caro morì improvvisamente
(nel luglio/agosto 283) senza poter consolidare il successo ottenuto a
seguito della conquista della capitale persiana Ctesifonte.
Nel 284 - Il figlio e successore di Caro, Numeriano, consigliato dallo suocero, il
prefetto del pretorio Arrio Apro, preferisce ricondurre l'esercito
romano sulla via del ritorno, lungo l'Eufrate. Nel marzo 284 si trovavano ad
Emesa, in Siria e Numeriano era vivo e in buona salute (qui, infatti, promulgò l'unico suo rescritto conservatosi), ma quando lasciò la città, i suoi collaboratori dissero che era affetto da un'infiammazione agli occhi per cui avrebbe continuato il viaggio in una carrozza chiusa. A novembre erano ancora in Asia Minore e giunti
in Bitinia, alcuni soldati sentirono un cattivo odore provenire dalla
carrozza; l'aprirono, e vi trovarono il cadavere di Numeriano, morto da diversi giorni. I generali e i tribuni si riunirono per deliberare sulla successione, e scelsero
Diocle come imperatore. Il 20 novembre 284 Diocle fu proclamato
imperatore dai suoi colleghi generali su di una collina a 5 km da
Nicomedia. Poi, di fronte all'esercito che lo acclamava Augusto, il
nuovo imperatore giurò di non aver avuto alcuna parte nella morte di
Numeriano e che fosse stato Apro ad uccidere l'imperatore e che avesse poi tentato di
nasconderne la morte. Detto questo, Diocle estrasse la spada e
uccise Apro. È possibile che Diocle sia stato a capo di una congiura
di generali che volessero liberarsi sia di Numeriano, giovane più votato
alla poesia che alle armi, che dello suocero Apro. Infatti, Diocle non volle apparire come il vendicatore di
Numeriano, piuttosto ne fece cancellare il nome da molte epigrafi
ufficiali, mentre il panegirista Claudio Mamertino esaltò Diocleziano come liberatore «da una crudelissima dominazione».
 |
| Diocleziano |
Poco dopo la morte
di Apro,
Diocle mutò il proprio nome nel più latinizzante
Diocleziano (Cesare Gaio Aurelio Valerio Diocleziano Augusto Iovio) e governò dal 20 novembre 284 al 1º maggio 305. Rimaneva da
risolvere la divisione del potere con il fratello maggiore di
Numeriano,
Carino, che dopo la morte del padre si era
rapidamente diretto a Roma e aveva assunto il consolato per la terza
volta. Carino, fatto divinizzare Numeriano, dichiarò Diocleziano
usurpatore e con il suo esercito si mosse verso Oriente. Lungo il
percorso, nei pressi di Verona, sconfisse in battaglia e uccise
il governatore Marco Aurelio Sabino Giuliano, che si era proclamato
imperatore. La rivolta di Giuliano (e la sua tragica conclusione)
fornirono a Diocleziano il pretesto per presentare Carino come un
tiranno crudele e oppressivo e assunse a sua volta il consolato, scegliendo
Cesonio Basso come
collega, che proveniva dalla famiglia senatoria campana dei
Caesonii ed era stato già console e proconsole d'Africa per tre
volte, dunque di un politico dotato di quell'esperienza degli affari di
governo di cui Diocleziano difettava. Con la scelta
di assumere il consolato con un collega
proveniente dai ranghi del
Senato, intendeva rimarcare la sua opposizione al regime di Carino, rispetto al quale rifiutava qualsiasi forma di subordinazione,
dimostrando la volontà di continuare la
collaborazione con
l'
aristocrazia senatoriale e
militare, del cui sostegno necessitava
per concretizzare il proprio successo sia al presente (mentre
marciava su Roma) che in futuro, per consolidarsi al potere. Nell'inverno 284/285 attraversò i Balcani diretto a ovest per affrontare Carino.
Nel 285 - Lo scontro risolutivo avvenne nella
primavera del 285, nella
battaglia del fiume
Margus nei pressi dell'odierna Belgrado, in Serbia. Malgrado
Carino disponesse di un esercito più consistente, lo dispose in una posizione più sfavorevole rispetto al
dispiegamento adottato da Diocleziano che prevalse sull'avversario. Secondo gli storici antichi, Carino fu
ucciso da uno dei suoi ufficiali, di cui aveva sedotto la moglie, mentre gli
storici moderni ritengono che sia morto a seguito del
tradimento perpetrato dal suo prefetto del pretorio e collega di consolato Aristobulo, che l'assassinò all'inizio della battaglia, essendo passato dalla parte di Diocleziano e ottenendone la riconferma delle sue cariche. Al
termine della battaglia, Diocleziano, ricevuto un giuramento di
fedeltà tanto dalle legioni vincitrici quanto da quelle appena
sconfitte, che
lo acclamarono Augusto, partì per Roma e insediatosi al
potere,
convinto che il
sistema di governo
dell'Impero fosse ormai
inadeguato ad amministrare
un così vasto territorio le cui frontiere erano sottoposte
alla minacciosa e crescente pressione di popoli ostili,
si risolse a
crearne uno
congeniale alle mutate necessità. Con l'avvento di
Diocleziano al potere
ebbe fine il periodo noto come crisi del
terzo secolo, che con l'
anarchia militare,
protrattasi per quasi
un cinquantennio, aveva visto succedersi un elevato numero di
imperatori la cui ascesa e permanenza al potere
dipendeva esclusivamente dalla
volontà dell'
esercito. Per porre fine all'instabilità, Diocleziano mise in atto una serie di profonde riforme
politiche e amministrative, tra cui la
condivisione dell'
Impero tra più colleghi.
 |
| Massimiano |
Nel 286 - L'
Impero Romano, per la prima volta, è
diviso fra impero d'
Oriente e impero d'
Occidente. Ottenuto il
potere, nel novembre del 285, Diocleziano nominò suo
vice
(col titolo di
Cesare) un valente ufficiale, Marco Aurelio Valerio
Massimiano Erculio (Sirmio, 250 circa - Massilia 310), che pochi mesi più tardi elevò al rango di Augusto (suo pari) il 1º aprile 286: formò così una
diarchia, nella
quale i
due imperatori si dividevano su base geografica il
governo dell'Impero e la responsabilità della difesa delle frontiere
e della lotta contro gli usurpatori. Introducendo il
nuovo sistema di governo,
Diocleziano si attribuì il titolo
di
Augusto d'Oriente, stabilendo la propria capitale a
Nicomedia, e nominò
Augusto d'Occidente Massimiano,
che scelse come capitale
Mediolanum (Milano), più vicina al confine con i territori "caldi" di Roma. Marco Aurelio
Valerio Massimiano Erculio, noto più semplicemente come Massimiano, (Sirmio 250 circa - Massilia luglio 310) fu co-imperatore di Diocleziano, le cui arti
politiche erano complementari alle capacità militari di Massimiano. Nel corso del III
secolo già altri imperatori, in più di un'occasione, avevano
preferito a Roma (resa dalla posizione geografica troppo
distante dalle turbolenti frontiere renana e danubiana), quelle città
(come
Milano) che gli consentissero di raggiungere rapidamente
le zone di volta in volta minacciate. Con Diocleziano questo dato di
fatto fu in qualche modo istituzionalizzato.
Roma restò
comunque il riferimento ideale dell'Impero, rimanendo la sede di
quelle istituzioni (come il
Senato) ridottesi a rivestire un
ruolo puramente
simbolico a seguito di un secolare processo di
erosione delle proprie originarie prerogative. Il
potere effettivo
era oramai circoscritto all'
imperatore e alla
cerchia
dei suoi più stretti
collaboratori (
consilium e poi
consistorium), nei
nuovi centri amministrativi dell'Impero
(Milano in
Occidentis; Nicomedia e poi Costantinopoli in
Orientis).
Per eventuali approfondimenti vedi "Storia dell'Europa n.33: dal 257 al 286 e.v. (d.C.)"
QUI.
- L'imperatore Massimiano istituisce un
regno vassallo dei
Franchi, al quale viene affidata la difesa della frontiera contro gli altri Germani. I Germani così, in questo caso i Franchi, oltre ad essere arruolati individualmente o a gruppi nei corpi regolari ed ausiliari dell'esercito, cominciano ad entrare al servizio di Roma come federati, conservando la loro organizzazione, i loro capi nazionali, la loro lingua e i loro costumi, ciò che li renderà
tanto meno assimilabili e tanto più
pericolosi per la compagine dell'impero.
Nel 291 - Viene attestata per la prima volta la suddivisione fra i Goti. La prima citazione dei
Tervingi risale all'incirca a questo periodo in un elogio all'imperatore Massimiano (285 -
305), scritto nel 291 o poco dopo (forse a Treviri il 20 aprile 292),
ascritto tradizionalmente a Claudio Mamertino, il quale affermava che i
"Tervingi, un'altra divisione dei Goti" (Tervingi pars
alia Gothorum) si erano alleati con i Taifali per attaccare i Vandali
ed i Gepidi. Il termine "Vandali" potrebbe essere
un'erronea citazione dei "Victohali", visto che
secondo Eutropio la Dacia era in quel periodo (nunc
=
adesso) abitata da Taifali, Victohali e Tervingi.
Nel 293 - Viste le crescenti difficoltà a contenere le numerose rivolte interne e
lungo i confini,
Diocleziano, che già aveva diviso in due parti l'amministrazione dell'Impero, condividendo il potere con Massimiano, un Augusto per parte, nel 293 procede ad un'
ulteriore divisione
territoriale, dimezzando le due parti, per cui a capo delle due nuove entità territoriali era assegnato un Cesare, una sorta di vice-Augusto. Ora si contavano quindi quattro gerarchi a capo dell'impero, due Augusti e due loro vice, i Cesari: la
tetrarchia, struttura di governo di
tipo "quadricefalo" al cui vertice erano collocati
due
imperatori (col titolo di
Augusto) ciascuno a capo dei
due territori in cui l'Impero era stato diviso, Occidente ed
Oriente, coadiuvati da
due Cesari di loro
scelta, che esercitavano un controllo quasi diretto sulla metà del
territorio governato dal rispettivo Augusto, al quale erano
destinati
a succedere. Tra il 293 e il 295, il Cesare di Diocleziano,
Galerio, sconfigge gli
Eruli con i
Franchi e i
Batavi.
 |
Carta dell'Impero Romano dal 293 al
305, ripartito fra 4 governanti
distinti
in 2 Augusti e due Cesari, loro vice e
successori. Le diocesi sono i
raggruppamenti di province, aree
fiscali per la tassazione.
|
La tetrarchia
introdusse un sistema di
successione al trono imperiale che evitasse eventuali lotte. Il sistema si
rivelò efficace per la stabilità dell'impero e rese possibile agli
augusti di celebrare i
vicennalia, ossia i vent'anni di regno,
come non era più successo dai tempi di Antonino Pio. Tutto il
territorio venne ridisegnato dal punto di vista amministrativo,
abolendo le
regioni augustee con la relativa divisione in
"imperiali" e "senatoriali". Vennero create
dodici circoscrizioni amministrative (le "
diocesi",
tre per ognuno dei tetrarchi), rette da vicarii e a loro volta
suddivise in 101 province, aumentate di numero. Le varie diocesi
furono a loro volta raggruppate in quattro regioni più ampie,
denominate
prefetture, ciascuna governata da un personaggio di
dignità imperiale (prefetto del pretorio). In tal modo, venne a
cadere qualsiasi residuo di
privilegio dell'
Italia, che si trovò
completamente equiparata alle altre parti dell'Impero. In campo economico si prese atto delle trasformazioni
avvenute e per
arrestare la
crisi, il sistema fiscale
fu razionalizzato
eliminando antiche
esenzioni e
privilegi. L'amministrazione civile, a cui venne affidata la riscossione
delle imposte, venne riorganizzata, con nuove suddivisioni
amministrative e nettamente separata da quella militare. Le
riforme
volute da
Diocleziano e i successi militari ottenuti,
consentirono di ridare
pace e
sicurezza all'impero. Il sistema tetrarchico terminerà solo nel 324, con Costantino I.
 |
| Galerio |
Diocleziano,
augusto
d'oriente, nominò
Galerio come suo
cesare per
l'oriente. Proveniente da una modesta famiglia illirica, Galerio
salì rapidamente la gerarchia nell'esercito romano fino ad essere
notato dall'imperatore Diocleziano, di cui sposò la figlia Valeria e
di cui divenne cesare il 1º marzo 293, ricevendo il controllo delle
province orientali dell'Impero romano, detenuto in oriente dallo
stesso Diocleziano. Nella veste di cesare d'Oriente condusse delle
campagne, lungo il limes danubiano, contro Sarmati, Carpi e Bastarni
nel 294-296, per poi conseguire una grande e prestigiosa vittoria
contro i Sasanidi sul limes orientale, a seguito della quale i Romani
ottennero condizioni di pace estremamente favorevoli nel 298. Pagano
ed estremamente critico della religione cristiana, approvò, se non
addirittura ispirò, la persecuzione dei cristiani decretata nel 303
dal suo superiore Diocleziano.
Massimiano fu designato come
augusto per l'occidente.
 |
| Costanzo Cloro |
Massimiano nominò
cesare dell'occidente Flavio Valerio
Costanzo, (Illyricum 250 circa - Eboracum 306) passato alla storia
come
Costanzo Cloro da "chlorus", che significa
"pallido", un epiteto datogli dagli storici bizantini. Entrato nell'esercito romano, Costanzo Cloro aveva fatto carriera, ricoprendo le cariche di
protector sotto gli imperatori Aureliano e Probo,
tribunus, e
praeses Dalmatiarum (governatore della Dalmazia) sotto l'imperatore Caro. Aveva avuto un legame con Elena di Bitinia,
che gli aveva dato un figlio maschio, Costantino, nato all'inizio
degli anni 270. Nel 288 Costanzo era stato prefetto del
pretorio, il comandante militare, dell'imperatore Massimiano.
All'inizio di quell'anno Massimiano incaricò Costanzo di condurre
una campagna contro gli alleati
Franchi (Salii) di Carausio (un usurpatore
che deteneva il potere sulla Britannia romana), i quali
controllavano
gli estuari del Reno, impedendo attacchi via mare contro Carausio.
Costanzo si mosse verso nord attraverso il loro territorio, portando
distruzione e diffondendo panico e raggiunse il Mare del Nord.
 |
Carta dell'impero romano nel
293, quando Diocleziano
decide di suddividere il potere
fra 2 Augusti e 2 Cesari, loro
vice e successori: la tetrarchìa. |
I
Franchi chiesero la pace e con l'accordo conseguente Massimiano
rimise al potere il
deposto re franco Gennobaude. Essendosi distinto per la sua abilità militare, il 1º marzo 293, a Mediolanum, Massimiano nominò Costanzo proprio Cesare, un vice-imperatore per la parte occidentale dell'impero e Diocleziano fece lo stesso con Galerio: era nata la
tetrarchia, il "governo a quattro". A Costanzo, che
aveva sposato la figlia di Massimiano, Teodora, vennero assegnate la
Gallia e la Britannia e fu fatto capire che avrebbe dovuto avere
successo lì dove Massimiano aveva fallito: sconfiggere Carausio, ed
entro il 293 espulse le forze di Carausio dalla Gallia
settentrionale. Nella
prima tetrarchia l'
impero
fu così diviso in quattro macro-aree: 1) a Diocleziano, augusto d'oriente,
spettavano le province orientali dell'Egitto con capitale Nicomedia; 2) a Galerio, cesare d'oriente, le
province balcaniche con capitale Sirmio; 3) Massimiano, augusto d'occidente,
governava su Italia e Africa settentrionale con capitale Milano
(Mediolanum); 4) Costanzo Cloro, cesare d'occidente,
ebbe in affidamento la Spagna, la Gallia e la Britannia con capitale
Treviri (Augusta Treverorum).
 |
Sculture raffiguranti i 4
tetrarchi
trafugate dai veneziani
a Costantinopoli
nel 1201 durante
la IV crociata.
I canoni dell'arte
classica stanno
mutando in quella
che sarà
l'arte medievale. |
L'estensione dell'impero e la lunghezza dei confini rendeva inefficace un controllo centrale da Roma; inoltre scarseggiavano le milizie per garantire la sicurezza del "
limes", il confine, e si passò quindi ad utilizzare sempre più mercenari proprio da quelle popolazioni, perlopiù Germaniche, che periodicamente effettuavano incursioni nell'impero. Col tempo si assisterà a lotte fra i tetrarchi e fa i loro successori per dominare su tutto l'impero, fino alla supremazia di Costantino, poi detto il Grande.
Diocleziano scatena persecuzioni contro i cristiani. Le persecuzioni contro i Cristiani non avevano un fondamento giuridico specifico, l'unico appiglio legale che l'autorità imperiale poteva impugnare era la
lesa maestà dei
"mores", i costumi dei cristiani che non riconoscevano l'autorità divina all'imperatore, rifiutandosi di offrire incenso all'immagine della sua persona, e per questo
accusati poi di
ateismo. Nella cultura antica, così come
lo scritto era sacro, così
l'immagine evocava la presenza fisica del rappresentato. Nei tribunali
le immagini dell'imperatore
garantivano la sua
presenza e per tali motivi nell'ebraismo erano proibite le raffigurazioni di immagini e idoli: l'Islam stesso adotterà tali provvedimenti e nei secoli successivi si scatenerà nell'impero bizantino l'iconoclaustia che provocherà la distruzione delle immagini sacre. Molti
imperatori romani erano di
origine illirica; oltre agli imperatori-soldati (Claudio il Gotico, Aureliano e Marco Aurelio Probo) vi sono stati Gaio Decio, Diocleziano, Galerio e Costantino il Grande. Diocleziano, quando lasciò il potere, si ritirò nel
palatium,
il palazzo che fece costruire a Spalato, in Illiria, che da "palatium" prese il nome.
Nel 303 -
Eusebio di Cesarea, storico incline ad alterare la realtà dei fatti, scrive la sua "
Storia Ecclesiastica" dotata di tavole cronologiche. Nello stesso anno inizia (fino al 311) la
persecuzione di
Diocleziano contro i
cristiani, fra le più cruente che Roma abbia subito benché sia stata l'
ultima, considerata il
peggior errore di Diocleziano e che fra l'altro impedirà l'elezione di un nuovo vescovo per 4 anni. I cristiani si opponevano al potere tetrarchico poiché pretendeva il riconoscimento nell'imperatore, da parte dei sudditi, del loro "signore e dio" (
dominus ed deus). Il loro rifiuto al culto pubblico e del conseguente
sacrificio all'imperatore (che includeva il servizio militare e gli impieghi pubblici) minava fin dalle fondamenta l'ordinamento politico-religioso romano. La "
minoranza cristiana" alla fine del III secolo, secondo stime moderne, poteva contare
da 7 a 15 milioni di fedeli su una popolazione di 50 milioni di persone.
 |
Massimino Daia da: QUI.
|
Nel 305 - Viene messa alla prova il meccanismo della successione dei tetrarchi:
il 1º maggio del 305 Diocleziano e Massimiano abdicarono,
ritirandosi il primo a Spalato (da
palatium, il palazzo che si
era fatto costruire) ed il secondo in Lucania. La
seconda
tetrarchia prevedeva che i loro rispettivi due cesari
diventassero
augusti:
Galerio per l'
Oriente e
Costanzo
Cloro per l'
Occidente, provvedendo questi ultimi a nominare a
loro volta i propri successori designati, i nuovi cesari. Fu in questo
frangente che Costantino raggiunse il padre in Britannia (alcune
fonti vogliono che quella di Costantino sia stata una vera e propria
fuga da Nicomedia, dove Galerio avrebbe voluto trattenerlo per
garantirsi la fedeltà di Costanzo Cloro) e condusse con lui alcune
campagne militari nell'isola.
Galerio scelse
come
cesare dell'oriente
Massimino Daia. Gaio Galerio
Valerio Massimino Daia (270 circa - 313), nato in Dacia, era figlio di una sorella di Galerio. Nel
305, in seguito all'abdicazione degli augusti Diocleziano e
Massimiano in favore di Galerio e Costanzo Cloro, fu nominato cesare
e quindi suo successore da Galerio. Gli fu assegnato il
governo delle province balcaniche. Nel 308 costrinse lo zio Galerio
a conferirgli la nomina ad augusto insieme a Costantino. Sappiamo che
condusse una campagna militare vittoriosa in Armenia contro un
popolo che in passato si era dimostrato alleato dei Romani, ma che
ora abbracciava la religione cristiana, nemica dell'imperatore poiché
"estremamente rispettosa della pietà verso Dio". In
seguito alla sconfitta di Massenzio da parte di Costantino I, si
scontrò nel 313 con Licinio ma, sconfitto nella
battaglia di Tzirallum, si ritirò a Tarso dandosi la morte
strangolandosi con le sue stesse mani. Uomo ambizioso e
ostile ai cristiani, è descritto da Lattanzio come un creatore di
scandali e autore di condanne ingiuste. Anche Eusebio di Cesarea ne
traccia una pessima descrizione e vista la sua poca affidabilità, si possono considerare queste opinioni solo come propaganda diretta a colpire un
nemico di Costantino.
 |
Moneta del 305-307 con Flavio
Valerio Severo, Cesare dell'Augusto
Costanzo Cloro, da: QUI.
|
Costanzo Cloro
scelse come
cesare d'occidente
Flavio Valerio Severo, più
raramente noto come Severo II. Valerio Severo nacque nelle province
illiriche da una famiglia di umili origini. Era stato comandante
dell'esercito ed era amico di
Galerio; per sua intercessione fu coinvolto nella seconda tetrarchia. Nella
seconda tetrarchia l'
impero fu così
diviso fra: Galerio, augusto d'oriente; Massimino Daia, cesare d'oriente; Costanzo Cloro, augusto d'occidente e Flavio Valerio Severo, cesare d'occidente. Poco tempo dopo,
Costanzo Cloro rinunciò a parte dei suoi territori (
Italia e Africa) a vantaggio di Galerio, che si trovò a dover gestire due cesari: Massimino Daia a cui aveva affidato l'Oriente e Flavio Valerio Severo, a cui rimase l'Italia e forse l'Africa, mentre tenne per sé l'Illirico.
 |
La testa della colossale
statua di Costantino, nei
musei Capitolini di Roma.
L'arte sta mutando da
classica a medievale. |
Dal 306 - La
Guerra civile romana degli anni 306-324 è un lungo conflitto tra numerose fazioni
di pretendenti al trono imperiale (tra augusti, cesari ed usurpatori)
in diverse parti dell'Impero, al termine del quale prevale su tutti
Costantino I, che riuscirà a riunire il potere imperiale nelle mani di
un solo monarca dopo il periodo della Tetrarchia. Flavio
Valerio Aurelio Costantino, conosciuto come
Costantino
il Grande o
Costantino
I (Naissus, l'odierna Niš, in
Serbia, 27 febbraio 274 - Nicomedia, 22 maggio 337) di origine illirica, era figlio di Costanzo
Cloro (imperatore romano nel 305-306) e della sua compagna Elena,
moglie o forse concubina, che i cattolici venerano come sant'Elena
Imperatrice, forse nata a Drepanum, in Bitinia, nel golfo di
Nicomedia (nell'attuale Turchia); Costantino rinominerà infatti
la città Helenopolis, "città di Elena", in suo onore.
Non è noto quando Elena incontrò il suo futuro compagno, Costanzo
Cloro. Lo storico Timothy Barnes ha suggerito che l'incontro ebbe
luogo quando Costanzo, all'epoca al servizio dell'imperatore
Aureliano, era stazionato in Asia minore per la campagna contro il
Regno di Palmira. Costantino aveva una
statura
imponente, in grado di terrorizzare i suoi coetanei, ed era detto
“Trachala” per il suo
largo collo. Nel 288 suo padre
Costanzo era stato nominato Prefetto del pretorio (comandante
militare) delle Gallie da Massimiano, ed ebbe notevoli successi in
questo ruolo, tanto da riuscire a sconfiggere Carausio, un usurpatore
di origine franca che aveva conquistato il controllo della regione
del Reno. Grazie a questi successi nel 293, in base al sistema della
Tetrarchia voluta da Diocleziano, Costanzo Cloro venne nominato cesare dall'augusto
di Occidente, Massimiano, di cui sposò la figliastra Teodora.
Costantino, che aveva 19 anni, venne affidato all'Augusto d'Oriente, il quarantanovenne Diocleziano, che si assicurava così la fedeltà di Costanzo. Costantino fu formato a Nicomedia, presso la corte dell'imperatore, sotto il
quale iniziò la carriera militare: prima fu tribuno, viaggiò
in Palestina e partecipò alla guerra romano/danubiana contro i
Sarmati. Fu ancora con Diocleziano in Egitto nel 296 e quindi
combatté sotto Galerio, il cesare d'Oriente, contro i Persiani e i
Sarmati. Quando nel 305 Costanzo
Cloro divenne augusto d'occidente, Costantino raggiunse il padre
in Britannia (alcune fonti la descrivono come una fuga da Nicomedia, dove Galerio lo avrebbe trattenuto per garantirsi la fedeltà di Costanzo Cloro) e
condusse con lui alcune campagne militari nell'isola. Il 25 luglio 306,
Costanzo Cloro morì a Eboracum, nei pressi dell'attuale York; le fonti sulle cause della morte di Costanzo sono discordi, dall'uccisione in battaglia a morte in seguito a ferite oppure a misteriosa malattia. L'
esercito, guidato dal generale Croco (di origine
alemanna),
proclamava il figlio illegittimo di Costanzo Cloro,
Costantino, nuovo augusto di Gallia e Britannia. Fu un atto
d'usurpazione nei confronti di Severo, cesare d'Occidente destinato a diventare augusto, che metteva
a repentaglio il
meccanismo della tetrarchia, ideato da Diocleziano per
evitare che gli eserciti di proclamassero di propria iniziativa gli imperatori. A Roma intanto
Massenzio era proclamato
augusto al posto del successore
designato, sempre Severo, nei territori precedentemente governati dal padre
Massimiano, ossia l'Italia e l'Africa.
Galerio
intervenne,
offrendo a
Costantino di riconoscerlo non come augusto
ma come
cesare. Costantino accettò e tornò ad Augusta
Treverorum nell'autunno di quello stesso anno, da dove le frontiere
della Gallia, minacciate dai Franchi, sarebbero state meglio
controllate. Qui rimase il
limes
per i sei anni successivi, trasferendovi la propria corte imperiale e
trasformandola nella propria capitale (di 80.000 abitanti), come
risulta anche dall'imponente costruzione dell'Aula palatina, fatta
erigere dal padre e completata da Costantino nel 310. Lo
schema della
terza tetrarchia sarebbe stata quindi:
Galerio
augusto e
Massimino Daia cesare in Oriente, Flavio Valerio
Severo augusto e
Costantino cesare in Occidente.
Severo
divenne
augusto d'occidente nell'estate del 306 con potere limitato dall'usurpazione di
Massenzio, figlio di
Massimiano, che governava da Roma sia l'Italia che l'Africa e che per legittimarsi aveva inviato al padre
Massimiano delle vesti imperiali salutandolo come "Augusto per
la seconda volta", affinché governasse alla pari con lui, in realtà con meno poteri e di rango inferiore.
Nel 307 -
Galerio, non riconoscendo
Massenzio come augusto, invia a
Roma
Severo (da Mediolanum) con un esercito per deporlo, ma gran parte di quei soldati, avendo combattuto con Massimiano, accettano del denaro da Massenzio e disertano. Severo
fugge a Ravenna, dove è assediato da Massimiano, corso in
soccorso del figlio Massenzio; ma la città è ben fortificata e Massimiano offre delle condizioni per la resa a
Severo che le accetta ma viene
ucciso. Zosimo
scrisse invece che fu catturato da Massenzio, tra Spoleto e Terni, e impiccato.
 |
| Massenzio |
In autunno Galerio guida un
secondo esercito contro Massenzio, ma
non conquistando
Roma ritorna a nord con l'esercito praticamente intatto; si era
accorto infatti che i soldati non gli erano fedeli. Mentre Massenzio era
occupato a rafforzare le difese di Roma,
Massimiano si recava in
Gallia per negoziare con
Costantino; i due giunsero ad un accordo in
base al quale Costantino avrebbe sposato la figlia minore di
Massimiano, Fausta, e sarebbe stato elevato al rango di augusto nel
dominio secessionista di Massenzio. In cambio Costantino
avrebbe confermato l'antica alleanza famigliare tra Massimiano e
Costanzo, oltre a sostenere la causa di Massenzio in Italia, ma tenne
come punto fermo la sua neutralità nella guerra contro Galerio.
L'accordo fu stretto con una doppia cerimonia, tenutasi a Augusta
Treverorum nell'estate avanzata del 307, durante la quale
Costantino
sposò Fausta e fu
proclamato
augusto (del
dominio secessionista di Massenzio) da
Massimiano, che non era però riuscito a persuaderlo ad inseguire Galerio che si
ritirava dall'Italia, pur creando i presupposti per mettere
malumore tra il nuovo genero Costantino ed il figlio Massenzio,
con cui poi entrerà lui stesso in contrasto. Massenzio
continuava a tenere l'Italia e l'Africa sotto il suo dominio e cavalcava il
malcontento del popolo di
Roma e della Guardia
pretoriana, che vedevano declinare la loro importanza a vantaggio
delle capitali nelle province (Treviri nella Gallia Belgica,
Milano, Nicomedia, Antiochia, terza città dell'impero dopo Roma e
Alessandria) e a cui assicurava il
vettovagliamento di grano e olio dalla provincia africana; cercava di stabilizzare la sua posizione richiamando al potere il padre Massimiano e cercando
l'alleanza con Costantino, suo cognato.
Nel 308 - In primavera, Massimiano sfidò l'autorità del figlio, sforzandosi
di alienare a Massenzio le simpatie dei soldati per impadronirsi egli
stesso del potere. Davanti ad una assemblea di soldati romani,
Massimiano parlò del debole governo, di cui accusò Massenzio, e
strappò le vesti imperiali del figlio. Si attendeva che i soldati lo
acclamassero, ma questi si schierarono con Massenzio, e Massimiano fu
obbligato a lasciare l'Italia. Il 21 aprile 308, nonostante la
contrarietà di Galerio, Massenzio si proclamò Augusto
legittimo. Sempre nel corso
di quell'anno ebbe luogo una secessione africana guidata da
Lucio Domizio Alessandro, l'allora viceprefetto del pretorio, che un
paio d'anni dopo si alleerà esplicitamente con Costantino). Il
peggioramento dei rapporti con Massimiano (che passerà anch'egli
dalla parte di Costantino) e la morte del figlio Valerio Romolo nel
309 che privava il suo disegno imperiale di ogni possibilità di
continuità dinastica, rappresentano nella vicenda di Massenzio
l'inizio della fine. Il ripristino
della grandezza di Roma e dei suoi dèi fu al centro del progetto
imperiale di Massenzio. Oltre al restauro e innalzamento delle mura di Aureliano, che dotò anche di un
fossato, provvide a restaurare la via Appia fino a Brindisi e
diversi acquedotti. Nella sua tenuta sulla Via Appia edificò una
grande villa suburbana, dotata anche di un circo e di un mausoleo.
Accanto alla villa fu costruito il mausoleo del figlio defunto. Altra
maestosa testimonianza del suo prestigio è nella celebre Villa di
Piazza Armerina (Enna), a lui ascritta. Visto che l'anno
precedente era morto Severo, l'augusto d'occidente, l'11 novembre 308
si tenne a Carnuntum, sull'alto Danubio, un incontro a
cui parteciparono Galerio, che lo organizzò, Massimiano e
Diocleziano, richiamato da Galerio.
 |
Moneta del 309 con Costantino
e il Sol invictus |
 |
Testa della colossale statua
di Licinio, musei Capitolini.
Da: QUI. |
Sul posto è stata
rinvenuta un'iscrizione relativa all'evento: « Al dio Sole
invitto Mitra, sostenitore del loro impero, gli Augusti ed i Cesari,
Iovii ed Herculii, devotissimi, restaurarono il suo santuario ». In questa
occasione venne riorganizzata una
quarta tetrarchia di cui
Galerio rimaneva l'
augusto d'Oriente, Massimiano
fu obbligato ad abdicare da tutte le sue cariche, mentre
Costantino
fu nuovamente degradato a
cesare d'Occidente, pur ottenendo il
titolo di filius Augustorum, insieme a
Massimino Daia,
cesare
d'Oriente, mentre
Licinio, un leale commilitone di
Galerio, fu nominato
augusto d'Occidente. Valerio Liciniano
Licinio, talvolta detto Giovio Licinio (265 circa -
Tessalonica, 325), è stato imperatore romano dal 308 al 324. Nel 307
era stato inviato come ambasciatore di Galerio, assieme a Pompeo
Probo, presso Massenzio, per deporlo, ma l'ambasciata non sortì
effetti. Oltre al titolo, Licinio ricevette
anche il comando delle province dell'Illirico, Tracia e Pannonia. Al di fuori del quadro della quarta
tetrarchia si trovavano Massenzio, che deteneva effettivamente il
potere su parte dell'Occidente, e suo padre Massimiano, che sperava
di riottenere il potere che aveva perduto.
Nel 309 - Agli
inizi di quell'anno, Massimiano tornò alla corte di
Costantino in Gallia, l'unica
dove fosse ancora ben accetto, ottenendo incarichi
militari. Contemporaneamente la
morte del figlio di Massenzio, Valerio Romolo, privava Massenzio
stesso del suo disegno imperiale e di ogni possibilità di continuità
dinastica.
 |
Solidus aureo di Costantino
battuto a gr. 4,54. |
Nel 310 -
Massimiano,
durante operazioni militari in Gallia,
si ribella
all'autorità di Costantino,
mentre quest'ultimo era impegnato in una campagna contro i Franchi.
Massimiano era stato inviato verso sud, ad Arelate (l'attuale Arles
in Francia), con parte dell'esercito e il compito di difendere la
Gallia meridionale dagli attacchi di Massenzio. Giunto in città,
Massimiano annunciò la morte di Costantino e assunse la porpora
imperiale ma gran parte dell'esercito rimase leale a Costantino e
Massimiano fu obbligato a fuggire. Costantino, che all'annuncio del
tradimento (piano rivelato dalla moglie Fausta, figlia dello stesso
Massimiano) aveva abbandonato la sua campagna contro i Franchi e si
era rapidamente recato in Gallia meridionale, raggiunse il fuggitivo
a Massilia (Marsiglia, Francia), città adatta a sostenere un lungo
assedio. La sorte volle che alcuni cittadini aprirono le porte della
città a Costantino, permettendogli di catturare Massimiano e
costringendolo al suicidio. Nella parte occidentale dell'impero, quella di sua competenza, Costantino riforma radicalmente l'economia introducendo il
solidus in oro (da cui l'italiano soldo), dopo anni di grande inflazione e svalutazione della moneta, che ormai era coniata con metalli non nobili.
Nel 311 - Galerio cade vittima
di una lunga e dolorosa malattia; il suo ultimo atto politico
fu l'editto di tolleranza del 30 aprile 311, col quale mise
fine alla persecuzione dei cristiani, iniziata con Diocleziano
imperatore. Estremo difensore della tetrarchia, la sua morte nel
maggio del 311 ne segnò la fine. Alla
morte di Galerio, Massimino Daia si impadronì
dell'Oriente, lasciando a
Licinio l'Illirico. Ora l'impero romano era diviso in quattro parti
(Massimino Daia e Licinio in Oriente, Costantino e Massenzio in
Occidente) formando la quinta tetrarchia
solo di fatto, senza intese comuni. In realtà poco dopo Massimino,
Costantino e Licinio
si coalizzarono per
eliminare il primo dei quattro augusti: Massenzio. Contemporaneamente
Massenzio inviava una spedizione militare in Africa, guidata dal
prefetto del pretorio, Rufio Volusiano, con lo scopo di porre fine al
potere di Lucio Domizio Alessandro. Quest'ultimo dopo essere stato
sconfitto ad un primo assalto, fu catturato e strangolato. Massenzio
era riuscito così ad ampliare le sue conquiste, che celebrò con un
trionfo. Possedeva ora Italia ed Africa.
- Nello stesso anno inizia lo scisma Donatista (papa Milziade scomunicherà Donato due anni dopo), che motiverà l'Imperatore Costantino ad indire il primo Concilio di ampio respiro in Occidente (quello di Arles).
Nel 312 -
Costantino,
riunito un
grande esercito
formato anche da barbari catturati in guerra, oltre a Germani e a
popolazioni celtiche e provenienti dalla Britannia, muove alla volta
dell'Italia attraverso le Alpi, forte di 90.000 fanti e 8.000
cavalieri (25.000 complessivi invece per E.Horst), determinato a
spodestare Massenzio,
che si era proclamato augusto. Lungo la strada, Costantino, lascia intatte tutte le città che gli aprono le porte (come Mediolanum) e
al contrario assedia tutte quelle che non si arrendono subito, ma evita ove possibile di distruggerle per raccoglierne il
loro consenso una volta vinte, come a Susa e a Torino. Al
contrario, Massenzio assediava e distruggeva le città che si opponessero. Dopo aver sconfitto le
armate di Massenzio, prima presso Torino e poi presso Brescia,
Costantino pone sotto assedio Verona, dove sottomette la città e batte le forze di Massenzio comandate dal prefetto del
Pretorio Ruricio Pompeiano, che nello scontro perde la vita.
Occupata l'intera Italia settentrionale (compresa l'importante Aquileia) e non trovando altra resistenza lungo le via Flaminia, che porta a Roma, si scontra con l'esercito di Massenzio poco a
nord di Roma, prima presso i Saxa Rubra, poi nella
decisiva battaglia di Ponte Milvio, il 28 ottobre 312. Qui
Massenzio, pur potendo contare secondo Zosimo su 170.000 fanti e
18.000 cavalieri (tra i quali vi erano 80.000 tra Romani, Italici,
Tirreni e 40.000 Africani, oltre ai Siculi, invece di ripararsi
dietro le mura che aveva restaurato, uscì in battaglia contro al
suo avversario e ne fu sconfitto e ucciso, gettato nel Tevere dopo
essere stato decapitato. Con la morte di Massenzio, l'Italia
passa sotto il controllo di Costantino, mentre la guardia
pretoriana ed i castra praetoria di Roma erano soppressi.
 |
Raffigurazione
di Chi-Rho.
|
Durante questa
campagna sarebbe avvenuta la celebre e leggendaria
apparizione
della croce sovrastata dalla scritta “
In hoc signo vinces” (con questo segno vincerai), che avrebbe avvicinato Costantino al cristianesimo. Secondo l'inaffidabile Eusebio
di Cesarea, l'apparizione avrebbe avuto luogo nei pressi di
Torino. Lo scrittore cristiano Lattanzio, precettore dei
figli di Costantino, nel
“De mortibus persecutorum”, non menziona
alcuna visione
prodigiosa, ma riferisce che la notte prima della battaglia,
Costantino avrebbe ricevuto in sogno l'ordine di mettere sullo scudo
dei propri soldati un segnale celeste divino (
coeleste signum
dei), senza specificare chi avesse dato quell'ordine né quale
simbolo gli fosse stato ordinato di utilizzare.
 |
Con Vega come riferimento, dall'alto
in basso le costellazioni Cigno,
Aquila, Capricorno e Saggitario,
da QUI. |
Nel 1948, Fritz Heiland, dello Zeiss
Planetarium di Jena, (il planetario Zeiss di Jena, in Turingia,
Germania, è il più antico planetario a funzionamento continuo del
mondo, inaugurato il 18 luglio 1926. I pianeti e le stelle fisse sono
proiettati sulla superficie interna di una cupola bianca) ha
pubblicato una interpretazione della visione di Costantino, secondo
lui la visione di una congiunzione planetaria. Nell'autunno del 312,
tre pianeti luminosi, Marte, Saturno e Giove erano allineati fra il
Capricorno e il Sagittario. La congiunzione astrale poteva essere
interpretata dalle truppe come un presagio sinistro e Costantino si
sarebbe inventato la leggenda cristiana per trasformare questo
pericolo in un segno celeste di vittoria. Lo spettacolo celeste, a
cui avrebbe assistito Costantino col suo esercito, può essere
ricostruito col computer. All'ora del tramonto (alba e tramonto erano
i momenti più significativi secondo gli astrologi Romani, così come
per i Celti) sarebbe comparsa maestosa allo zenit la
croce del
Cigno. Proprio sotto di essa si trovava la costellazione
dell'
Aquila (simbolo di Roma e del suo esercito). Ancora più
in basso, fra le costellazioni del
Capricorno, la zona più a
sud del cielo boreale e quella del
Sagittario, si trovavano
allineati i principali pianeti:
Venere,
Giove,
Saturno
e
Marte, le
principali divinità pagane. Poco dopo il
tramonto del
Sole ( il
Sol invictus era un'altra
divinità), anche i pianeti tramontarono. Uno
scenario unico e molto
simbolico, che potrebbe
essere stato interpretato associando ad ogni pianeta una
lettera, come quelle della parola greca
nikà, “vinci”.
 |
Mosaico bizantino raffigurante
l'imperatore Costantino I, particolare, Basilica di Santa
Sofia (Instanbul, Turchia), da: |
Nel 313 - In febbraio Licinio
si reca a Mediolanum, per incontrare Costantino,
divenuto l'unico imperatore della parte occidentale dell'impero dopo aver sconfitto Massenzio: i due stringono un'alleanza,
rafforzata dal matrimonio di Licinio con la sorella di Costantino,
Flavia Giulia Costanza (da cui ebbe nel 315 il figlio Valerio
Liciniano Licinio) e promulgarono insieme l'Editto di
Milano, che garantisce ampia libertà di culto alle diverse religioni dell'Impero. L'Editto rappresenterà per la Chiesa un confine epocale tra l'era della semplicità e della spiritualità evangelica del periodo delle catacombe e quella della graduale acquisizione, almeno da parte delle sue gerarchie, di interessi terreni, materiali e politici, a scapito della funzione spirituale. A partire dall'Editto di Milano, la Diocesi di Roma diventa proprietaria di immobili e terreni, frutto delle donazioni dei fedeli, denominato Patrimonium Sancti Petri, già rilevante nel VI secolo. Costantino è Imperatore e Pontifex Maximus (titolo a cui non rinuncerà mai), pone termine alle persecuzioni ma nello stesso tempo tenta di controllare (e spesso vi riesce) le gerarchie della Chiesa. Dal 313 il vescovo di Alessandria usa per sé stesso il termine "Papa", titolo che i vescovi di Roma cominceranno ad usare intorno al 400. Dopo l'editto di Milano del 313 la diffusione del simbolo della croce si espande ed assume l'aspetto della "crux commissa" (T), o della "croce latina" (†) detta anche "crux immissa", o della croce greca a bracci uguali (+). L'alleanza tra Licinio e Costantino escludeva chiaramente il terzo imperatore, Massimino Daia, che si fece proclamare unico imperatore dalle truppe e mosse dalla Siria verso occidente con un esercito di 70.000 armati, conquistando Bisanzio dopo soli 11 giorni: Licinio lo affrontò e lo sconfisse nella battaglia di Tzirallum il 30 aprile di quell'anno. Massimino Daia, dopo aver provocato una nuova rivolta contro Licinio presso Tarso, qui morì, prevenendo la propria rovina. Restavano ora solo due augusti: Costantino per l'Occidente e Licinio per l'Oriente. Divenuto unico signore della parte
orientale dell'impero, Licinio si rese colpevole della purga che
colpì le famiglie dei tetrarchi: per suo ordine vennero uccisi
Candidiano, figlio di Galerio, Severiano figlio di Flavio Severo e
i figli di Massimino, di otto e sette anni. Dichiaratosi cristiano per fini politici sin dal periodo della sua rivalità con Massimino Daia, Licinio cominciò ad inimicarsi i cristiani con politiche insensatamente ostili,
ritenendo, in maniera non del tutto infondata, che appoggiassero Costantino contro di lui e quindi questi lo
abbandonarono nella fase decisiva del conflitto.
Per eventuali approfondimenti vedi "Storia dell'Europa n.34: dal 286 al 313 e.v. (d.C.)"
QUI.
Nel 316 - Licinio si scontra con
Costantino I: il casus belli fu la nomina a collega di
Aurelio Valerio Valente da parte di Licinio, che di fatto mostrava
come Licinio non considerasse più Costantino il legittimo signore
d'occidente. Costantino vinse però Licinio nella battaglia di
Mardia e, con la pace firmata il 1º marzo 317 lo costrinse a
cedergli l'Illiria e a condannare a morte Valente. La pace del 317 durò sette anni.
 |
Moneta del 327 con l'imperatore
Costantino e il monogramma di Cristo.
Da: QUI. |
Nel 321 - L'imperatore Costantino, in qualità di Pontefice Massimo, introduce
la settimana di sette giorni e decreta come giorno di riposo il
dies Solis (il "giorno del Sole", la nostra
domenica). Con l'affermarsi del cristianesimo, gli antichi culti, magici e tradizionali, sono sempre più officiati di nascosto, nei boschi e nei "
pagus", arroccamenti naturali o rupestri. Da qui i termini
pagani e
paganesimo. Il giorno
natale del
Sole e del
dio Mitra, il
25
dicembre, divenne anche quello della
nascita di
Gesù. Le statue del
dio Sole erano spesso adornate del simbolo della Croce, ma a
Costantinopoli furono eretti anche dei templi pagani. Il culto del
Sol invictus era diffuso nell'esercito, soprattutto
nell'occidente e ad esso non furono estranei né Costanzo Cloro né Costantino stesso, che fu il primo a
comprendere l'importanza della nuova
religione cristiana per
rafforzare la
coesione culturale e
politica dell'impero romano. La volontà imperiale di presentarsi
come un prediletto dal cielo, senza però mettere in chiaro quale
fosse la divinità, è definita
ambiguità costantiniana,
rilevata fin dalla battaglia di Ponte Milvio, in cui
Costantino si dimostra
attento a presentarsi
come
prescelto dalla
divinità,
qualunque essa
fosse.
Nel 324 -
Scontratosi una prima volta in Mesia, ad Adrianopoli,
con Costantino,
Licinio non riuscì ad approfittare della sua netta superiorità numerica, venendo di lì a poco sconfitto in una battaglia navale nell'Ellesponto da
Crispo,
figlio di
Costantino e di
Minervina. Minervina (fine III secolo - prima del 307) sposò Costantino quando questi era molto giovane, ed ebbe da lui un figlio, Crispo. Quando Costantino ebbe bisogno di rafforzare i suoi legami con i tetrarchi, sposò Fausta, figlia dell'imperatore Massimiano nel 307, ed è possibile che Minervina fosse in tale occasione ripudiata, ma è più probabile che fosse già morta.
Fausta Massima Flavia (Roma, 289
o 290 - Roma, 326), da Costantino ebbe
tre figli, Costantino II,
Costanzo II e Costante I, tutti succeduti al padre e
due figlie,
Costantina ed Elena. Nata e cresciuta a Roma, era la figlia più
giovane di Massimiano ed Eutropia. Nel marzo 307 sposò Costantino I,
probabilmente a Treviri: il marito era più vecchio di lei di almeno
quindici anni. Voluto come legame tra Costantino e il tetrarca, per
rafforzarne l'alleanza, il matrimonio di Fausta fu messo alla prova
da due eventi tragici, avvenuti a seguito dei contrasti di Costantino
con il padre e il fratello di Fausta. Nel 310, fu Fausta a svelare il
complotto di Massimiano contro Costantino, che farà uccidere il
suocero e nel 312, invece, all'indomani della vittoriosa Battaglia di
Ponte Milvio, Costantino fece mettere la testa del cognato Massenzio
su di una lancia e la fece girare per la città. Tornando a
Licinio, nella battaglia contro Crispo perse le sue migliori unità di soldati, per cui reclutò schiavi e contadini delle terre bitiniche per ingaggiare un'ultima, disperata battaglia contro le truppe veterane di Costantino (la cosiddetta battaglia di Crisopoli, svoltasi presso l'odierna Üsküdar), venendo disastrosamente sconfitto. Tratto prigioniero dinanzi a Costantino venne graziato da questi e inviato a vivere come privato cittadino a Tessalonica; negli anni seguenti però (nel 325/326), nonostante le promesse fatte a sua sorella che ne era la moglie,
Costantino fa
giustiziare Licinio per avere complottato una rivolta. Costantino rimase così l'
unico Augusto al
potere.
 |
Suddivisione in Chiese e patriarcati
nell'impero romano. |
Nel 325 -
L'imperatore
Costantino indice il
Concilio di Nicea dove, fra i tanti argomenti, il cristianesimo adotta come sua la tradizione della "Torah" e di altre scritture sacre ebraiche, oltre a quattro Vangeli epurati e corretti (come si può evincere dal confronto con le parti originali nei Rotoli del Mar Morto) come testimonianza, che formeranno la "Bibbia" (da Ta biblìa = i libretti) stabilendo quindi quali fossero i "
Libri ispirati da Dio". Nel concilio sono stabilite le regole per calcolare la Pasqua, celebrazione della divinità di Gesù confermata dalla resurrezione. Mentre gli ebrei celebrano la
“ Pesach”, la liberazione dall’Egitto, durante
il primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera, la Pasqua si festeggerà la domenica (nei Vangeli è scritto che il sepolcro vuoto di Gesù
Cristo fu scoperto il giorno successivo al sabato)
successiva al
primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera. Si definiscono quindi gli ambiti della nuova
autorità dei vescovi, capi delle comunità cristiane, che assumono connotati da magistrati imperiali, non pagando tasse all'impero pur incassando le decime,
il 10% dei redditi (come i sommi sacerdoti della tribù di Levi) delle loro curie (termine che anticamente indicava le assemblee cittadine) e ottenendo l'incarico di
giudici nei processi di diritto ordinario. Inizialmente (nel I sec.) i principali
centri cristiani della diaspora ebraica nell'Impero romano erano tre:
Antiochia, Alessandria e Roma, a parte Gerusalemme nella madrepatria.
I
patriarcati ufficiali della nuova Chiesa, con l'aggiunta della
nuova capitale e della città santa diventano così
cinque, riconosciuti
da concilio ed imperatore: patriarcato di Roma o d'Occidente
(il futuro papato), patriarcato di Antiochia, patriarcato di Alessandria,
patriarcato di Costantinopoli e patriarcato di Gerusalemme. Ne esistevano anche altri, ma essendo fuori dall'Impero non erano politicamente utili e potenzialmente concorrenti. Il vescovo e patriarca di Roma si insedierà nel palazzo del Laterano e rivendicherà il primato della sua sede poiché era stata dell'apostolo Pietro, il primo vescovo di Roma, sancito da Gesù in Matteo 16:18 e che dal 375 comunque, otterrà dall'imperatore Graziano la carica di Pontefice massimo, che diventerà sinonimo di «
papa», titolo che portava anche il patriarca di Alessandria. Dal punto di vista dottrinale, le discordie erano assai radicate nella comunità cristiana e il Concilio di Nicea del 325 rappresentò un momento importante di questo confronto, nato dalla constatazione che il
tema cristologico (temi riguardanti la natura di Gesù Cristo, la sua divinità, i suoi rapporti con la tradizione giudaica e con il monoteismo precristiano) aveva ormai assunto un
rilievo politico. Si affermava quindi la
consustanzialità, cioè la stessa natura, del
Padre e del
Figlio, come si recita nella preghiera "Credo", chiamato appunto niceno e quelle che avessero sostenuto dottrine diverse, sarebbero divenute "chiese scismatiche".
Costantino, adoratore del Sole Invitto, supervisionava il tutto esercitando, come imperatore l'autorità di Pontefice massimo: gli stava a cuore il dominio sia politico-militare che religioso sull'impero e cercava di organizzare ed istituzionalizzare la nuova fede religiosa per saldarla alla tradizione romana. Era necessario divinizzare Gesù e a tal fine era stata aggiunta nei Vangeli la Resurrezione e per separarsi definitivamente dall'Ebraismo, da una parte si accusavano i Giudei di "deicidio" e dall'altra si poneva l'accento sul legame fra Cristo e Roma tramite Pietro, investito secondo le scritture ad essere la pietra fondante della Chiesa a Roma stessa. Prende quindi forma una nuova
Chiesa, che non è più solo il nome della comunità cristiana, ma anche un
vertice di funzionari che da una parte
gestiscono potere politico, economico e giudiziario e dall'altra si ergono a tramite fra i fedeli e la divinità, coronando così gli sforzi di
Paolo di Tarso, che
aveva minacciato perfino l'apostolo Pietro ad adeguarsi ad una strategia di controllo sulla comunità dei cristiani, sia che fossero essi ebrei o gentili. L'ebreo Saul di Tarso (S. Paolo), diventerà così, insieme a Simon-Pietro, fondante per la
Chiesa "
Cattolica" (cioè
Universale) e quindi Apostolica. L'
Imperatore Romano aveva
fondato una
Chiesa Romana. Le
dottrine cristologiche (dottrine riguardanti la natura di Gesù Cristo, la sua divinità, i suoi rapporti con la tradizione giudaica e con il monoteismo precristiano) dei primi secoli vengono vagliate nel concilio e sono stabiliti i "fondamentali" della Chiesa. Un anno dopo il Concilio di Nicea, avverrà la
confisca e la
distruzione di tutte le
opere che mettevano in discussione i fondamenti approvati dal Concilio: le opere
degli autori pagani che parlavano di Gesù e quelle dei cristiani
eretici. Il
capolavoro di Costantino I il Grande, poi fatto Santo, era dunque compiuto. Il Concilio dovette inoltre bollare come eresie alcune pericolose deviazioni dall'ortodossia nicena che avrebbero potuto destabilizzare il nuovo afflusso della cristianità nelle istituzioni statali, ne seguono alcune:
- L'Arianesimo, il movimento teologico più rilevante del IV secolo. Secondo Ario, sacerdote di Alessandria d'Egitto (256-336), la figura del Padre si collocava in posizione preminente all'interno della Trinità e il Figlio era subordinato al Padre e riduceva così la figura di Gesù alla dimensione umana, solo somigliante a quella divina.
- Il Donatismo, da Donato di Case Nere (nel 315 vescovo di Cartagine), movimento che nasce e si sviluppa in Africa nel IV secolo e che critica quei vescovi che non avevano resistito alle persecuzioni di Diocleziano ed avevano consegnato ai magistrati romani i libri sacri. Secondo i donatisti, i sacramenti somministrati da quei sacerdoti non avrebbero avuto validità, considerando quindi i Sacramenti non efficaci di per sé, ma dalla dignità di chi li dispensa.
-
Lo
Gnosticismo, un movimento filosofico-religioso molto articolato, la cui massima diffusione si ebbe tra il II e il IV secolo. Il termine gnosticismo deriva dalla parola greca
gnósis, «
conoscenza» e quel movimento adottava quindi una "
dottrina della salvezza tramite la conoscenza". Mentre il giudaismo sostiene che l'anima raggiunge la salvezza attraverso l'osservanza delle 613 mitzvòt e il cristianesimo sostiene che l'anima raggiunge la salvezza dalla dannazione eterna per Grazia mediante la Fede (Efesini 2,8), per lo gnosticismo invece la salvezza dell'anima dipende da una forma di conoscenza superiore e illuminata (gnosi) dell'uomo, del mondo e dell'universo, frutto del
vissuto personale e di un percorso di ricerca della Verità.
- Il Manicheismo è la religione fondata in Persia da Mani (215-277), predicatore e teologo nato nel regno dei Parti e vissuto nell'Impero sasanide, religione universale che fondeva le caratteristiche dello Zoroastrismo, del Cristianesimo (probabilmente con influenze di seguaci di Marcione e Bardesane) e del Buddismo, che Mani aveva conosciuto durante un viaggio in India. Il Manicheismo è radicalmente dualista: due princìpi, la Luce e le Tenebre, indipendenti e contrapposti che influiscono in ogni aspetto dell'esistenza e della condotta umana.
- Il Marcionismo da Marcione (85-160), vescovo nato a Sinope sul Mar Nero, fondatore di questa dottrina di cui alcuni Padri della Chiesa (Epifanio di Salamina) indicano in Cerinto un suo maestro. La Chiesa marcionita era probabilmente ben organizzata, con un clero ("i perfetti") accuratamente preparati e che conducevano una vita contemporaneamente attiva e duramente ascetica. Sopravvisse per secoli e continuò in vari movimenti tardi, come Bogomili e Càtari (vedi Manichei medievali).
 |
Aquila bicipite o a due teste, che
simboleggiavano le due parti,
Occidente e Oriente dell'impero,
emblema dell'impero romano adottato
da Costantino il Grande. Da: QUI. |
Nel 326 -
Iniziano i lavori per la
costruzione della nuova capitale Nova Roma (
Nuova Roma) sul sito dell'antica città di Bisanzio, fornendola di un senato e di uffici pubblici simili a quelli di Roma. Il luogo venne scelto come capitale nel 324 per le sue qualità difensive e per la vicinanza ai minacciati confini orientali e danubiani. Inoltre, particolare non secondario, consentiva a Costantino di sottrarsi all'influenza invadente, arrogante ed irritante, degli aristocratici presenti nel senato romano. La città venne inaugurata nel 330 e prese presto il nome di
Costantinopoli. Rispetto alla vecchia città, la nuova era quattro volte più vasta: dove c'era un'antica porta Costantino pose un foro circolare, inoltre spostò le sue mura più ad occidente di 15 stadi. La città (oggi
Istanbul, nome che appare ufficialmente dal 1930 e che deriva dal greco “
isten polis”, cioè "quella è la città") resterà poi fino al 1453 la capitale dell'Impero romano d'Oriente, chiamato dai latini impero bizantino. L'aquila bicipite è, in araldica, l'aquila con due teste separate fin dal collo e rivolte una verso destra ed una verso sinistra. Generalmente la si pone nel capo d'oro, detto capo dell'Impero. Infatti l'aquila bicipite identifica l'unione di due imperi.
L'aquila bicipite fu
adottata come
stemma imperiale per la
prima volta dall'imperatore romano
Costantino I, detto il Grande, e rimase poi come stemma nell'Impero romano d'oriente fino all'ultima dinastia di imperatori bizantini: quella dei Paleologi. Lo stesso stemma fu poi usato dagli Arsacidi, re d'Armenia e più avanti dagli Asburgo, imperatori d'Austria poi dai Romanov, zar di tutte le Russie. Anche i re di Serbia, i principi di Montenegro e l'eroe albanese Giorgio Castriota Scanderbeg, adottarono l'aquila bicipite come emblema. Secondo alcuni autori
una testa rappresenta l'
Occidente e l'altra l'
Oriente.
- Il 326 è stato caratterizzato
da una serie di uccisioni. Dopo quella del suo antico alleato
e rivale Licinio, Costantino fa uccidere a Pola il
suo figlio primogenito, Crispo, la cui madre era stata
Minervina, la prima moglie di Costantino. Secondo alcune fonti, Fausta, sorella di Massenzio e moglie di Costantino, avrebbe
accusato il figliastro Crispo di averla voluta sedurre o forse voleva assicurarsi l'eliminazione dei rivali dei propri figli come successori di Costantino. Poco dopo Costantino, convintosi dell'innocenza del figlio,
l'avrebbe fatta morire affogandola in un bagno portato a una
temperatura più alta del normale. Secondo una diversa versione la
sua morte venne invece causata dal sospetto di adulterio fra i due. Fausta subì
la damnatio memoriae, una locuzione che significa
letteralmente "condanna della memoria", che nel diritto
romano indicava una pena consistente nella cancellazione di
qualsiasi traccia riguardante una persona, come se non fosse mai
esistita. Da Fausta, Costantino aveva avuto tre figli,
Costantino II, Costanzo II e Costante I, tutti succeduti al padre e
due figlie, Costantina ed Elena. Nello stesso periodo venne ucciso inoltre Liciniano, figlio della sorella di Costantino, Costanza, e di Licinio.
Per eventuali approfondimenti vedi "Storia dell'Europa n.35: dal 313 al 326 e.v. (d.C.)"
QUI
 |
| Pianta dell'antica Costantinopoli. |
Nel 330 - "
Nuova Roma", chiamata poi, col tempo,
Costantinopoli (che significa città di Costantino), è la
capitale dell'
Impero Romano, e il suo vescovo inizia a pretendere prerogative primaziali.
Costantino, adoratore del "Sole Invincibile", pare che si sia convertito al cristianesimo solo sul letto di morte, per potere perpetrare tutti quelli che dai cristiani sono visti come "peccati mortali", fra cui l'omicidio del co-imperatore Licinio, di Fausta, la sua seconda moglie, del suo figlio primogenito Crespo ecc., anche se Costantino è considerato santo e
"simile agli apostoli" dalla Chiesa ortodossa, da alcune
Chiese orientali antiche e in alcune località oggi romano-cattoliche
di rito latino, come Sedilo in Sardegna. Mentre in quei tempi la popolazione cristiana era
circa il 10% nell'occidente dell'Impero Romano, è fuori di
dubbio la sincerità costantiniana nella ricerca dell'unità e
concordia della Chiesa, la cui necessità derivava da un
preciso disegno politico che considerava l'
unità del
mondo
cristiano condizione indispensabile alla
stabilità della
potenza imperiale. Costantino infatti interpretava in senso
cristiano l'antico tema, caro alla Roma imperale pagana, della
pax
deorum, nel senso che la
forza dell'
impero non
derivava
semplicemente dalle azioni di un principe illuminato, da una saggia
amministrazione e dall'efficienza di un ben strutturato e
disciplinato esercito, ma direttamente dalla
benevolenza di
Dio. Costantino non poteva fare a meno di essere coinvolto nelle lotte
teologiche della Chiesa auspicando l'unità e la concordia dei cristiani anche con interventi molto duri nei confronti di coloro che lo stesso
imperatore considerasse eretici, trattati più
duramente dei pagani. I conflitti teologici si trovarono dunque ad
avere una ricaduta politica, mentre d'altra parte le sorti interne
dell'Impero erano sempre più dipendenti dai risultati delle lotte
teologiche; gli stessi
vescovi, infatti,
sollecitavano
continuamente l'
intervento dell'
imperatore per la corretta
applicazione delle decisioni dei concili, per la convocazione dei
sinodi e anche per la definizione di controversie teologiche: ogni
successo di una fazione comportava la deposizione e l'esilio dei capi
della fazione opposta, con i
metodi tipici della
lotta politica.
Nel 331 - Eusebio di Cesarea, nel libro “Sulla
vita di Costantino”, afferma che nell’anno 331 d.C.
Costantino
gli
chiese personalmente
50 copie della Bibbia cristiana per le
chiese che stava facendo costruire a Costantinopoli, come dimostrano
i manoscritti biblici risalenti proprio a quel periodo: il codice
Sinaitico e il codice Vaticano. Questo fu uno dei fattori decisivi nell'intera storia del cristianesimo e offrì un'occasione senza precedenti per l'affermazione dell'ortodossia cristiana, poiché nel 303, un quarto di secolo prima, l'imperatore pagano
Diocleziano aveva
ordinato di
distruggere tutti gli
scritti cristiani che era possibile trovare. Quindi i documenti cristiani, soprattutto a Roma, erano quasi spariti. Quando Costantino commissionò nuove versioni di questi documenti, permise ai custodi dell'ortodossia di revisionare, modificare e riscrivere il materiale come ritenevano più opportuno, secondo i loro obiettivi, più legati alla gestione del potere che ad una gestione dell'aldilà. Fu a questo punto che vennero apportate probabilmente quasi tutte le alterazioni decisive al Nuovo Testamento e
Gesù assunse la
posizione eccezionale che ha avuto da allora. Non si deve sottovalutare l'importanza della commissione costantiniana: delle cinquemila versioni manoscritte più antiche del Nuovo Testamento, nessuna è anteriore al IV secolo. Il Nuovo Testamento nella sua forma attuale, è sostanzialmente il prodotto dei revisori e degli scrittori del IV secolo, custodi dell'ortodossia, con precisi interessi da difendere. Fortunatamente nel 1976 un cospicuo numero di antichi manoscritti fu scoperto nel monastero di Santa Caterina sul monte Sinai, per cui disponiamo ora di
migliaia di frammenti, alcuni dei quali anteriori al 300 d.C., oltre naturalmente ai reperti ritrovati nelle grotte del Mar Morto, i Manoscritti di Qumran
e il ritrovamento degli scritti di
Nag Hammâdi.
 |
Correzioni aggiunte nel codice
sinaitico. |
Il
Codice Sinaitico (Codex Sinaiticus), ritrovato da Konstantin von Tischendorf presso il Monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai, in Egitto, tra il 1844 e il 1859, il più antico monastero cristiano ancora esistente che sorge alle pendici del monte Horeb, dove Mosè avrebbe parlato con Dio, originariamente conteneva l'intero Antico Testamento nella versione greca della Settanta, l'intero Nuovo Testamento e altri scritti cristiani (Lettera di Barnaba, Pastore di Erma).
 |
| Monastero di S. Caterina, nel Sinai. |
Circa l'Antico Testamento, il manoscritto ha subito varie mutilazioni, specialmente nei libri da Genesi ad Esdra. Qualcuno lo ha
associato alle 50 copie della Bibbia commissionate dall'imperatore romano Costantino I. Uno studio paleografico compiuto sul testo nel 1.938 al British Museum ha mostrato che il testo è stato oggetto di
molte correzioni. Le prime risalgono a un periodo immediatamente successivo alla sua stesura, nel IV secolo, altre risalgono al VI-VII secolo, realizzate probabilmente a Cesarea, in Palestina. Secondo una nota presente alla fine dei libri di Esdra ed Ester, tali alterazioni sono state fatte sulla base di un altro antico manoscritto corretto dalla mano del santo Panfilo (martirizzato nel 309). Il manoscritto manca della Pericope dell'adultera (Vangelo secondo Giovanni 8,1-11) e di Matteo 16,2b-3. Originariamente mancava anche dei versetti relativi all'agonia di Gesù al Getsemani (Vangelo secondo Luca 22:43-44), che fu poi successivamente introdotta da una seconda mano e
nel
vangelo di Marco non vi è traccia della
resurrezione del Cristo.
 |
Moldavia e Valacchia, da: QUI.
|
Nel 332 - I goti
Tervingi (poi chiamati Visigoti), stanziati
tra la
Moldavia e la
Valacchia,
sfondano il
limes ma sono sconfitti dall'imperatore Costantino che tuttavia, invece di farli rientrare nelle loro basi, li accoglie all'
interno dell'
Impero romano a seguito di un accordo che li avrebbe impegnati, in cambio del territorio ottenuto, a rapporti di collaborazione basati sui sussidi (o tributi) offerti dai romani in cambio di contingenti di
mercenari,
difesa dei confini, stabilità nella regione e scambi commerciali. Da allora rimarranno in pace fino al 365.
 |
| Banato, da: QUI. |
Nel 335 - I
Vandali, che
abitavano la regione compresa tra il fiume Marisus ed il Danubio
(forse poco a nord-ovest del Banato), sotto la guida di Visimar,
si scontrarono con i Goti di Geberico e
furono sconfitti. I superstiti chiesero a Costantino I di essere ammessi nei territori
dell'Impero romano, ottenendone il permesso e
stabilendosi nella
Pannonia, dove rimasero tranquilli per almeno quarant'anni "obbedendo
alle leggi dell'Impero come gli altri abitanti della regione".
Essi furono così inglobati come
foederati dell'Impero, mantenendo la loro
mansione di cuscinetto fra l'impero e le altre tribù barbare della
pianura Sarmatica.
Nel 336 - In occasione della celebrazione dei
tricennalia di Costantino,
Costanzo II (il secondo dei figli sopravvissuti di Costantino, di cui il primo era Costantino II, essendo stato giustiziato Crispo, il primogenito)
sposa a Costantinopoli, prima delle sue tre mogli, la
figlia di
Giulio Costanzo (fratellastro di Costantino I)
e di Galla, da cui non avrà figli.
- Nello specifico, la stirpe Costantiniana derivava da Costanzo Cloro (Flavio Valerio Costanzo, meglio noto come Costanzo Cloro o Costanzo I; Dardania, 31 marzo 250 circa - Eboracum, 25 luglio 306), imperatore d'Occidente (nel 305-306) nato in Dardania da una famiglia di Illiri romanizzati. Costanzo Cloro ebbe sette figli: 1) Costantino I da Elena (Flavia Giulia Elena, Drepanum, 248 circa - Treviri, 329), concubina (o forse moglie) dell'imperatore Costanzo Cloro e madre dell'imperatore Costantino I. I cristiani la venerano come sant'Elena Imperatrice. Nel 293 Costanzo dovette lasciare Elena per volere di Diocleziano e sposare la figliastra dell'imperatore Massimiano, Teodora, allo scopo di cementare con un matrimonio dinastico l'elevazione di Costanzo a cesare di Massimiano all'interno della tetrarchia. Da Flavia Massimiana Teodora, figliastra dell'imperatore romano Massimiano, in quanto figlia di sua moglie Eutropia da un precedente matrimonio con Afranio Annibaliano, console nel 292 e prefetto del pretorio sotto Massimiano, Costanzo Cloro ebbe altri sei figli: 2) Flavio Dalmazio, noto anche come Dalmazio il censore ( ... - 337), che passò la propria giovinezza a Tolosa ed è probabile che anche i suoi due figli, Dalmazio e Annibaliano, siano nati nella città gallica. A metà degli anni 320, Dalmazio tornò a Costantinopoli, alla corte di Costantino. Dopo la morte di Costantino, la famiglia imperiale fu vittima di una purga che colpì anche Dalmazio e i suoi figli, che vennero giustiziati nella tarda estate del 337. 3) Giulio Costanzo ( ... – settembre 337) si sposò due volte ed ebbe Costanzo Gallo (nato intorno al 325, divenne cesare d'Oriente dal 351 ma a causa del suo governo giudicato fallimentare e odioso, l'imperatore Costanzo II, suo cugino e cognato, ne ordinerà l'arresto e l'esecuzione) e una figlia, che sposerà il cugino Costanzo II., da Galla (fl. 325 circa, sorella del console Nerazio Cereale e del prefetto del pretorio Vulcacio Rufino) e Giuliano (Flavio Claudio Giuliano; 6 novembre 331- Maranga, 26 giugno 363, futuro imperatore e filosofo romano, l'ultimo sovrano dichiaratamente pagano) da Basilina, oltre ad un altro figlio, più grande di Gallo e Giuliano, morto assieme al padre nelle purghe del luglio del 337. Giulio Costanzo era vissuto per qualche tempo in esilio a Tolosa e a Corinto poi, nel 330, era andato a vivere a Costantinopoli, dove Galla era morta. 4) Flavio Annibaliano (... – settembre 337), insieme al fratello Dalmazio fu educato a Tolosa dal retore Exuperio. Nel 335, Annibaliano sposò la figlia di Costantino, Costantina, e fu elevato al rango di nobilissimus. Fu ucciso nella purga che colpì i membri maschili della famiglia imperiale e che tolse di mezzo molti pretendenti al trono. 5) Flavia Giulia Costanza (dopo il 293 - 330 circa). Nel 311 o 312, l'imperatore Costantino I, fratellastro di Costanza, la promise in moglie al proprio collega, Licinio: il matrimonio si celebrò nel febbraio 313, in occasione dell'incontro di Costantino e Licinio a Milano. Dall'unione nacque un figlio, Valerio Liciniano Licinio, nel 315. Quando Licinio e Costantino si dichiararono guerra nel 316, Costanza si schierò al fianco del marito, come fece pure in occasione della guerra del 324. Dopo la sconfitta di Licinio, Costanza intercesse presso Costantino in favore di Licinio. Costantino risparmiò la vita di Licinio, obbligandolo a risiedere a Tessalonica da cittadino privato; l'anno seguente, però, ordinò che venisse ucciso. Un secondo colpo per Costanza fu la morte, per ordine di Costantino, di suo figlio Liciniano. 6) Anastasia (fl. 314; ... – ...) rientrò anch'essa nei giochi politici del fratellastro Costantino I. Sposò Bassiano, un matrimonio con scopi dinastici visto che Costantino elevò nel 314 Bassiano al rango di cesare per l'Italia e inviò al suo collega orientale Licinio, il prefetto del pretorio Flavio Costanzo allo scopo di ottenere il riconoscimento della nomina del cognato. Licinio riuscì a convincere Bassiano a ribellarsi contro Costantino, consigliato dal proprio fratello Senecio; Costantino venne a sapere del complotto e mise a morte Bassiano. Quando però chiese a Licinio di consegnargli Senecio e ne ricevette un rifiuto, mise fine alla pace e attaccò il collega. 7) Eutropia (... - 350) sposò Virio Nepoziano, console per il 336, ed ebbero un figlio di nome Nepoziano. Madre e figlio sopravvissero alla purga della dinastia costantiniana che insanguinò la famiglia imperiale nel 337, alla morte di Costantino ma è possibile che in quell'occasione sia stato ucciso Virio. Quando Magnenzio si ribellò nel 350, uccidendo l'imperatore Costante I (figlio di Costantino), Nepoziano conquistò Roma per 28 giorni, prima di essere sconfitto e ucciso dal comandante di Magnenzio, Marcellino: sembra che anche Eutropia sia stata mandata a morte in tale occasione.
- Dagli inizi del IV secolo d.C.
gli eunuchi compaiono nell'amministrazione dell'Impero,
(in seguito specialmente in quello d'Oriente),
con la funzione del praepositus sacri cubiculi (custode della
sacra camera da letto) che oltre ai compiti di valletto-maggiordomo
lavora come funzionario di alto grado civile, fiscale
e militare. Si preferisce servirsi di questi particolari
personaggi nella convinzione che la loro menomazione li rendesse
docili e ben disposti all'obbedienza privi com'erano di quella "vis"
naturale che appartiene agli uomini virili. L'eunuco poi non aveva
problema familiari a cui attendere e poteva dedicarsi esclusivamente
ai suoi compiti. La presenza di un praepositus con alti
incarichi è attestata durante l'impero di Costantino (274-337
d.C.) che si avvale dell'eunuco Eusebio,
passato poi a servire anche il figlio dell'imperatore Costanzo II
(317-361 d.C.). Nelle corti degli imperatori d'Oriente vennero create
delle vere e proprie gerarchie di cubicularii: nel
grado più basso della scala gerarchica erano i comites sacrae
vestis, addetti al vestiario imperiale, quindi vi erano i comites
domorum che curavano gli introiti della sacra camera. Lo
spatharius comandava la guardia del corpo mentre il
sacellarius curava le finanze private dell'imperatore.
Entrambi questi funzionari erano sottoposti al castrensis che
aveva alle sue dipendenze contabili (tabularii) e segretari. In breve i cubicularii ebbero
modo di arricchirsi e di tessere una rete di connivenze politiche che
permise loro di essere arbitri del governo dell'Impero. Le loro imprese sono rimaste nella memoria di diversi storici laici e
religiosi del IV-V sec. d.C. come Socrate Scolastico, Ammiano
Marcellino, Filostorgio, Palladio di Galazia, Sozomeno, Atanasio di
Alessandria che hanno tramandato come fosse mal riposta la fiducia
nella docile fedeltà degli eunuchi a confronto della reale cattiva
fama dei castrati come espressione di corruzione, avidità, arrivismo
e amoralità: "La fabbrica degli intrighi di corte batteva
giorno e notte sulla stessa incudine secondo la volontà degli
eunuchi, che con la loro esile voce sempre infantile e
accattivante, con una pesante odiosità, rovinavano,
sussurrando alle orecchie troppo accoglienti dell'imperatore, la
reputazione anche di un eroe." (Ammiano Marcellino, XVIII
4, 2-4).
Dal 337 - Costantino muore (pare per malattia) il 22 maggio 337 ad Achyrona, non molto lontano da Nicomedia, mentre preparava da lungo tempo una campagna militare contro i Sasanidi di Persia. L’ Impero Romano verrà così nuovamente spartito fino al 350. Costantino, pur volendo apparire continuatore della suddivisione tetrarchica del potere, aveva nominato Cesari, suoi successori, i figli Costantino II, Costanzo II e Costante I, oltre ai due nipoti Dalmazio (Flavio Giulio Dalmazio, anche noto come Dalmazio Cesare) e Annibaliano, figli di Dalmazio il censore, instaurando quindi forzatamente una successione ereditaria ma astenendosi dal nominare un Augusto, inceppando così la legittimità delle nomine ai successori, titolo che a questo punto doveva essere conquistato sul campo per acclamazione delle truppe.
 |
I Cesari nominati da Costantino, da:
L'utente che ha caricato in origine il
file è stato Panairjdde di Wikipedia
in
italiano - Trasferito da it.wikipedia
su
Commons., CC SA 1.0, QUI. |
Costantino finì per esser parte di una
sequenza di
tre dinastie, collegate fra loro da alleanze matrimoniali, che avrebbe
governato ininterrottamente (a parte la brevissima eccezione di Gioviano) dal
285, con Massimiano, fino al
455 nell’Impero d’Occidente, e fino al
457 in quello d’Oriente.
Costanzo II, nato poco dopo il fratello maggiore Costantino II, impegnato in Mesopotamia settentrionale a supervisionare la costruzione delle fortificazioni frontaliere, si affrettò a tornare a Costantinopoli dove organizzò e presenziò alle cerimonie funebri del padre, rafforzando i suoi diritti come successore e ottenendo il sostegno dell'esercito, componente fondamentale della politica di quei tempi.
- Durante l'estate del 337 si ebbero diversi eccidi, per mano dell'esercito, dei membri maschili della dinastia costantiniana e di altri esponenti di grande rilievo dello stato: solo i tre figli di Costantino e due suoi nipoti bambini (Gallo e Giuliano, figli di Giulio Costanzo, fratellastro di Costantino) furono risparmiati. Le motivazioni dietro questa strage non sono chiare: secondo Eutropio Costanzo II non fu tra i suoi promotori ma non tentò certo di opporvisi e condonò gli assassini; Zosimo invece afferma che Costanzo II fu l'organizzatore dell'eccidio. Nel settembre dello stesso anno i tre cesari rimasti (Dalmazio e Annibaliano, figli di Dalmazio il censore, fratellastro di Costantino, erano stati vittime della purga) si riunirono a Sirmio in Pannonia, dove il 9 settembre furono acclamati imperatori dall'esercito e si spartirono l'Impero: Costanzo II si vide riconosciuta la sovranità sull'Oriente, Costante I sull'Illirico e Costantino II sulla parte più occidentale (Gallie, Hispania e Britannia). La divisione del potere tra i tre fratelli durerà poco.
- Costantino II (Flavius Claudius Constantinus; Arelate, febbraio 317 - Cervenianum, aprile 340), il fratello maggiore, mantenne il territorio che aveva governato in qualità di cesare da Treviri, mentre Costante e Costanzo si spartirono il territorio di Flavio Dalmazio, ucciso insieme al fratello Annibaliano. Oltre alla
Gallia, alla
Britannia, alla
Spagna e a
parte dell'
Africa, Costantino ricevette anche la tutela sul fratello diciassettenne Costante I. Nel 338 affrontò con successo gli Alamanni, per cui si attribuì il titolo di
Germanicus maximus. Costantino II si arrogò più potere di quanto gli era stato affidato, poiché promulgò alcune leggi per le province africane, che cadevano sotto la giurisdizione di Costante. Ben presto, insofferente delle ingerenze di Costantino II, Costante I venne in contrasto con il fratello maggiore per cui Costantino II, approfittando della lontananza di Costante, che si trovava a Naissus in Pannonia, mosse contro di lui scendendo in Italia (nel 340), ma fu
ucciso durante una battaglia presso Aquileia e i suoi territori passarono quindi a
Costante I che divenne
unico dominatore della parte
occidentale dell'impero.
- Flavio Giulio Costante, meglio conosciuto come Costante I (Flavius Iulius Constans; 320 - Oppidum Helena, 18 gennaio 350), riconosciuto augusto dal Senato il 9 settembre di quell'anno, aveva potere sulle province di Italia, Africa, Pannonia, Dacia, Macedonia e Acaia. Nel 338 Costante, dopo aver incontrato i fratelli a Viminacium, ottenne una vittoria contro i Sàrmati e accettò il titolo di Sarmaticus maximus. Nel 340 i territori di Costantino II passarono a Costante I, che divenne unico dominatore della parte occidentale dell'impero e accettò il titolo di Maximus Victor ac Triumphator. Nel 341-342 combatté contro i Franchi in Gallia, stipulando un trattato vantaggioso. Nel gennaio 343 si recò nella Britannia romana. L'attraversamento della Manica in pieno inverno significa che si dovesse intervenire con urgenza, e pare che Costante abbia rinforzato le fortificazioni frontaliere della provincia, forse per difendersi dagli attacchi delle tribù ostili dopo che Costantino II aveva distaccato molte truppe provinciali al fine di invadere l'Italia. Ad ogni modo, la visita di Costante in Britannia, che durò fino alla primavera, fu l'ultima di un imperatore romano nella provincia. Il 18 gennaio 350, in Gallia,
l'usurpatore di Costante I, Magnenzio, è elevato imperatore dalle sue truppe. Negli ultimi anni del suo regno infatti, Costante finì per alienarsi il consenso di tutti i gruppi sociali: cercò di ristabilire la disciplina negli eserciti riuscendo però solo ad attirarsi l'antipatia dei soldati, aggravò il prelievo fiscale tra i provinciali, scelse i governatori tra uomini incapaci di ricoprire tale carica e infine, con la sua ferma adesione al cristianesimo, si fece nemica l'aristocrazia senatoria di Roma. La sua cattiva nomea fu poi gonfiata da alcuni comportamenti nell'ambito della sfera privata ritenuti disdicevoli per l'epoca, come l'abitudine di attorniarsi di attraenti soldati per soddisfare le sue voglie omosessuali o il dedicare troppo tempo allo svago della caccia, che gli avrebbe fatto progressivamente perdere il controllo sulla corte. Questa fu la situazione storico-politica di cui seppe approfittare Magnenzio, benché la cospirazione contro Costante si configurò inizialmente come una congiura di palazzo. Flavio Magno Magnenzio (Samarobriva,
Amiens in Gallia 303 - Lugdunum, 10 agosto 353), militare di origine barbarica, con la sua rivolta spezzò il dominio ininterrotto dei Costantinidi sulla pars Occidentis dell'impero, riuscendo a coagulare le forze sociali ostili al governo di Costante. Come prima decisione, Magnenzio ordinò la morte di Costante I, benché quest'ultimo, anni addietro, con un suo intervento personale avesse salvato la vita allo stesso Magnenzio a seguito di una ribellione dei soldati posti sotto il suo comando. Costante I fuggì allora verso la penisola Iberica, ma fu raggiunto e ucciso vicino ai Pirenei da un gruppetto di cavalieri guidati dal generale Gaisone.
 |
Costanzo II, imm. di Mary
|
- Flavio Giulio Costanzo, meglio noto come
Costanzo II (Flavius Iulius Constantius; Sirmio, 7 agosto 317 - Cilicia, 3 novembre 361) è stato imperatore per 24 anni, difendendo l'impero dai nemici esterni e il proprio potere dagli usurpatori e promuovendo il Cristianesimo. Nominato Cesare (imperatore subordinato ad un Augusto) dal padre, assieme ai fratelli, alla sua morte aveva mantenuto il potere come Augusto nella
parte orientale dell'impero (province d'
Asia e d'
Oriente,
compreso il
Ponto e la
Tracia, lasciando gli altri fratelli a spartirsi l'Occidente. Si impegnò nella difesa dei confini orientali dell'impero dalla minaccia dei Sasanidi, optando per una politica militare a bassa intensità diversa dalle consuetudini romane, che fu efficace, ma che causò una certa insoddisfazione nel mondo romano. Buon comandante e amministratore, ridusse il peso della burocrazia imperiale e del fisco; in campo militare dovette affrontare anche le incursioni dei popoli barbari attraverso i confini germanico e danubiano, mentre in politica interna fu a lungo impegnato dall'usurpatore Magnenzio, cui contese e strappò il potere in Occidente, come pure da altri usurpatori (Vetranione, Decenzio, Nepoziano e Claudio Silvano). L'usurpatore Magnenzio, elevato a
imperatore della parte occidentale dell'impero il 18 gennaio 350, come
prima decisione aveva ordinato la morte di Costante I, che era
fuggito verso la penisola Iberica, ma che fu raggiunto e
ucciso vicino ai Pirenei da un gruppetto di cavalieri guidati
dal generale Gaisone. Alla fine dell'inevitabile guerra tra Magnenzio e Costanzo II, dopo le battaglie di Mursa del 351 e di Mons Seleucus (La Bâtie-Montsaléon) del 353, il 10 agosto 353,
Magnenzio uccise la propria madre e tutti i parenti e gli amici più stretti che erano a Lugdunum con lui, e poi
si suicidò. La
sua testa fece il
giro delle città a dimostrare la sua sconfitta. L'
impero era di nuovo
riunito sotto
un solo imperatore, mentre nei confronti di Magnenzio fu dichiarata la
damnatio memoriae.
Non avendo
figli,
Costanzo II associò al potere gli unici due parenti maschi rimastigli dopo le purghe seguite alla morte di Costantino, che avevano consentito a Costanzo di sbarazzarsi di possibili concorrenti al soglio imperiale: prima scelse il cugino Gallo (Flavio Claudio Giulio
Costanzo Gallo; Massa Veternensis, 325/326 - Pola, 354) che nominò cesare d'Oriente nel 351 e a cui diede in sposa la propria sorella Costantina ma che poi a causa del suo governo giudicato fallimentare e odioso, l'imperatore Costanzo II, suo cugino e cognato, ne ordinerà l'arresto e l'esecuzione. Poi il fratellastro di questi
Giuliano, il quale, dopo aver dimostrato insospettate qualità militari e amministrative in Gallia, gli si rivoltò contro, proclamato imperatore e succedutogli poi alla sua morte. Come il padre prima di lui, come imperatore Costanzo assunse un ruolo attivo all'interno del cristianesimo, promuovendo l'
arianesimo nell'ambito della diatriba sulla natura di Cristo e promuovendo diversi concili, rimuovendo e nominando molti vescovi. Con Costanzo il
potere e i privilegi della
gerarchia ecclesiastica si
consolidarono e il cristianesimo divenne sempre più la religione principale dello Stato romano.
Nel 342 - La federazione
dei Franchi è protagonista di un'incursione in territorio
gallico, condotta a partire dalla loro area d'insediamento presso
il Reno ma sono respinti da Costante I, imperatore dal
337.
- Nell'Europa orientale, le tribù degli
Slavi orientali uniscono parte delle loro forze a quelle
gotiche nel III e IV secolo. Tuttavia
i Goti, capeggiati da Ermanarico,
ambivano a
sottomettere gli stessi
Venedi (gli Slavi occidentali), senza peraltro riuscirvi. I
movimenti migratori dei
Venedi (gli Slavi occidentali) nelle terre a sud-ovest dell'Elba e dell'Oder, erano stati causati anche dalla
pressione e dalle violente
incursioni degli
Unni.
- Durante il
IV secolo gli
Unni, popolo guerriero nomade, probabilmente
di ceppo
turcico (o turco), provenienti dalla Siberia meridionale,
giungono in Europa.
Non si conosce quasi nulla della lingua unna, l'ipotesi più accettata è che si trattasse di una lingua altaica ma diverse altre teorie la vorrebbero vicina al moderno ungherese o addirittura alle
lingue iraniche. Giordane (o
Giordano o Jordanes, storico bizantino di lingua latina del VI secolo
di probabile origine gotica o alana) scrisse che gli Unni "si
procuravano ferite sulle guance come segno di lutto per i guerrieri
più valorosi, piangendoli non con lacrime di donne ma con il sangue
degli uomini". Inoltre gli Unni
praticavano la deformazione
cranica, allungandosi le teste probabilmente a imitazione dei
nomadi sàrmati, di origine indoiranica. La deformazione cranica fu una
pratica molto comune nel corso della storia. Il procedimento veniva
applicato sin dalla più tenera infanzia e consisteva nello stringere
la testa del bambino con un bendaggio, approfittando del fatto che a
quell'età il cranio era ancora molle e in crescita. Nel caso di
alcuni popoli, questa pratica serviva a indicare che il ragazzo era
destinato al sacerdozio, ma nel caso degli Unni se ne ignora il
significato, anche se come suggerisce lo storico John Man, "gli
uomini con la testa allungata costituivano un'élite".
Gli
Unni sono stati descritti come un popolo di uomini brutti e spaventosi e lo stesso si diceva dei loro
cavalli, la loro vera grande
arma vincente sui campi di battaglia. I cavalli unni erano diversi dai cavalli attuali e molto diversi da quelli adottati dalla cavalleria romana e dai popoli con cui si scontrarono. Esteticamente questi cavalli potevano sembrare poco attraenti, erano molto magri, decisamente più bassi dei cavalli adottati dagli eserciti imperiali ma erano forti, resistenti e veloci, in grado di percorrere anche 100 km senza aver bisogno di essere ferrati, di indole mansueta e in grado di trovare il foraggio anche sotto la neve: sopravvivevano dunque facilmente anche in condizioni ambientali poco favorevoli. L'unico territorio in cui questi cavalli si muovevano a disagio era quello montagnoso, ma nelle vaste praterie della steppa Europea, nelle pianure e nelle valli si dimostrarono molto più performanti di qualsiasi cavalleria contro cui si scontrarono. I cavalieri unni sembravano un tutt'uno in sella ai loro cavalli, i bambini imparavano a cavalcare nello stesso tempo in cui imparavano a camminare e al galoppo di quei veloci destrieri sapevano destreggiare le armi con una precisione che le altre cavallerie, più rigide, pesanti e diversamente equipaggiate, non possedevano. Grazie all'
uso sia della
sella che della
staffa i loro attacchi erano sorprendentemente potenti, scanditi da repentini movimenti inaspettati. Si ritiene che un tipo di sella arcaica sia stata usata fin dal 700 a.C. circa dagli Sciti, un popolo nomade della steppa eurasiatica, ma è stato certamente l'arrivo in Europa di
selle robuste come quelle cinesi a fare la differenza in battaglia. Lo scoprirono a loro spese i Romani, che combatterono gli
Unni seduti su coperte appoggiate ai cavalli mentre la cavalleria dei loro nemici era già dotata di
selle in
legno con pomelli davanti e dietro, il cui vantaggio era una stabilità senza pari e la possibilità di tirare frecce senza fermarsi. Allo stato attuale e basandoci sui ritrovamenti effettuati in alcuni siti archeologici, è possibile oggi affermare che le
prime staffe rinvenute in
Europa sono attribuibili al quarto secolo dopo Cristo e provengono dalle tombe dei cavalieri
Sàrmati situate nel bacino del fiume Kuban, a nord del Caucaso, mentre al quinto secolo dopo Cristo appartengono alcune staffe in ferro, con la fessura per il passaggio dello staffile e la forma consueta che ancora oggi gli viene data, rinvenute in tombe di
Unni in Ungheria. Gli storici romani e cristiani che tanto disprezzarono gli Unni, descrivendoli come rozzi e incivili, narrarono di come si nutrissero della
carne cruda che riponevano
sotto la
sella durante le cavalcate, appena scaldata e "cotta" dal continuo movimento del corpo sulla sella. In realtà quella carne proteggeva l'animale dall'attrito del contatto, rendendogli quindi la cavalcata più lieve, che poi quella carne venisse realmente mangiata non apparirebbe certo strano oggi, soprattutto alla luce del prezzo della carne di Kobe, pregiatissima perché "massaggiata" a mano. Il cavaliere unno non avevano solo un cavallo a disposizione, ma un'intera scuderia di cavalli al seguito, in modo da poter contare sempre su un cavallo riposato per un'azione scattante. Quando gli Unni avanzavano lo facevano così velocemente che si potevano vedere le sentinelle correre disperate per annunciare l'arrivo degli Unni quando già se ne sentiva lo scalpitio sul terreno e l'orizzonte si copriva della polvere sollevata dagli zoccoli dei loro cavalli.
Nel 343 - Al Concilio di Serdica (o Sardica, l'attuale Sofia in Bulgaria) convocato nel
343/344 dagli imperatori Costante I e Costanzo II, parteciparono 180
vescovi di cui molti semiariani i quali, non riconoscendo come
vescovi Atanasio di Alessandria, Marcellino di Ancira e Asclepiade di
Gaza, costituirono un altro concilio che scomunicò
il papa Giulio I. Nella sua maggioranza però, il concilio
restò fedele a Roma e confermò la dottrina atanasiana e il simbolo
di Nicea e promulgò inoltre canoni riguardanti il diritto episcopale,
fra cui il diritto della Sede romana di ricevere i
ricorsi di chierici o vescovi condannati in provincia.
Nel 344 - Nasce Giovanni Crisostomo, o Giovanni d'Antiochia (Antiochia, 344/354 - Comana Pontica, 14 settembre 407), arcivescovo cattolico, santo e teologo bizantino, uno dei 33 Dottori della Chiesa. La sua eloquenza è all'origine del suo epiteto Crisostomo (in greco antico khrysóstomos = bocca d'oro). Il suo zelo e il suo rigore saranno causa di forti opposizioni alla sua persona. Fra l'altro scrisse delle omelie antigiudaiche, utilizzate nei secoli successivi come pretesto per discriminazioni e persecuzioni contro gli ebrei. In età avanzata dovette subire un esilio e morì durante un trasferimento.
- A partire dal IV secolo (dopo l'Editto di Milano) la
Diocesi di Roma diventa
proprietaria di immobili e terreni, frutto delle donazioni dei fedeli. Il patrimonio terriero del vescovo di Roma era denominato
Patrimonium Sancti Petri poiché le donazioni erano devolute a san Pietro, l'apostolo fondatore della Chiesa romana. Nel VI secolo il patrimonio petrino assumerà un'estensione di rilievo.
Nel 350 -
Ulfila traduce il
Nuovo Testamento in lingua gota, favorendo così la
conversione dei
Goti al
cristianesimo ariano. Ulfila o Wulfila (in gotico
"Lupacchiotto"; 311 - Costantinopoli, giugno 388), nato da genitori romani
di una comunità originaria della Cappadocia, ridotta poi in
cattività dai Goti sul finire del III secolo, era di religione
cristiana ariana e di lingua e cultura elleniche. Fu forse grazie a
prigionieri come lui che il Cristianesimo si diffuse tra i Goti,
allora stanziati nella Bessarabia storica.
 |
In color mattone, la
Bessarabia. |
Si sa che nel 311 i
genitori di Ulfila vivevano a nord del Danubio, in territorio
visigoto. Oltre al goto, Ulfila sapeva il latino e il greco e fu
inviato più volte come ambasciatore a Costantinopoli, dove prese
contatti con l'ala moderata degli ariani. Nel 348 il vescovo di
Costantinopoli, Eusebio di Nicomedia, lo nominò vescovo presso i
goti. All'inizio la sua missione di evangelizzatore fallì: re
Atanarico scatenò una
persecuzione contro i goti cristiani, che per
questo migrarono con Ulfila nell'area oggi al confine tra Romania e
Bulgaria, con il benestare dell'imperatore romano Costanzo II. Lo
storico Iordanes, nel suo
De origine actibusque Getarum del
551, scrisse (libro LI, 267): «Ci furono anche altri Goti, detti
minori, un popolo immenso il cui vescovo e capo fu Wulfila, che si
dice li avesse istruiti nelle lettere». Grazie alla sua
predicazione, Ulfila convertì molti goti al cristianesimo ariano.
Tradusse, anche se con difficoltà,
la Bibbia dal greco
al
gotico antico, di cui creò l'
alfabeto (detto
appunto
gotico). La
Bibbia di Ulfila non ebbe diffusione, dal 325, infatti, l'arianesimo
era considerato eretico e Ulfila, che era ariano, dovette difendersi
dall'accusa di eresia. Morì a Costantinopoli nel 388, quando
la maggioranza dei goti era ormai cristianizzata. Neppure in punto di
morte Ulfila rinnegò la sua versione del cristianesimo. Il vescovo
ariano Massimino, nella sua Dissertazione contro Ambrogio (
Contra
Ambrosium, 56, 59-60, 63), ne riporta il testamento spirituale
pronunciato prima di morire.
 |
Carta dell'Occitania (di cui solo
Provenza e Languedoc, Aquitania
esclusa) provincia Romana. |
- Nel crogiuolo occitanico, composto da iberi, liguri, baschi, celto-liguri, greci e romani, diventati tutti cittadini romani nel 121 a.C., con la proclamazione della Provincia della Gallia Narbonensis (da cui il termine Provenza), si mescolano successivamente popoli germanici (goti e franchi) e semito-camitici (ebrei e arabo-berberi) che si convertono spontaneamente alla lingua ed alle culture latine. La
lingua d'Oc è una delle lingue neolatine che si formano sul substrato degli antichi dialetti regionali e della lingua ufficiale e colta della Roma conquistatrice e padrona, fin dalla fine dell'Impero. Se in quella parte di continente che denominiamo Francia settentrionale (e che allora era lungi dall'essere un'entità definita e definibile) si andava affermando la Langue d'Oil, in una zona compresa
tra le Valli alpine del Piemonte e la Catalogna prendeva forma la lingua d'Oc (anche se in realtà non dovette esserci per il volgo, il popolo non colto, un significativo distacco dal dialetto parlato in precedenza). Per "Occitani: storia e cultura":
QUI
Nel 352 - Da
QUI: I destini di
Eusebia e di
Giustina s'incrociarono per breve tempo alla metà del IV secolo, quando entrambe si unirono in
matrimonio a due
imperatori rivali. Nel dicembre del
352 a Milano,
Eusebia sposa il più maturo e già vedovo imperatore
Costanzo II. Di Eusebia non sappiamo la data di nascita ma solo che proveniva da una famiglia di Salonicco, di recente elevazione senatoria. Il padre Flavio Eusebio era stato
magister equitum et peditum prima del 347 e console subito dopo tale data ed aveva almeno altri due figli di cui si conoscono i nomi: Flavius Hypotius e Flavius Eusebius. Quest'ultimo, omonimo del padre, diverrà governatore dell'Ellesponto nel 355, governatore della Bitinia nel 355/356 e console nel 359. Gli storici all'unanimità attribuiscono ad Eusebia bellezza e intelligenza, ma questi erano forse gli attributi comuni a tutte le auguste.
Giustina, definita bella e intelligente, aveva solo
dodici anni quando il padre Giusto, governatore del Piceno, la
consegnò in quello stesso anno al cinquantenne
Magno Magnenzio, già vedovo di sua sorella maggiore e con una figlia sua coetanea.
Giustina era verosimilmente appartenente alla
dinastia costantiniana, probabilmente tramite
sua madre, che potrebbe essere stata o figlia di Crispo, il figlio primogenito di Costantino I o di Giulio Costanzo (fratellastro di Costantino). Il
generale franco Magno Magnenzio era stato acclamato imperatore nel 350 dopo una rivolta nelle Gallie conclusasi con la morte di Costante, fratello di Costanzo.
- Costanzo II, poco prima della vittoria decisiva sull'usurpatore Magnenzio, sposa Eusebia (... – Tessalonica, 360), sua seconda moglie, figlia del suo magister militum Eusebio (comandante in capo dell'esercito), che l'imperatore stimava tanto da concedergli di condividere il consolato del 347. In onore di Eusebia, descritta dalle fonti come molto bella, Costanzo creò una nuova diocesi, costituita dalla Bitinia e da parti della Pontica, cui diede il nome di Pietas ("pietà", "senso del dovere", "rispetto"), traduzione in latino della parola greca eusebia. Eusebia usò la propria influenza sul marito per aiutare le persone a lei vicine; i suoi due fratelli divennero consoli nel 359 e dal punto di vista religioso fu una sostenitrice dell'Arianesimo, influenzata dall'eunuco Eusebio, il potente praepositus sacri cubiculi ("addetto agli appartamenti imperiali") di Costanzo. Eusebia e Costanzo non ebbero figli e sebbene fosse stata forse lei a convincere il marito a elevare il cugino Giuliano al rango di cesare, si tramanda che Giuliano stesso le abbia causato ripetuti aborti allo scopo di non avere pretendenti al trono di sangue imperiale. Probabilmente Costanzo era sterile e quelle voci infamanti venivano da cristiani avversi al filosofo Giuliano.
Nel 353 - Da QUI: Costanzo II scende in campo e sconfigge il rivale Magno
Magnenzio. Per l'occasione riapre la zecca a Milano con
l'emissione di una moneta commemorativa, in cui veniva effigiato
quale debellator orbis. Magnenzio si suicidò il 10 agosto a
Lione; la sua testa venne spiccata e portata in giro per le province;
chiunque l'avesse sostenuto, anche solo con un gesto di compassione
umana, venne torturato, condannato a morte o all'esilio e i
suoi beni confiscati (Amm. Marc., XIV 5, 1-9). Questa sorte toccò al
padre di Giustina e a Graziano il Vecchio, il cui
figlio Valentiniano diventerà imperatore e secondo
marito di Giustina. Ammiano Marcellino ha così
tratteggiato il carattere fisico e psicologico di Costanzo II:
bruno, con uno sguardo luminoso e penetrante, morbidi capelli, guance
sempre ben rasate, brevilineo. Sobrio e parco, moderato nel cibo e
nelle bevande, dormiva pochissimo. La sua massima abilità era nel
cavalcare, nel lanciare giavellotti e nel saettare con precisione.
Era così compreso della sua ieratica maestà che, in presenza del
pubblico, rimaneva immobile come una statua, senza pulirsi nemmeno il
naso. Poiché era scarso d’ingegno, era prudente fino alla
paranoia, che lo spinse a commettere parecchi omicidi anche di
consanguinei, ma soprattutto di persone che temeva. Per questo motivo
non presenziò mai a processi. L’unica persona della quale si
fidò ciecamente fu la moglie Eusebia, che gli fece da
filtro alle voci sottili degli eunuchi e a quelle insinuanti dei
cortigiani.
- Da QUI: Costanzo II ed Eusebia pongono la loro sede a Milano, nel palatium presso S. Giorgio al Carrobio di Porta Ticinese, adattato per un fastoso soggiorno. Il clima che si respirava a corte era tutt'altro che sereno: adulazione cortigiana, lusinghe artificiose, trame di calunnie tessute instancabilmente dagli avidi eunuchi di palazzo, segreti sussurri che materializzavano cavalletti di tortura, catene, pianti di supplici inascoltati. "La fabbrica degli intrighi di corte batteva giorno e notte sulla stessa incudine secondo la volontà degli eunuchi, che con la loro esile voce sempre infantile e accattivante, con una pesante odiosità, rovinavano, sussurrando alle orecchie troppo accoglienti dell'imperatore, la reputazione anche di un eroe." (Ammiano Marcellino, XVIII 4, 2-4). Tutta la letteratura nera che siamo abituati ad associare a Bisanzio si potrebbe benissimo trasferire alla corte milanese. Ammiano Marcellino ci consegna due impareggiabili ritratti di cortigiani: Paolo, spagnolo, cameriere della sala da pranzo "soprannominato Catena perché era invincibile nell'intrecciare complicate calunnie" e Mercurio, persiano, detto "conte dei sogni", perché "insinuandosi spesso in molti banchetti e riunioni, come un cane nascostamente pronto a mordere, che dissimula l'intera crudeltà scodinzolando umilmente, se qualcuno narrava ad un amico un sogno, lo riferiva con velenosi artifici, deformandolo, alle orecchie avide dell'imperatore". Ad alimentare questo inferno di turpitudini c'era Costanzo, spietato assassino dei suoi consanguinei nel 337 e timoroso di ricevere lo stesso trattamento.
Nel 354 - Da QUI: Dopo aver eliminato suo cugino Gallo, che aveva fatto sposare con sua sorella Costantina, Costanzo II assapora il delirio del potere e comincia a definire se stesso "la mia Eternità" e a firmarsi "Signore di tutto il mondo". Restava però in vita un ultimo rivale, che aveva tutte le carte in regola per contestargli il dominio assoluto: suo cugino Giuliano, fratellastro di Gallo. E su di lui si concentrerà la fabbrica degli intrighi.
Nel 355 - Gli Alamanni (o Alemanni) passano la frontiera in Alsazia con l'idea di stabilirsi in
massa e definitivamente nel territorio dell'impero, ma l'imperatore romano Giuliano li sconfiggerà a Strasburgo nel 358. Delle antiche tribù germaniche, nell'Europa centrale erano rimaste soltanto due confederazioni di tribù: i popoli stanziati nei territori a nord del Danubio, gli Alamanni e quelli stanziati intorno al Reno, i Franchi.
- Da QUI: Giuliano,
detto l'Apostata Giuliano, nato a Costantinopoli nel 331 e scampato
alla strage del 337, era vissuto in rigoroso e forzato isolamento a
Macellum in Cappadocia, in quella che lui chiamava "la torre del
silenzio", ossia l'edificio funebre dove i persiani esponevano i
cadaveri al pasto degli uccelli. Nel 355 venne prelevato e condotto
nei pressi di Milano, dove attese in angosciosa incertezza sei lunghi
mesi prima che Costanzo II trovasse il coraggio di guardarlo negli
occhi. La regìa dell'incontro spettò a Eusebia. Secondo Ammiano
Marcellino sarebbe stato schiacciato dalla nefanda cospirazione dei
cortigiani se non lo avesse appoggiato per ispirazione divina
l'imperatrice Eusebia, che gli procurò l'autorizzazione a trasferirsi
all'università di Atene. Pochi mesi dopo Giuliano fu richiamato a Milano perché il 6 novembre si celebrava la sua elezione a cesare, che sottintendeva un probabile trasferimento nelle Gallie e contemporaneamente gli si offriva in moglie Elena, la sorella minore di Costanzo II. Il trasferimento nelle Gallie, regione oltremodo turbolenta e palcoscenico degli assassinii di quasi tutti i prossimi imperatori, equivaleva in realtà alla condanna a morte. Dopo aver celebrato il matrimonio con Elena, nubile e vicina ai trent'anni, il 1° dicembre la coppia fu spedita in fretta e furia nelle Gallie. C'è troppa insistenza da parte di tutti gli storici e in Giuliano stesso nel definire Eusebia "donna estremamente intelligente" e Costanzo succube delle sue decisioni per non riconoscerla come la principale stratega di questa operazione. Giuliano era l'ultimo discendente dei figli che il capostipite Costanzo Cloro ebbe da Teodora, mentre dei figli avuti da Elena rimanevano Costanzo II ed Elena, tutti senza figli: in attesa di rimanere incinta, Eusebia doveva eliminare i due diretti rivali. L'imperatrice, colpita dalla temibile sterilità, contava sulla professione di castità fatta da Giuliano e sulla precaria salute della cognata Elena. Purtroppo per lei le cose presero una piega completamente diversa. Eusebia non aveva calcolato che per un filosofo come Giuliano era ammesso il sacrificio di se stessi in nome dello Stato: Elena rimase incinta poco dopo il matrimonio. Ammiano Marcellino, che pure loda la bontà, la cultura e la bellezza di Eusebia, non tralascia di riportare i sospetti che caddero sull'imperatrice allorché Elena perse il primo figlio a Lutetia (Parigi) per un taglio eccessivo del cordone ombelicale. In occasione di una seconda gravidanza, si mormorò che Eusebia avesse propinato alla cognata una pozione abortiva durante il viaggio ufficiale a Roma nell'aprile 357 per la celebrazione del ventennale di governo di Costanzo II.
 |
Confederazioni dei Franchi
e degli Alemanni. |
Nel 357 - La federazione di tribù dei
Franchi Salii, così chiamati perché abitavano la
regione prossima al
fiume Sala,
l'odierno Ijssel, il più orientale dei tre rami principali in
cui si divide il Reno prima di sfociare in mare, erano
giunti, attraversando il Reno e la Mosa, ai territori delle valli della Mosa stessa e dello
Schelda, la cui parte terminale aveva una notevole importanza strategico-commerciale essendo sulle rotte dirette in Britannia. Inizialmente i Franchi Salii avevano interferito
con
atti pirateschi sulle rotte di rifornimento dei romani finché, nel 357, l'
imperatore Giuliano, trovando le rotte del
Reno sotto il loro controllo, ebbe degli
scontri con loro, al termine dei quali li pacificò.
Roma garantì
ai Franchi una fetta considerevole della Gallia
Belgica e divennero
foederati
dell'Impero romano, incaricati di difendere la frontiera
del Reno contro Alani, Suebi e Vandali. La regione che i Franchi Salii ottennero corrisponde all'incirca alle odierne
Fiandre e ai Paesi Bassi a sud del Reno e rimane ancora oggi una
regione di lingua germanica (attualmente predomina l'olandese ed il
fiammingo). I
Franchi Salii divennero quindi,
il primo popolo
germanico a stabilirsi permanentemente all'interno del territorio
romano, con il ruolo di
foederati. Da quel territorio i Franchi
conquistarono gradualmente gran parte della Gallia Romana a nord
della Valle della Loira e ad est dell'Aquitania visigota. I
Franchi Ripuarii si consolidarono sulla riva destra renana, da Colonia
fino all'odierna Francoforte. A queste federazioni apparteneva probabilmente anche i Brutteri e i
Sicambri (o Sigambri), che già avevano combattuto contro i Romani ai tempi di Giulio Cesare e Augusto e che avevano poi assegnato loro dei contingenti, come ausiliari, nell'esercito romano. Dal 26 gli storici romani non ne avevano più scritto, ma
Fredegario,
uno scrivano borgognone del VII/VIII sec., narra nella sua "Cronaca", che la storia dei Franchi Sicambri era iniziata dai tempi remoti degli antichi
Patriarchi ebrei, citando numerose fonti
d'informazione e di rimando, fra cui gli scritti di San Girolamo,
l'arcivescovo Isidoro di Siviglia ed il vescovo Gregorio di Tours
anch'egli autore di una "Storia dei Franchi". Per raggiungere tale
precisione, Fredegario, che godeva di molta considerazione alla corte
borgognona, approfittò della sua possibilità di accedere a svariati
archivi ecclesiastici ed annali statali. Egli, dunque, racconta come
i
Franchi Sicambri, da cui prese nome la Francia, erano stati
a loro volta chiamati così per via del loro capo
Francio o
Francione, morto nel
II secolo a.C.. La tribù, che era
passata nella Scozia, affondava le sue radici nell'antica città di
Troia. Tracce di questa discendenza si potrebbero trovare in alcuni
nomi come quello della città di Troyes e perfino di Parigi che
porterebbe il nome del principe Paride, figlio del re Priamo di
Troia. Quella dei
Merovingi, quindi, sarebbe stata una dinastia discendente in
linea
maschile dai "Re pescatori" che corrispondevano anche
ad una
linea di successione
femminile sicambrica. I Sicambri,
prendevano il loro nome da
Cambra, una regina tribale vissuta
intorno al 380 a.C., originaria della
Scozia ed erano chiamati
anche i "nuovi parenti". Potrebbe darsi che da tale Cambra avesse preso nome la città di
Cambrai. Lo storico Ammiano Marcellino riporta nelle sue cronache
che la tribù dei Salii era composta da uomini forti e coraggiosi che
si erano spinti sino alle fortificazioni sulla strada romana di
Colonia e affermava inoltre che sia i Salii che i Ripuari avessero un proprio re. C'è chi ipotizza che i Romani li chiamassero Franchi nel senso di "i
liberi", ovvero gli
"
affrancati", (dal latino
francus = libero?)
e
il nuovo territorio
Franconia, da cui deriveranno Francia e Germania.
- Da QUI: In occasione di una seconda gravidanza di Elena, sorella minore di Costanzo, si mormorò che Eusebia avesse propinato alla cognata una pozione abortiva durante il viaggio ufficiale a Roma nell'aprile 357 per la celebrazione del ventennale di governo di Costanzo II. Giuliano non nominò quasi mai sua moglie, non le dedicò il minimo pensiero affettuoso e non ebbe mai parole di dolore per i figli che morivano. Elena, relegata a Lutetia, semplicemente non esisteva. Tutto lascia intendere che soffrisse di disturbi che consigliavano per lei una vita ritirata. Non bisogna dimenticare che sua madre Fausta era stata giustiziata da suo padre Costantino, nel dubbio ingiustificato di un adulterio consumato con Crispo, figlio maggiore dell'imperatore e anche lui eliminato. Elena non aveva che un anno quando la tragedia si compì e fu condannata a vivere senza madre, col solo conforto della sorella Costantina di dieci anni maggiore. Un secondo aborto si verificò in occasione del viaggio da Parigi a Roma. L'ultima gravidanza fu fatale a Elena, che morì senza che venisse registrato neppure il giorno esatto del decesso, fissato tra la fine del 360 e l'inizio del 361. Anche questa volta si favoleggiò di un intervento criminoso di Eusebia, che moriva negli stessi giorni.
- Da QUI: La bella Eusebia era stata colpita dalla più terribile delle malattie per un'imperatrice, la sterilità. Per curarsi doveva utilizzare potenti e pericolose pozioni, preparate sotto stretto controllo medico, che avevano effetti emorragici. Fu così che morì. Il fatto che disponesse di tali filtri indusse i suoi detrattori ad accusarla di averli fatti assumere anche alla cognata Elena, che non ne aveva certo bisogno. Mai Giuliano darà segno di raccogliere queste accuse. Il montaggio delle trame contro Eusebia potrebbe essere opera del partito cattolico. L'imperatrice e suo marito Costanzo II erano cristiani ariani, mentre Elena era cattolica e Giuliano notoriamente pagano. Elena si prestava ad assumere le caratteristiche di una novella martire e la sua storia utilizzata nella propaganda contro gli ariani. L'imperatrice venne tumulata in un sarcofago di porfido, il marmo rosso degli imperatori, nel mausoleo vicino a S. Agnese sulla Nomentana. Il mosaico che una volta ricopriva le pareti della cupoletta sopra il sarcofago raffigurava la Gerusalemme celeste con due figurette, che ritraevano Elena e sua sorella Costantina. Eusebia si era indelebilmente macchiata di fronte ai cattolici dopo il grandioso concilio svoltosi da gennaio a maggio 355 nella basilica ecclesìa nova (S. Tecla), fatta appositamente costruire dall'imperatore. L'esito del concilio fu drammatico: il vescovo cattolico Dionigi fu esiliato e al suo posto la corte impose il cappadocio Aussenzio, di lingua greca e credo ariano. La sua ignoranza del latino suscitò l'ostilità dei milanesi e il suo insediamento dovette avvenire sotto scorta armata. Le gerarchie cattoliche lo definirono lapidariamente "faccendiere" per i suoi stretti rapporti con la corte e addossarono la colpa dell'esilio di Dionigi alla perfida Eusebia. Perché non attribuirle anche gli attentati contro Elena?
Nel 360 -
Sapore (re dei Sasanidi; l'Impero sasanide è stato l'ultimo impero persiano preislamico il cui nome nativo "Eran Shahr" significava Impero ariano, dal
sanscrito ariyà, cioè "
signore") prese le fortezze orientali di Singara e Bezabde;
Costanzo II, obbligato a riprendere le ostilità con i Sasanidi, richiese al cesare Giuliano alcune sue truppe, anche allo scopo di assicurarsi che non potesse progettare l'usurpazione, ma
le truppe galliche si ribellarono all'idea di essere mandate in oriente e
proclamarono augusto Giuliano, figlio di Giulio Costanzo, che aveva dato valide prove di capacità militari difendendo la Gallia da vari tentativi d'invasione: fu l'inizio di una nuova
guerra civile. Costanzo decise che la guerra contro i Sasanidi avesse la precedenza sulla ribellione di Giuliano, e nella primavera del 360 iniziò la propria campagna orientale, occupando Edessa e cercando di riprendere Bezabde; l'attacco però fallì e Costanzo decise di ritirarsi a svernare ad Antiochia di Siria.
- Nel 360 nell'ambito del cristianesimo, l'arianesimo stava soppiantando quasi del tutto il cattolicesimo niceno di Paolo di Tarso. Sembra infatti che la la dinastia imperiale dei Costanzi fosse di fede ariana, escludendo Giuliano. La stesura della Bibbia in gotico dell'ariano Ulfila, aveva fatto sì che una parte di Visigoti e Ostrogoti si convertisse a quella fede, abbandonando il paganesimo germanico. Longobardi, Alani, Vandali e Burgundi erano già tutti ariani. Nell'impero d'Occidente, sotto gli auspici dei Visigoti, l'arianesimo diverrà la forma di cristianesimo predominante in Spagna, nei Pirenei e in Occitania.
Nel 361 -
Da
QUI:
Costanzo II aveva subìto il fascino e il potere di Eusebia, ma questo non gli impedì di
risposarsi subito per garantirsi la discendenza, e la prescelta fu
Faustina. Era il terzo matrimonio e fu celebrato ad Antiochia. A Costanzo non fu però concesso di conoscere chi lo avrebbe rappresentato fra i posteri, perché morì prima che la moglie desse alla luce, all'inizio del 362,
Flavia Costanza, detta quindi
Postuma.
- Ad Antiochia, all'inizio dell'anno 361, Costanzo II sposa la quattordicenne Faustina, sua terza moglie, quindi Eusebia doveva essere già morta nel 360, forse per una malattia all'utero o a causa di una medicina datale per curarne l'infertilità. Faustina (347 - dopo il 365) darà all'imperatore il tanto sospirato erede, Flavia Massima Faustina Costanza (futura moglie dell'imperatore Graziano), che però nacque dopo la morte del padre. Quando l'usurpatore Procopio si rivolterà a Graziano nel 365, penserà di garantirsi la lealtà delle truppe tenendo in ostaggio Faustina e la figlia, che presenzieranno sia all'elevazione al trono di Procopio che agli inizi delle sue battaglie; probabilmente pensando di testimoniare così la sua appartenenza alla stirpe costantiniana. Nel 361 l'imperatore Costanzo II riprese inizialmente la campagna sasanide, muovendo su Edessa e da qui su Ierapoli, ma poi riprese la strada per Antiochia, muovendo contro a Giuliano, che col suo esercito stava procedendo verso oriente. Lo scontro fratricida tra gli ultimi due membri della dinastia costantiniana però non avvenne; partito da Tarso in autunno, il 3 novembre, Costanzo II morì per una febbre mentre si trovava ancora in Asia, a Mopsucrenae. Il senato di Roma, con un atto di consecratio, lo divinizzò. Costanzo aveva 44 anni e ne regnava da 24.
-
L'imperatore Giuliano (331-363 d.C.) istituisce uno
speciale tribunale per giudicare i funzionari corrotti e l'eunuco Eusebio, riconosciuto autore delle false accuse contro Gallo, è condannato
a morte nel 361 d.C.
Nel 362 - Da QUI: Nasce Flavia Costanza, figlia di Faustina e del defunto Costanzo II, detta quindi Postuma. La sorte di questa piccina pare essere segnata sin dall'infanzia. Orfana di tanto padre, venne strumentalizzata dall'usurpatore Procopio nel 365 per garantirsi il favore dei soldati fedeli alla memoria di Costanzo. Procopio era parente di Basilina, moglie di Giulio Costanzo e madre di Giuliano, e questa parentela con la famiglia regnante lo autorizzava a proclamarsi difensore della discendente imperiale: portava in giro per gli accampamenti su una lettiga la vedova Faustina e la piccina come degli ostaggi. Procopio venne ucciso dall'imperatore Valente, fratello di Valentiniano I, e di Faustina non abbiamo altre notizie; la figlia Costanza venne giocata come pedina dinastica per sancire la continuità tra la discendenza di Costantino e quella del nuovo imperatore Valentiniano I, che nel 374 le imporrà il suo mite figlio Graziano che era stanziato a Treviri, nel nord delle Gallie, l'attuale Trier; nel Land tedesco Renania Palatinato, sul fiume Mosella a circa 15 km dal confine con il Lussemburgo. Ma il viaggio per raggiungere lo sposo a Treviri non fu senza incidenti: “mentre pranzava in una pubblica villa chiamata Pristensis, poco mancò che fosse fatta prigioniera dai Quadi, se per la protezione di una divinità propizia non si fosse trovato sul luogo il governatore della provincia pannonica Messalla, che la fece salire su una carrozza del servizio postale e la ricondusse di gran carriera a Sirmio, lontana da lì ventisei miglia. Così per questo caso fortunato fu sottratta al rischio di una miseranda schiavitù la regale fanciulla, la cui cattura, se non se ne fosse ottenuto il riscatto, avrebbe inferto una grave iattura allo stato romano”. La vita di Costanza non fu peraltro né lunga né felice: dopo aver messo al mondo nel 379 un maschietto, del quale si ignora persino il nome, Costanza morì nel 383 e il 12 settembre dello stesso anno la sua salma fu trasferita nel mausoleo imperiale di Costantinopoli.
- Costanza era la figlia che l'imperatore della dinastia costantiniana Costanzo II aveva avuto dalla terza moglie Faustina, nata dopo la propria morte e fu l'unica sua discendente. Faustina era stata introdotta a corte dall'eunuco Eutropio in un momento di grave difficoltà per Costanzo II, allora privo di figli e probabilmente sterile, considerati gli esiti dei suoi precedenti matrimoni. Non è da escludersi che la determinazione degli eunuchi di vederlo padre, per assicurare a lui, non meno che a se stessi, la continuità dell'imperio, li avesse spinti a dei sotterfugi per rendere gravida Faustina. In seguito Giuliano, ribellatosi a Costanzo e a questi succeduto, permise che moglie e figlia del defunto imperatore rimanessero indisturbate a corte negli anni successivi. Da quando l'usurpatore Procopio si era ribellato nel 365 all'imperatore Graziano, utilizzava Costanza e la madre Faustina per convincere delle truppe di passaggio a disertare in suo favore; la sua strategia era quella di contrapporre al legittimo imperatore Valente le proprie pretese dinastiche, in quanto membro della dinastia costantiniana (sua madre era sorella di Basilina, madre dell'imperatore Giuliano), e il supporto della moglie di Costanzo gli fu prezioso. Si racconta che nel corso di una invasione di Quadi e Iazigi nel 374, poco mancò che Costanza fosse catturata dai barbari inferociti, riuscendo invece a rifugiarsi a Sirmio. E sempre intorno al 374, Costanza sposò l'imperatore Graziano, collegando così la dinastia di Costantino I a quella di Valentiniano I. Si avrà notizia dell'arrivo delle sue spoglie a Costantinopoli nell'agosto del 383.
 |
La campagne di Persia del 363
dell'imperatore Giuliano. |
Nel 363 - L'
imperatore Giuliano (Flavio Claudio Giuliano;
6 novembre 331- Maranga, 26 giugno 363), succeduto a Costanzo II e ricordato come l'
apostata, poiché da
filosofo quale era, aveva rinnegato il cristianesimo (era stato battezzato da bambino e non per volontà sua), inizia la campagna contro la Persia, in cui troverà la morte. Flavio Claudio
Giuliano, figlio di
Giulio Costanzo (fratello,
da parte del padre Costanzo Cloro, di Costantino I) e della sua
seconda moglie Basilina (che apparteneva a una nobile famiglia di
latifondisti della Bitinia; morì qualche mese dopo la sua nascita),
è stato l'
ultimo imperatore dichiaratamente
pagano.
Tentò, senza successo, di riformare e di restaurare la
religione romana vista la sua decadenza di fronte alla diffusione del
cristianesimo.
 |
Moneta in bronzo con l'effige
di Giuliano, di Classical
Numismatic Group, Inc. QUI,
CC BY-SA 3.0, QUI. |
Membro della dinastia costantiniana (che si affermava
fosse discesa da Claudio il Gotico e dai Flavi), fu Cesare in Gallia
dal 355 e un pronunciamento militare nel 361 seguito dalla morte del cugino Costanzo II, lo resero imperatore fino alla morte,
avvenuta nel 363 durante la campagna militare in Persia. Per
distinguerlo da Didio Giuliano o da Giuliano di Pannonia, usurpatore
dell'imperatore romano Carino nel 283-285 o di Massimiano nel 286, fu
chiamato anche Giuliano II, Giuliano Augusto, Giuliano il Filosofo o
Giuliano l'Apostata dai cristiani, che lo presentarono come un
persecutore ma, per quanto personalmente avverso al cristianesimo,
non ci furono comunque mai persecuzioni anticristiane
(anche se vennero emanate dall'imperatore politiche
discriminatorie contro i cristiani). Giuliano manifestò tolleranza
nei confronti delle altre religioni, compreso l'ebraismo, al punto da
ordinare la ricostruzione del tempio ebraico di Gerusalemme secondo
un programma di ripristino e rafforzamento dei culti religiosi
locali; il tentativo di ricostruzione però venne abbandonato. In
campo fiscale e amministrativo Giuliano aveva proseguito la politica
che aveva tenuto quando governava la Gallia. Ridusse il carico
fiscale, combatté la corruzione burocratica attraverso una più
attenta selezione e cercò di ridare un ruolo all'amministrazione
delle città. Con la morte di Giuliano si estinse la
dinastia degli imperatori costantiniani e si concluse l'ultimo
tentativo di espansione imperiale in Oriente.
Giuliano scrisse numerose opere di carattere filosofico, religioso,
polemico e celebrativo, in molte delle quali criticò il
cristianesimo. La sua ispirazione filosofica era in gran parte
neoplatonica.
- Flavio Claudio Gioviano (Singidunum, 331 - Dadastana, 17 febbraio 364) è imperatore romano dal giugno 363 alla sua morte, avvenuta dopo otto mesi. Figlio del comes domesticorum Varroniano, Gioviano divenne comandante dei protectores domestici (primicerius) dell'esercito di Giuliano, dopo le dimissioni del padre. Il 26 giugno 363, l'imperatore Giuliano era rimasto ucciso in seguito alle ferite riportate in una battaglia contro i Sasanidi e Gioviano, che "godeva di una modesta fama per i meriti paterni", venne eletto (avventatamente a parere di Ammiano Marcellino) imperatore da un consiglio di comandanti dell'esercito e delle legioni, dopo che la scelta su Salustio, prefetto del pretorio d'Oriente, di maggiore esperienza, era stata rifiutata dallo stesso che adduceva motivi di salute e vecchiaia. Una volta ottenuto il potere, Gioviano concluse con l'impero persiano una pace svantaggiosa per Roma, abbandonando i territori che Galerio aveva conquistato in Mesopotamia nel 297, comprese le fortezze di Singara e Nisibi (più altri 15 castelli), e lasciando di fatto l'Armenia sotto il controllo dell'Impero persiano. Gioviano abrogò inoltre i decreti del suo predecessore contrari alla chiesa cristiana (era egli stesso un cristiano), pur mantenendo una politica di tolleranza verso tutte le religioni, attirandosi l'odio e il sospetto dello stesso Ammiano (pagano, noto per l'appoggio dato a Giuliano), che questi definisce un debole, succube del Cristianesimo e incapace politicamente (a motivo della sua età giovane e della mancanza di esperienza). Gioviano morì il 17 febbraio 364, dopo soli otto mesi di regno, probabilmente avvelenato casualmente dalle esalazioni di un braciere che teneva nella sua stanza a Dadastana in Bitinia, mentre tornava con l'esercito dalla disastrosa spedizione militare contro l'Impero persiano; tra l'altro Ammiano Marcellino riporta che l'opinione prevalente era che l'imperatore fosse morto per indigestione.
- Da
QUI: Alla morte di Costanzo II, l'impero era passato al cugino
Giuliano,
trafitto a morte nel 363
da una lancia, che non si seppe mai da
quale esercito fosse stata
scagliata.
Gioviano, il
protector domesticus (ufficiale delle guardie palatine) che aveva accompagnato la salma di Costanzo II a Costantinopoli, assunse le
redini dello Stato. Suo suocero Lucilliano, ritiratosi dalla carriera militare a Sirmio, venne inviato a Milano come
magister equitum et peditum (comandante supremo della cavalleria e fanteria) per porre rimedio alla situazione incerta creatasi dopo la morte di Giuliano. Lucilliano doveva portare con sé persone fidate e la scelta cadde su Seniauco e
Valentiniano. La
reazione milanese alla notizia della
morte di Giuliano fu talmente
violenta che solo Valentiniano scampò all'eccidio che ne era seguito. Poi, per un improvviso
colpo di fortuna, colui che poco prima aveva temuto per la vita si vide innalzare al comando dello Stato quando
Gioviano morì il 17 febbraio 364.
Valentiniano I aveva allora quarantatré anni, con un fisico atletico, splendido
colore di capelli, occhi azzurri dallo sguardo obliquo e inquietante,
statura elevata e tratti armoniosi. Era originario della Pannonia,
pagano appena
convertito al cristianesimo (
indifferente
alla
distinzione fra cattolici e ariani); Ammiano lo descrive
come scrittore dignitoso, di eloquio vivace ed incisivo, pittore e
scultore piacevole, inventore di nuove armi, amante dell'eleganza;
per controparte aveva un pessimo carattere: autoritario fino alla
crudeltà per esigere disciplina e obbedienza, con
eccessi di
collera incomprensibili per l'educazione classica romana,
implacabile e sommario nell'emettere sentenze e affrettare giudizi.
Come
sede della sua corte aveva inizialmente scelto
Milano,
dove soggiornò dal novembre
364 alla fine del
365, poi
si spostò a
Lutetia per dirigere le campagne contro gli
Alamanni. I frequenti e micidiali
attacchi di febbre cui
andava soggetto gli consigliarono di associare alla guida
dell'impero, già
dal 367,
il figlio
Graziano di soli otto anni, onde garantire la
continuità dinastica in caso di peggioramento delle sue
condizioni. Nel discorso che Valentiniano pronuncia nella cerimonia
c'è già il ritratto del futuro sfortunato imperatore: "Non è
stato educato come noi sin dalla culla a un'inflessibile disciplina,
né è maturato nel sostenere le difficoltà... (ma) poiché è stato
educato negli studi letterari e nelle discipline che allenano
l'intelligenza, esaminerà con retto giudizio il valore delle azioni
buone e malvagie; farà in modo che gli onesti sappiano di essere
compresi..." (Am. Mar. XXVII 6, 8-9). Poi
la corte di spostò a Treviri,
e qui entrò in scena
Giustina.
 |
Solidus di Valentiniano
I (Cibalae, Vinkovci in
Croazia, 3/07/321 -
Brigetio, 17/11/375).
Cristiano, abbandonò
il paganesimo di
Giuliano l'Apostata.
Di Siren-Com-Opera
propria, CC BY-SA
|
Nel 364 - Dopo la morte di
Gioviano, dopo soli otto mesi di regno, il 23 febbraio l'esercito e
la corte eleggono imperatore Flavius Valentinianus o
Valentiniano I, figlio di Graziano il Vecchio, un prominente
ufficiale di origine pannonica dell'esercito romano durante gli
imperi di Costantino I e Costante I. Poco dopo la sua elezione,
Valentiniano I affida le province orientali al fratello minore
Valente e poco dopo associa al potere della parte occidentale
anche il figlio avuto dalla sua prima moglie, Graziano.
Valentiniano, Valente e Graziano erano cristiani, quindi abbandonarono la
politica di Giuliano in campo religioso, mentre sul piano militare,
amministrativo e fiscale, i Valentiniani seguirono invece la linea
del predecessore. Grazie a una nuova politica monetaria, che favoriva
lo scambio fra monete d'oro, d'argento e di bronzo, riuscirono a
frenare l'inflazione galoppante ma dovettero affrontare l'emergenza dei
barbari che premevano sui confini
della Germania con la costruzione di un poderoso limes
che andava dal Mare del Nord, in corrispondenza della foce del Reno,
alle Alpi Retiche. Valentiniano, come e ancor più dei suoi
predecessori, fece frequente ricorso al reclutamento di mercenari
nell'esercito, con il conseguente accesso alle magistrature
civili e militari di molti Germani e la graduale
"barbarizzazione" dei quadri dell'amministrazione,
della burocrazia e dell'esercito.
 |
Solidus di Flavio Giulio Valente
(Cibalae, Vinkovci città della Croazia,
328 - Adrianopoli, 9 agosto 378),
imperatore d'Oriente, da: QUI. |
- I
Tervingi (dal 395 chiamati Visigoti) condotti da Atanarico, pur essendone alleati, entrano in
conflitto con l'Impero Romano per appoggiare l'usurpazione di Procopio contro l'imperatore d'Oriente Valente, pianificando una
rivolta. Definito "l'
ultimo vero
romano",
Valente non riuscì a ben governare, tanto da pensare di abdicare e poi suicidarsi a causa di Procopio, che gli si era ribellato autonominandosi imperatore.
Nel 365 - A Costantinopoli, l'usurpatore Procopio è incoronato imperatore. Procopio (Cilicia, 326 - 27 maggio 366), membro della dinastia costantiniana (sua madre era sorella di Basilina, madre dell'imperatore Giuliano, di cui era quindi cugino), aveva corrotto due legioni, armato schiavi e volontari e preso la capitale senza spargimento di sangue, tra la sorpresa degli abitanti che lo sostennero poiché avevano in odio il patricius Petronio, suocero dell'imperatore Valente e probabilmente grazie ad una cospirazione di corte. Il 28 settembre 365, Procopio è incoronato imperatore dal senato di Costantinopoli e penserà di garantirsi la lealtà delle truppe esponendo Faustina (terza moglie di Costante II) e la figlia Costanza, che presenzieranno sia alla sua all'elevazione che agli inizi delle sue battaglie; probabilmente Procopio pensava così di testimoniare la sua appartenenza alla stirpe costantiniana.
 |
Damaso, mosaico
in S. Paolo fuori le
mura, a Roma.
|
Nel 366 -
Dopo furiosi
scontri costati 137 morti fra due fazioni cristiane,
Damaso I è l'unico vescovo (quindi papa) di Roma. Damaso I (Roma o Guimarães, 305 ca. - Roma, 11 dicembre 384) fu il 37º papa della Chiesa cattolica, che lo venera come santo. Fu papa dal 1º ottobre 366 alla sua morte. Figlio dell'iberico Antonio (prete aggregato alla chiesa di San Lorenzo) e di una certa Laurentia, si è ritenuto per molto tempo che fosse nato nell'attuale Portogallo, ma ricerche storiche più recenti sembrano indicare che egli possa essere nato a Roma; di certo crebbe a Roma al servizio della chiesa di San Lorenzo martire. Morto papa Liberio il 24 settembre 366, il clero romano si divise in due fazioni: una, favorevole alla politica del defunto antipapa Felice II, del tutto contraria ad ogni accordo con i sostenitori delle teorie ariane (nonostante Felice II fosse ariano), e l'altra, maggioritaria, più conciliante e favorevole ad accordi e compromessi. In due distinte e contemporanee elezioni, i primi, riuniti nella basilica di Santa Maria in Trastevere, elessero e consacrarono frettolosamente
papa il diacono
Ursino, mentre i secondi, nella basilica di San Lorenzo in Lucina,
scelsero Damaso, che fu consacrato nella basilica di San Giovanni in Laterano il 1º ottobre 366. Molti dettagli degli avvenimenti che seguirono a questa elezione vennero narrati nel "Libellus Precum", una petizione all'autorità civile da parte di Faustino e Marcellino, due presbiteri della fazione di Ursino e dallo storico pagano
Ammiano Marcellino che così
narrava: «L'ardore di Damaso e Ursino
per occupare la sede vescovile superava qualsiasi ambizione umana. Finirono per affrontarsi come due partiti politici,
arrivando allo
scontro armato,
con
morti e
feriti; il prefetto, non essendo in grado di impedire i disordini, preferì non intervenire. Ebbe la meglio Damaso, dopo molti scontri; nella basilica di Sicinnio, dove i cristiani erano riuniti, si contarono 137 morti e dovette passare molto tempo prima che si calmassero gli animi. Non c'è da stupirsi, se si considera lo splendore della città di Roma, che un premio tanto ambito accendesse l'ambizione di uomini maliziosi, determinando lotte feroci e ostinate. Infatti, una volta raggiunto quel posto, si gode in santa pace una fortuna garantita dalle donazioni delle matrone, si va in giro su di un cocchio elegantemente vestiti e si partecipa a banchetti con un lusso superiore a quello imperiale». Il prefetto di Roma era un tal Vivenzio Scisciano che attese che si concludessero i disordini per prendere posizione nella contesa e una volta accertata la vittoria del partito di Damaso, esiliò da Roma Ursino. Ma i suoi seguaci non vollero accettare la sconfitta e si rifugiarono nella basilica di Santa Maria Maggiore, che i damasiani il 26 ottobre assalirono e dove si accese una vera e propria battaglia, con le conseguenze citate da Ammiano. Damaso amava il fasto e gli spettacoli e non esitava a commissionare grandi opere: sotto il suo pontificato la residenza papale assunse un aspetto principesco e grazie a donazioni, la Chiesa iniziò ad accumulare ricchezze. In tal senso, un decreto imperiale del 370 proibì agli ecclesiastici di far visita a vedove ed ereditiere per evitare che le inducessero a fare donazioni alla Chiesa. Nel 378, alla corte imperiale sarà mossa
contro Damaso anche un'accusa di adulterio, dalla quale sarà scagionato prima dall'Imperatore Graziano e poco dopo da un sinodo romano di quarantaquattro vescovi, che scomunicherà per giunta i suoi accusatori.
Nel 367 - L'imperatore romano
Valente attacca i goti Tervingi a nord del
Danubio ma non riuscirà a combattere direttamente contro di loro,
apparentemente a causa del fatto che i Goti si erano ritirati sui
Montes Serrorum (probabilmente i Carpazi). Secondo Ammiano
Marcellino, Valente non trovò nessuno con cui combattere (nullum
inveniret quem superare poterat vel terrere) e questo proverebbe
che fuggirono terrorizzati sulle montagne (omnes formidine
perciti... montes petivere Serrorum). Nell'anno seguente
l'inondazione del Danubio impedì ai romani di
attraversarlo. Nel 369 Valente penetrò profondamente in territorio
gotico, vincendo una serie di schermaglie con i Grutungi (e forse
anche con i Tervingi). Il tutto si concluse però con un trattato di
pace.
Nel 368 -
Gli
Alemanni travolgono Mogontiacum (Magonza, l'attuale Mainz) e costringono
l'imperatore Valentiniano I ad accorrere, insieme al figlio ed
augusto Graziano. I due imperatori passano il Reno e si spingono
fino al fiume Neckar, dove ottengono un'importante vittoria sulle
genti germaniche nei pressi di Solcinium. A Treviri però, a Valentiniano giunge notizia che la
Britannia è
stata
devastata da
Pitti,
Attacotti e
Scoti, i
quali avevano ucciso i generali Nettarido e Fullofaude. Valentiniano
invia quindi in Britannia delle truppe al comando prima di
Severo, poi di Giovino e Protervuide ma, di fronte agli insuccessi
subiti, decide di inviare nell'isola il
valoroso comes (Conte)
Flavio Teodosio (il Vecchio, padre di
Teodosio I) che, sbarcato in Britannia,
riuscìrà a porre fine
alle incursioni annientando gli invasori e ripristinando
la pace. Il futuro
usurpatore Magno
Massimo combattè con Teodosio il
Vecchio nella campagna in Britannia, distinguendosi per le sue qualità militari contro i Pitti.
 |
| Dobrugia, da: QUI. |
Nel 369 - Mentre i suoi generali si spingevano nei territori dei Goti a nord, l'imperatore romano
d'oriente Valente, per domare la rivolta degli ex alleati goti Tervingi (poi chiamati Visigoti) di cui era re Atanarico, decide di passare il Danubio in Dobrugia
(regione situata tra il Danubio e il Mar Nero), nei pressi di
Noviodunum, avendone ragione. Atanarico, pur essendo stato
sconfitto, riuscì a negoziare una pace favorevole grazie al fatto che si era ritirato sui Carpazi, fuori dall'impero e furono così solamente sospesi i precedenti accordi conclusi con Costantino nel 332, basati sui sussidi (o tributi) offerti
dai Romani in cambio di contingenti mercenari, stabilità nella
regione e scambi commerciali. I goti Tervingi (poi chiamati Visigoti) che erano pagani della
tradizione mitologica scandinava, che erano la maggioranza,
riconoscevano come loro capo Atanarico, mentre la parte che si era
convertita al Cristianesimo di credo ariano, promosso da Ulfila,
faceva capo a Fritigerno, per cui i goti Tervingi (poi chiamati Visigoti) facevano capo ai due
condottieri in base al loro culto. Lo stesso vescovo Ulfila aveva
intrapreso la messa per iscritto della Bibbia, che divenne così il
primo testo in lingua gotica e la più estesa testimonianza delle
lingue germaniche antiche. Valente decise infine di fermarsi nella
Dobrugia, per migliorare le fortificazioni lungo il tratto del basso
corso danubiano.
- Da QUI: La cristiana di fede ariana Giustina,
che aveva solo dodici anni
quando il padre Giusto, governatore del Piceno, l'aveva consegnata
nel 352 al cinquantenne usurpatore Magno Magnenzio,
ricompare come signora dei palazzi imperiali di Treviri nel
369, quando diventa la legittima consorte dell'imperatore
Valentiniano I. E' la seconda volta che assurge al vertice del
potere sposando un generale, lei che era verosimilmente appartenente
alla dinastia costantiniana, probabilmente tramite sua
madre che potrebbe
essere stata o figlia di Crispo, il primogenito di Costantino I
(anche se identità e destino del figlio di Crispo ed Elena non sono
noti; è stato proposto comunque che fosse una femmina e che fosse la
madre dell'imperatrice Giustina da Harlow e altri) o di Giulio
Costanzo (fratellastro di Costantino). È noto che Giustina avesse
due fratelli, Costanziano e Cereale, entrambi ufficiali sotto
Valentiniano I. L'unione aveva fatto scandalo, perché
Valentiniano era ancora sposato con Marina Severa, che ripudiò in
favore di questa avvenente ventenne, tradizionalmente legata al suo
stesso partito politico. La storia della Chiesa non ha potuto
accettare che il padre del mite e cattolico Graziano
fosse stato bigamo ed ha quindi elaborato la leggenda che
Giustina, essendo rimasta orfana e vedova a tredici anni, avesse
fatto l'ancella di Marina Severa. L'imperatrice, colpita dalla
perfezione del suo corpo, ne avrebbe parlato in maniera entusiasta al
marito, che avrebbe promulgato una legge per ammettere il concubinato
per gli imperatori (Paredi, p. 147). Secondo alcune fonti Giustina
divenne la concubina di Valentiniano I nel 363 e ne
suggestionò le decisioni a favore del vescovo ariano
Aussenzio nel 364. Secondo altri l'unione ebbe luogo nel 369 a
Treviri. Giustina (probabilmente 340 - 388) è
stata un'imperatrice romana, seconda moglie dell'imperatore romano
Valentiniano I e la madre del futuro imperatore Valentiniano II,
oltre che di Galla, Grata e Giusta. Era la figlia di Giusto,
governatore di Picenum sotto Costanzo II, che l'imperatore aveva
fatto uccidere in quanto, come racconta Socrate Scolastico, il
governatore fece un sogno che l'imperatore interpretò come un
presagio di rivolta.
Nel 371 -
Nasce Valentiniano II, uno dei figli che l'imperatore della parte occidentale Valentiniano I aveva avuto dalla sua seconda moglie, la cristiana ariana Giustina, insieme alle sorelle Galla, Grata e Giusta. Era il secondo figlio maschio di
Valentiniano, che aveva già avuto Graziano da un precedente matrimonio.
Nel 374 -
Sappiamo che avvenne
l'
uccisione a tradimento, dopo un banchetto, del
capo dei
Suebi Quadi, Gabinio, da parte del prefetto del pretorio delle Gallie,
Massimino, che rese furiosi non solo i Quadi, ma molte altre
popolazioni a loro vicine (come i Sàrmati
Iazigi ed i
Vandali),
che insieme
inviarono squadre di
saccheggiatori a sud del
Danubio
in territorio romano. Furono così senza alcun preavviso assaliti i contadini impegnati nel raccolto delle messi, molti dei quali furono sterminati mentre altri furono fatti prigionieri e condotti con molti animali di ogni tipo nei loro territori. Poco mancò che anche la stessa figlia dell'imperatore Costanzo II, Flavia Massima Faustina Costanza, venisse catturata dai barbari inferociti, riuscendo invece a rifugiarsi a Sirmio.
 |
| Ambrogio di Milano. |
- Il 7 dicembre 374
Ambrogio è nominato
vescovo di
Milano. Aurelio Ambrogio, meglio conosciuto come sant'Ambrogio (Treviri, 339/340 - Milano, 397) è stato un vescovo, scrittore e santo romano, una delle personalità più importanti nella Chiesa del IV secolo. È venerato come santo da tutte le Chiese cristiane che prevedono il culto dei santi; in particolare, la Chiesa cattolica lo annovera tra i quattro massimi dottori della Chiesa d'Occidente, insieme a san Girolamo, sant'Agostino e san Gregorio I papa. Conosciuto anche come Ambrogio di Treviri, città in cui era nato e in cui il padre esercitava la carica di prefetto del pretorio delle Gallie, intorno al 339 circa, proveniva da un'illustre
famiglia romana di rango
senatoriale, la
gens Aurelia, cui la famiglia materna apparteneva inoltre al ramo dei Simmaci. La famiglia di Ambrogio, a cui apparteneva Santa Sotere, martire cristiana, Marcellina e Satiro di Milano, risultava convertita al cristianesimo già da alcune generazioni. Destinato alla carriera amministrativa sulle orme del padre, dopo la sua prematura morte frequentò le migliori scuole di Roma, dove compì i tradizionali studi del
trivium e del
quadrivium (imparò il greco e studiò diritto, letteratura e retorica), partecipando poi attivamente alla vita pubblica dell'Urbe. Dopo cinque anni di avvocatura esercitati presso Sirmio (l'odierna Sremska Mitrovica, in Serbia), nella Pannonia Inferiore, nel 370 fu incaricato quale governatore dell'Italia Annonaria per la provincia romana Aemilia et Liguria, con sede a Milano, dove divenne una figura di rilievo nella corte dell'imperatore Valentiniano I. La sua abilità di funzionario nel dirimere pacificamente i forti contrasti tra ariani e cattolici gli era valso un largo apprezzamento da parte dei cattolici e tutta la
sua opera finirà per far
primeggiare il
cattolicesimo sull'arianesimo, grazie alla sua
influenza sugli imperatori, in particolare
Graziano e
Teodosio I. Nel 374, alla morte del vescovo ariano Aussenzio di Milano, il delicato equilibrio tra le due fazioni sembrò precipitare. Il biografo Paolino racconta che Ambrogio, preoccupato di sedare il popolo in rivolta per la designazione del nuovo vescovo, si recò in chiesa, dove all'improvviso si sarebbe sentita la voce di un bambino urlare «Ambrogio vescovo!», a cui si unì quella unanime della folla radunata nella chiesa. I milanesi volevano un cattolico come nuovo vescovo. Ambrogio però rifiutò decisamente l'incarico, sentendosi impreparato: come era in uso presso alcune famiglie cristiane all'epoca, egli non aveva ancora ricevuto il battesimo, né aveva affrontato studi di teologia. Ma alla fine accettò l'incarico, considerando che fosse questa la volontà di Dio nei suoi confronti e decise di farsi battezzare: nel giro di sette giorni ricevette il battesimo nel battistero di Santo Stefano alle Fonti a Milano e venne ordinato vescovo. Conosciuto comunemente come Ambrogio di Milano, la città di cui assieme a san Carlo Borromeo e san Galdino è patrono e della quale è stato vescovo dal 374 fino alla morte, le sue spoglie sono conservate a Milano, nella basilica a lui dedicata.
Per eventuali approfondimenti vedi "Storia dell'Europa n.36: dal 326 al 374 e.v. (d.C.)"
QUI.
 |
Solidus di Flavio Graziano
(Sirmio, Sremska Mitrovica
in Serbia, 04/05 359 -
Lugdunum, 25/08/383), sotto
l'influenza di Ambrogio avviò
una politica anti-pagana. Di
Rasiel Suarez - Opera propria,
|
Nel 375 - Durante il regno di Valentiniano I, l'impero è ripetutamente devastato da invasioni barbariche. Nel 375, alla notizia di un'
invasione da parte della tribù dei
Quadi, si dice che
Valentiniano I sia stato preso da un tale
accesso di
collera da stramazzare al suolo,
morendo per un'
emorragia cerebrale, anche se secondo altre fonti, l'imperatore Valentiniano I mosse guerra ai Quadi nei loro stessi territori a nord di Brigetio e fu proprio in questa località che l'imperatore si spense per un colpo apoplettico durante le trattative di pace, il 17 novembre del 375.
Brigetio (l'odierna
Komárom, sul Danubio) era una località appartenente all'antica tribù degli Azali, di chiara origine illirica, ma con connotazioni anche celtiche, tanto che l'origine del suo nome deriverebbe proprio dal
celtico brig-, col significato di "
fortezza". Si trova nel territorio della moderna Ungheria, mentre in Slovacchia, al di là del Danubio sorge l'equivalente Komárno.
Valentiniano I lasciava il sedicenne
Graziano (figlio avuto dalla prima moglie Marina Severa) suo co-imperatore d'Occidente a Treviri, in attesa dell'arrivo della promessa sposa, al
comando dell'impero d'
occidente mentre in oriente aveva posto al governo il fratello
Valente. Lasciava inoltre la moglie Giustina con quattro figli: Valentiniano nato nel 371, Grata, Giusta e Galla, tutti a Sirmio. Proprio in quei giorni e in quei luoghi, passava Flavia Massima
Costanza, la pustuma figlia dodicenne di Costanzo II, che da Costantinopoli transitava attraverso la Pannonia per
andare sposa a Graziano a Treviri. Ammiano Marcellino racconta che per poco non venne fatta prigioniera dai Quadi, se non fosse sopraggiunto un governatore romano a trarla in salvo nella fortezza di Sirmio. In Occidente, col giovane imperatore Graziano lontano, giovane e inesperto, l'esercito romano tentennava, valutando la possibilità di proclamare imperatore un proprio generale, tal Sebastiano.
 |
Flavio Valentiniano II, (371-
Vienne, 15 maggio 392) QUI. |
In Oriente invece, il generale
franco Merobaude, nominato
magister peditum, promuoveva l'immediata
elezione a
co-imperatore d'Occidente di
Valentiniano II, sostenuto anche dallo zio Cereale e dal
generale pannonico Equizio. Graziano cominciava così a sperimentare il
potere della matrigna Giustina, insediata a Sirmio, l'attuale Sremska
Mitrovica in Serbia. Anche altri alti funzionari imperiali, Massimino, Romano e Petronio Probo vollero porre
sul trono d'
occidente anche
Valentiniano II, figlio minore di Valentiniano I,
un bambino di quattro anni, facilmente manipolabile (la reggenza venne assunta dalla madre Giustina e quindi, di fatto, dal potente generale Merobaude), che divise l'impero d'occidente col fratellastro Graziano. A Valentiniano II andrà il governo di
Italia,
Africa e
Illirico, mentre a
Graziano rimarrà il comando su
Gallia,
Spagna e
Britannia. Giustina e Graziano sposteranno in seguito la
corte imperiale d'Occidente a
Milano, dove subito si aprirà lo
scontro con i cristiani
cattolici della città, guidati dal vescovo
Ambrogio, poiché
Giustina era
ariana, così come lo era stata d'altra parte la
dinastia imperiale dei
Costanzi.
 |
Pannonia con Sirmio, da QUI.
|
Da
QUI: Infatti pochi mesi dopo la presa del potere di
Giustina, si verifica il
primo dei grandi
scontri che
segneranno la storia di
Milano:
Giustina si misura con
Aurelio
Ambrogio, vescovo di Milano. Alla morte del vescovo di
Sirmio, Germinio, di credo ariano, la comunità cattolica aveva
chiamato il vescovo di Milano Ambrogio, quale metropolita della
grande diocesi, per sostenere la candidatura di un vescovo cattolico.
Ambrogio era noto alla popolazione di Sirmio per aver lavorato cinque
anni nella prefettura, al servizio di Sesto Petronio Probo, prima di
essere nominato governatore di Milano. Il biografo di Ambrogio,
Paolino, ci offre un vivace spaccato dello scontro avvenuto a Sirmio
(Vita Ambrosii, 11): "Era sul punto di essere scacciato dalla
chiesa da una moltitudine radunata dalla potenza dell'imperatrice
Giustina, affinché fosse ordinato un vescovo ariano non da lui ma
dagli eretici. Quando era nel presbiterio, senza curarsi per nulla
della sommossa aizzata da quella donna, una delle
vergini ariane,
più impudente di tutte le altre, salendo nel presbiterio afferrò la
veste del vescovo con l'intenzione di trascinarlo nella parte
occupata dalle donne, perché fosse battuto da loro e scacciato".
Per inciso questo episodio ci informa sull'esistenza di vergini
consacrate anche al credo ariano e sulla divisione delle navate, al
di sotto del presbiterio, a seconda dei sessi. Vincerà comunque
Ambrogio,
riuscendo a far eleggere un
vescovo
cattolico, Anemio.
- Nel 375 il sedicenne Imperatore d'occidente Graziano (sicuramente convinto dal vescovo Ambrogio), di religione cristiana cattolica, rinuncia alla carica
di Pontefice Massimo, che con Augusto era stata assorbita
dalla figura dell’Imperatore, per donarla al Vescovo di Roma che da lì in poi diventerà sinonimo di Papa. Graziano così opera
una netta distinzione fra potere politico e autorità
religiosa decretando comunque un primato di Roma
nell'ambito del Cristianesimo, in cui Costantino I aveva trasfuso
l'istituzionalità dell'Impero Romano. Nello stesso anno il co-imperatore d'Occidente Graziano ordina la rimozione, dall'atrio del senato, della statua della
Vittoria, provocando le vane proteste dei senatori pagani e
specialmente di Simmaco. Avverserà le sette eretiche e richiamerà alle loro sedi i vescovi orientali ortodossi, che l'arianeggiante
Valente aveva esiliati. Il mite e influenzabile Graziano, privo di qualità nell'ambito politico, ebbe il torto di favorire troppo l'elemento barbarico dell'esercito, che lo abbandonerà in un momento decisivo.
 |
| Nel 378 gli Unni scacciano i Goti. |
- Nel 375, incalzati dagli Unni che, giunti nel frattempo in Europa, avevano sconfitto gli Alani accogliendone i superstiti nel loro esercito e sottomesso i Goti dell'est o Greutungi (Ostrogoti), i goti Tervingi (poi chiamati Visigoti) sono scacciati dalla loro regione d'insediamento tra il Danubio e il Mar Nero.
 |
| L'antica Scizia. |
Nel 376 - I goti
Tervingi erano rimasti a
occidente della Scizia fino al 376, quando uno dei propri capi,
Fritigerno (convertito al cristianesimo ariano), chiede
all'imperatore romano Valente il permesso di insediarsi sulla riva
meridionale del Danubio. In questo luogo sperava di trovare
riparo
dagli
Unni. Valente concederà il permesso, ma la
carestia
che stava colpendo
Roma impedirà all'imperatore di fornire il cibo e la
terra promessi, fatto che causerà una rivolta seguita da sei anni
di saccheggi e distruzioni per tutti i Balcani. I goti
Tervingi (poi chiamati Visigoti), parte dei quali si erano ritirati in Transilvania con il pagano Atanarico, dopo aver perso gran parte delle loro ricchezze per le incursioni degli Unni, decide di passare con il cristiano ariano Fritigerno a chiedere asilo all'imperatore romano d'oriente Valente, accalcandosi in duecentomila tra le foci del Danubio, la Mesia e la Tracia. Secondo gli accordi, i goti sarebbero stati coscritti nell'esercito romano e a loro sarebbe stata concessa piena cittadinanza, ma in realtà non accadde niente di tutto questo. Anche i Greutungi (
Ostrogoti), senza essere invitati, entrano nei confini dell'impero. La presenza di troppe persone in un'area ristretta, come la provincia della
Mesia, che era stata loro assegnata, porterà ad una penuria di cibo che causerà l'inizio delle ostilità tra Romani e Goti. L'accoglienza romana ai Goti fu concessa ma malamente gestita: i Goti furono spogliati delle armi e privati dei bambini, consegnati come ostaggi, ma non venne adeguatamente assicurato loro l'approvvigionamento alimentare. La fame e gli stenti spinsero i Tervingi, guidati dal cristiano ariano Fritigerno, alla rivolta, a cui si unirono i Greutungi che avevano a loro volta passato il Danubio ed insieme
sconfissero l'
esercito romano a
Marcianopoli (l'attuale Preslav, nei pressi della città di Devnja, in Bulgaria dell'est).
 |
Invasioni nell'Impero Romano dal 375
Immagine modificata da: MapMaster-
Opera propria, CC BY-SA 2.5: QUI.
|
Nel 377 - Le popolazioni gotiche sono respinte dalla provincia di Tracia da alcuni generali di Valente, fino verso la Dobrugia, regione situata tra il Danubio e il Mar Nero, divisa ora tra la Dobrugia Settentrionale che fa parte della Romania e la Dobrugia Meridionale che è oggi parte della Bulgaria. Le città principali della regione rumena sono: Costanza, Mangalia, Tulcea, Medgidia e le città principali della regione bulgara sono Dobrič e Silistra.
 |
Mesia con evidenziata Adrianopoli,
in Tracia, da: QUI. |
Nel 378 - Disfatta dei Romani nella
battaglia di Adrianopoli. Mentre i goti
Tervingi (poi chiamati Visigoti) in
Mesia compievano ripetute razzie nelle regioni circostanti, sul fronte settentrionale una
nuova incursione alemannica era repressa da Graziano nella Battaglia di Argentovaria, nei pressi di Colmar, a cui seguì l'ultima spedizione romana al di là del Reno, nella foresta Ercinia. Il co-imperatore d'occidente
Graziano richiamò Teodosio il giovane,
al quale affidò l'incarico di respingere le nuove incursioni di Sarmati Iazigi in Pannonia e lo
nominò magister militum. Intanto la risposta dei
Goti non si fece attendere, infatti nel corso
di quell'anno
dilagarono fino a sud dei Balcani insieme
ad alcuni reparti degli stessi Unni. Riuscì però a fermarli il
magister peditum Sebastiano, che ne rallentò
provvisoriamente le incursioni. Poco dopo
mosse contro le
orde
barbariche lo stesso
imperatore d'oriente
Valente, che nella
successiva
battaglia di Adrianopoli, subì non solo una disastrosa
sconfitta, ma cadde egli stesso sul campo di battaglia. Valente,
per non dover
dividere il
successo con Graziano, figlio di suo fratello Valentiniano I e co-imperatore d'occidente, che
stava sopraggiungendo in forze, aveva deciso di dirigersi da solo contro i
Goti: disponeva probabilmente di 40.000 soldati contro un'orda
di circa 50.000 guerrieri più altri 50.000 cavalieri goti. Una volta
arrivato presso il cerchio di carri goto, Valente passò alcune ore a
disporre in campo l'esercito. In questa fase furono comunque avviate
trattative di pace: l'imperatore ricevette infatti una delegazione di
preti cristiani ariani che gli consegnarono una lettera da parte dell'ariano
Fritigerno (condottiero dei goti
Tervingi poi chiamati Visigoti) nella quale si prendeva
in considerazione l'ipotesi di intavolare delle trattative sulla
consegna ai Goti di terre, come era stato loro promesso ai tempi del
trasbordo del Danubio. Pare che il capo goto, in realtà, volesse rimandare il più possibile l'inizio della battaglia (cosa di cui era certo
Ammiano Marcellino) nella speranza che ritornassero in tempo le
squadre di cavalleria che si erano allontanate per foraggiare i cavalli. Ad un
tratto accadde l'
imprevisto:
due reparti di cavalleria
leggera romana schierati sull'ala destra e composti da arcieri a
cavallo, giunti a tiro dei barbari,
attaccarono di propria
iniziativa,
gesto che diede
inizio alla battaglia.
 |
| Battaglia di Adrianopoli. |
I reparti di Valente, in
inferiorità
numerica,
furono massacrati. Mentre i due schieramenti continuavano a scontrarsi, la cavalleria gota rompeva gli
equilibri colpendo il fianco sinistro romano che era rimasto
scoperto. I fanti romani, schierati in ordine compatto e con scarso
margine di manovra, non poterono resistere all'urto e lo
schieramento, dopo una ferrea resistenza, si sfaldò e si dette alla
fuga. Alla fine lo stesso imperatore rimase ucciso e i resti
delle forze romane si dettero alla macchia. Non si è mai saputo di
preciso in che modo
l'imperatore morì: forse fu colpito da
una freccia o forse, come si raccontò dopo la battaglia,
bruciò
vivo nell'incendio di una fattoria nella quale,
ferito, si
era riparato nottetempo e a cui i Goti avevano dato fuoco. Con lui
caddero anche due
comites (Sebastiano e Traiano), tre
duces,
trentacinque tribuni e circa 30.000 soldati persero la vita. In
seguito alla vittoria i barbari dilagarono nei territori intorno alla
città compiendo ogni genere di razzie e massacrando le popolazioni
romane. Il
magister equitum Vittore si salvò e portò la
notizia della sconfitta a Graziano, rimasto a oltre trecento
chilometri dal campo di battaglia. Il
comes (dal latino,
"
compagno") nell'antica Roma
era un nome ufficiale usato dagli accompagnatori di alcuni magistrati
e dal III secolo in poi fu sempre più spesso usato per i funzionari
imperiali fino ad essere un grado dell'esercito e
dell'amministrazione romana, ed evolutosi poi nel tardo Impero romano fino a diventare un titolo nobiliare nel Medio Evo:
conte.
 |
Carta con le date dell'avanzata della
migrazione dei Visigoti attraverso
l'Europa.
|
Teodosio accorse per frenare l'invasione dei Goti ma dovette in seguito riconoscere i goti
Tervingi (poi chiamati Visigoti) come
federati, che cominciarono così a percorrere l'impero in ogni direzione. La battaglia di Adrianopoli segna il momento culminante della
Guerra gotica, durata fino al 382. Gli Unni, giungendo fino all'Elba, spingevano intanto contro le frontiere romane anche i Germani occidentali che da allora, alla guida dei loro re, estesero sempre più i loro
insediamenti nelle provincie dell'
impero. Le violente incursioni degli Unni causarono
movimenti migratori anche da parte degli
Slavi occidentali, i
Venedi-Sclavini stanziati nelle terre a sud-ovest dell'Elba e dell'Oder, pur non essendo interessati direttamente dalle incursioni unne. Per reazione alla spinta degli Unni, si crearono
unioni tribali miste
di
Germani,
Slavi,
Sàrmati e
Mauri ma
non i
Goti, in via di conversione all'
arianesimo cristiano promosso da Ulfila, contro cui combattevano invece tribù Sarmatiche e Slave.
- In seguito al disastro di Adrianopoli dell'agosto del 378 in cui era stato ucciso l'imperatore d'oriente Valente,
Graziano si ritrovava a governare anche la parte
orientale dell'impero, ma sentendosi impreparato a fronteggiare da solo la pressione barbarica nominò, il 19 gennaio 379, il suo
magister militum Teodosio
imperatore d'oriente come
Teodosio I e da lì in poi gli imperatori romani e i loro successori avrebbero adottato una
nuova strategia di
contenimento nei confronti dei
barbari, cominciando ad adottare
politiche di
pacificazione basate sui sistemi di
hospitalitas e
foederatio, meccanismi che consentissero l'
integrazione e l'
assimilazione delle genti che premevano lungo il
limes romano. La disfatta di Adrianopoli inoltre, innescò un circolo vizioso
per il quale
le forze
militari romane iniziarono a fare
assegnamento, in modo sempre più esclusivo, sull'apporto dei
soldati di
origine barbarica, al punto che l’esercito giunse
ad essere costituito, in larga parte, da mercenari e truppe barbare
romanizzate oltre ai
dediticii, membri di comunità che erano volontariamente dipendenti da Roma. La battaglia segnò l’
inizio
del percorso che avrebbe portato alla
caduta definitiva dell’
Impero
(d'Occidente)
e al suo
sfaldamento per l'
incapacità
di gestire
un tassello basilare come quello
militare, a causa
delle sempre più frequenti pressioni che i militari stranieri
esercitavano sull'autorità imperiale, in termini di donativi,
privilegi e richieste che, a vario titolo, i vertici dell'esercito
insistevano a pretendere dagli imperatori. L'incapacità di far
fronte a queste domande, il rafforzarsi della posizione dei
comandanti barbari che disponevano spesso di un proprio e
autonomo esercito all'interno dell'impalcatura militare romana e l'acuirsi di forme di ricatto, costituirono i punti deboli del
potere romano. Questo
processo fu
contrastato e
arrestato con
successo alla metà del V secolo nella
Pars Orientis
dell'impero, mentre in occidente si svilupperà incontrastato
fino alla presa di potere di Odoacre nel 476.
- Da QUI: La vita alla corte imperiale
d'Occidente di Sirmio doveva essersi fatta pesante per l'incalzare
dei Goti, soprattutto dopo il disastro di Adrianopoli del 9
agosto 378, in cui era morto bruciato l'imperatore d'Oriente Valente,
cognato di Giustina. Graziano si trasferisce a Sirmio per essere più
vicino al teatro delle battaglie, ma alla fine dell'anno si consiglia
un trasferimento di Giustina e figli a Milano,
per il momento al sicuro da qualsiasi attacco. Il
trasferimento non piacque a nessuno: nè al vescovo Ambrogio
che temeva, a buona ragione, l'invasione delle truppe ariane al
servizio di Giustina e Valentiniano II, né a Graziano, che con il
vescovo stava intessendo un rapporto di amore filiale e tanto meno
alla stessa Giustina, che non tollerava rivali a corte. Paolino
(biografo di Ambrogio) continua così la narrazione (Vita Ambr., 12):
"Giustina, trasferita la corte a Milano nel 378, sobillava il
popolo con l'offerta di doni e di onori. Gli animi dei deboli erano
accalappiati da tali promesse: assegnava infatti tribunati e diverse
dignità a coloro che avessero rapito il vescovo dalla chiesa e
condotto in esilio". In effetti Giustina richiese per il
culto ariano l'assegnazione di una basilica e, di
fronte al netto rifiuto del vescovo, la fece occupare. Graziano
dovette intervenire ordinando ufficialmente il sequestro della
basilica per garantirne l'officiatura da parte ariana.
L'imperatrice-madre tentò di sostituire Ambrogio con Giuliano
Valente, vescovo cattolico ma con aperture verso l'arianesimo. Negli
atti del concilio di Aquileia del 381 Ambrogio lo accusa di
indossare collana e braccialetti come i Goti, cosa
doppiamente empia, e di turbare la chiesa milanese provocando tumulti
sia davanti alla sinagoga, sia nelle case degli ariani. La durezza dello scontro dovette non
poco sconcertare il giovane imperatore Graziano, che chiese ad
Ambrogio un fidei libellus e il vescovo compose per lui il De fide,
un'amplissima confutazione dell'arianesimo.
- Dopo secoli di ininterrotta dominazione romana, l'Hispania ne aveva assorbito totalmente la cultura latina, ne aveva adottato la lingua, i costumi e le leggi, acquisendo un'importanza fondamentale all'interno dell'Impero romano, tanto da dare i natali a due imperatori: Traiano e Teodosio I (mentre sulla nascita ispanica di Adriano sussistono seri dubbi) e ad alcuni importanti scrittori, fra cui Seneca e Marziale.
Nel 379 -
Il 19 gennaio 379, in seguito alla morte dell'imperatore Valente
nella disastrosa battaglia di Adrianopoli ad opera dei Goti,
l'imperatore Graziano associa il suo magister militum Teodosio (cristiano di origine ispanica) alla guida dello
stato, nominandolo imperatore romano d'Oriente. Flavio
Teodosio, conosciuto anche come Teodosio I (Coca, 11 gennaio 347 -
Milano, 17 gennaio 395), nacque a Coca in Hispania, nell'attuale
Provincia di Segovia (Castiglia e León), in una famiglia influente e
benestante dell'aristocrazia locale. Suo padre era Teodosio (detto
"il Vecchio" dagli storici per distinguerlo dal figlio),
funzionario imperiale di rango elevato, sua madre si chiamava
Termanzia. Teodosio I aveva un fisico ben proporzionato, i capelli
biondi e il naso aquilino. Uomo non privo di valore come ci viene
tramandato da Zosimo, il giovane Teodosio fece la carriera militare.
Condivideva la vita dei soldati e, pur amando la magnificenza e i
piaceri, sapeva ritrovare tutta la propria forza ed energia nei
momenti di pericolo. Teodosio fissò inizialmente la propria
residenza a Tessalonica. Graziano affidò a Teodosio il compito
di proteggere i confini dell'area dell'Illirico e dei Balcani e
quest'ultimo decise di ricostruire l'esercito romano che l'anno
precedente era stato distrutto dalle forze barbariche dei Goti.
Frattanto lungo il fronte renano l'imperatore Graziano era costretto
a respingere nuove invasioni di Alemanni e Franchi. Verso la fine del
379 Teodosio si ammalò gravemente e, come era usanza presso i
cristiani del tempo, venne battezzato.
- L'Illirico orientale è
aggiudicato dall'imperatore Graziano all'Impero d'Oriente governato
dall'ispanico Teodosio I, ma Stilicone
lo rivendicherà in
seguito per l'Occidente. L'Illiria, ripartita fra le due parti dell'Impero, sarà quindi fonte di continue dispute che inizieranno a profilarsi subito dopo la morte di Teodosio I.
- Da QUI: Il 19 gennaio
379 Graziano si
associa nell'impero, quale augusto d'Oriente, il
cattolicissimo generale Teodosio, il cui padre aveva fatto
giustiziare a Cartagine solo tre anni prima: dopo la vittoria di
Flavio Teodosio noto come Conte Teodosio o Teodosio il Vecchio o
Seniore sul ribelle Firmo in Mauretania, che si era ribellato a
causa delle vessazioni subite dal governatore romano della provincia,
il comes Africae Romano di cui Teodosio aveva rivelato le malefatte e
dopo la morte di Valentiniano I (novembre 375), Teodosio fu
arrestato, portato a Cartagine e giustiziato nella prima parte del
376, non prima di essersi battezzato. La decisione di Graziano era
stata suggerita, a quanto pare, dai cattolici milanesi. Infatti
Graziano è a Treviri da fine agosto 379 a primavera 380,
accompagnato da Manlio Teodoro, l'influente comes rerum privatorum a
capo della fazione cattolica milanese. Quali argomenti abbia usato
l'amico di Ambrogio per convertire alla propria fazione il duttile
imperatore non sappiamo, ma quando Graziano ritorna a Milano il 22
aprile 380 emana un editto che impone la confisca di
tutti i luoghi di culto a vantaggio dei cattolici e
impone che sia restituita ai cattolici una basilica sequestrata dagli
ariani non per sua iniziativa (Ambr., De spiritu I, 8, 19-21).
Nel 380 - Il 27 febbraio, viene emesso dagli imperatori
Teodosio I (imperatore d'oriente)
Graziano e
Valentiniano II che all'epoca aveva solo nove anni (co-imperatori dell'occidente), l'
editto di Tessalonica, conosciuto anche come "
Cunctos populos". Il decreto
dichiara il cristianesimo secondo i canoni del credo niceno la
religione ufficiale dell'
impero,
proibisce in primo luogo
l'arianesimo e secondariamente anche i
culti pagani. Per combattere l'eresia si esige da tutti i cristiani la confessione di fede conforme alle deliberazioni del concilio di Nicea. La nuova legge riconosceva alle due sedi episcopali di Roma e Alessandria d'Egitto il primato in materia di teologia. Ad Alessandria d'Egitto,
viene chiuso una prima volta
il Serapeo, tempio della tradizione religiosa ellenistica, che contiene la biblioteca con la memoria del pensiero ellenistico. La
popolazione alessandrina decide di desistere dall'
occupazione del tempio solo quando i messi imperiali leggono l'ordine dell'imperatore: per gli antichi, lo
scritto era
sacro e
maggiormente lo era
quello dell'imperatore, rappresentante in terra dell'
ordine divino.
 |
| Teodosio I. |
L'editto, pur proclamando il Cristianesimo religione di Stato dell'impero romano, non stabiliva alcuna direttiva specifica a proposito. Bisognerà attendere i cosiddetti decreti teodosiani, promulgati dallo stesso Teodosio I, che tra il 391-392 normarono l'attuazione pratica dell'editto di Tessalonica. L'editto di Tessalonica è ritenuto importante dagli storici in quanto diede inizio a un processo in base al quale «per la
prima volta una
verità dottrinale veniva
imposta come
legge dello Stato e, di conseguenza, la dissidenza religiosa si trasformava giuridicamente in
crimen publicum: ora gli eretici potevano e dovevano essere perseguitati come pericolo pubblico e nemici dello Stato». L’imperatore
Teodosio pensava
che dovesse essere la Provvidenza a sottomettere il cuore degli
uomini, trasformando “ogni ferocia in dolcezza”, come riferiva il
filosofo ed alto funzionario dello stato Temistio. Nello stesso anno Graziano inviò
alcuni generali per liberare l'Illiria dai Goti, consentendo a
Teodosio di entrare finalmente a
Costantinopoli il 24 novembre
del 380, al termine di una campagna militare durata due anni.
Durante il regno di Teodosio le regioni orientali rimasero
relativamente tranquille, anche se i Goti e i loro alleati,
insediatisi stabilmente nei Balcani, erano motivo di continuo
allarme. La tensione crebbe a poco a poco, tanto che, a un certo
punto, l'imperatore associato Graziano rinunciò a mantenere il
controllo delle province illiriche e si ritirò a Treviri, allora
compresa nel territorio della Gallia. La manovra aveva lo scopo di
consentire a Teodosio di portare avanti senza intralci le successive
operazioni militari. Un motivo di grave
debolezza degli
eserciti
romani del tempo era legato alla pratica di arruolare
contingenti fra le
popolazioni barbare e farli
combattere contro
altri
barbari, spesso etnicamente affini. Per tentare di limitare
gli effetti negativi che ne derivavano, Teodosio inviava ripetutamente
le nuove reclute in Oriente, nelle province più lontane dai confini
danubiani (soprattutto in Egitto), con la necessaria e costosa
conseguenza di doverle rimpiazzare con leve romane, politica non esente da inconvenienti:
oltre a improvvise defezioni si registrarono anche incomprensioni e
persino scontri armati fra romani e federati barbari. A Filadelfia,
in Lidia, federati goti diretti in Egitto incontrarono un'armata romana di ritorno e
ingaggiarono contro di essa una assurda e sanguinosa battaglia.
- Nel corso del 380 i goti Tervingi (poi chiamati Visigoti) di Fritigerno (convertitisi in cristiani ariani) devastano la Macedonia, mentre gli Ostrogoti di Alateo e Safrax conducono nuove incursioni in Pannonia. Al termine di queste nuove incursioni l'imperatore Graziano sarà costretto a concedere ad alcuni di loro di stanziarsi insieme ai Vandali come foederati in Pannonia.
- Da QUI: Il 30 settembre 380 a Sirmio, Graziano
e Teodosio sottoscrivono un accordo per una nuova sistemazione
dell'impero: Valentiniano II, di soli nove anni, controlla la
prefettura d'Italia, Illirico e Africa con sede a Milano; Graziano
viene spedito a Treviri a controllare le bellicose Gallie e Teodosio
si tiene il meglio, l'Oriente con sede a Costantinopoli. La frontiera
occidentale era l'inferno per i romani. Graziano lo capisce
immediatamente e il 29 marzo 381 è già di ritorno a
Milano con tutto il suo seguito. Ambrogio non può che
esultare per aver riottenuto il suo docile alleato, che per la Pasqua
gli fa riconsegnare la solita basilica occupata dagli ariani.
Giustina è stizzita e si sposta ad Aquileia e allora
Ambrogio va a portare guerra anche in quella città, facendo indire
con lettere di Graziano un sinodo provinciale che inquisisca
gli ariani. Come si direbbe oggi, era un processo chiaramente
politico e anche la lettura degli asettici atti processuali ci fanno
piombare in un clima cupo che prelude ai processi medievali. A Milano
la lotta contro Ambrogio è portata avanti con zelo da Macedonio, il
magister officiorum fedele a Giustina, che controllava diversi uffici
del palazzo imperiale, dalla segreteria alla schola di agentes in
rebus, opponendosi all'ingerenza di Ambrogio nelle questioni civili.
-
Concilio ecumenico di
Costantinopoli, cui presero parte
solo esponenti della Chiesa dell'Impero romano d'Oriente, in cui venne
ribadita l'uguaglianza tra le divinità del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo e nello specifico è accettato il dogma che
lo Spirito Santo procede dal Padre attraverso il Figlio (in latino:
ex Patre procedit). Successivamente, la sola Chiesa di Roma celebrerà un suo Concilio a Toledo, nell'anno 589 (sotto Papa Pelagio II), nel quale modificherà questo dogma e stabilirà che
lo Spirito Santo promana dal Padre e dal Figlio (in latino:
ex Patre Filioque procedit). Questa variazione non sarà accettata dagli altri patriarcati, soprattutto da quello di Costantinopoli, che intravvederà in questo cambiamento una sorta di
negazione del monoteismo, e si arriverà, nel 1.054 ad uno scisma della chiesa cristiana fra "cattolica" cioè universale, quella romana e "ortodossa", fedele al dogma di Nicea del 325, quella costantinopolitana.
- Dopo le invasioni dei goti Tervingi (poi chiamati Visigoti) dalla Tracia fino in Grecia e i saccheggi nei Balcani, il re visigoto Atanarico riesce a negoziare una pace, nel 381, col nuovo imperatore Teodosio I ottenendo che i Visigoti divenissero alleati ufficiali di Roma con un'autonomia che mai era stata concessa alle nazioni sottomesse dai romani. La pace verrà ratificata solo l'anno dopo, nel 382, dai nuovi capi dei Visigoti, tra cui Fravita, ed il trattato valse fino alla morte di Teodosio nel 395. Ai Visigoti, cui fu riconosciuto lo status di foederati, venne assegnata la Tracia settentrionale (province di Scythia e di Moesia Minor), ma una parte di essi fu insediata in Macedonia. Secondo la concezione del diritto germanico, i capi goti si ritenevano vincolati ai patti solo in forma individuale, e non già "statale". Da allora l'esercito Romano sarà costituito il larga parte da Sàrmati e Goti e comandato da capi goti (come Gaina) e imporrà a tutto l'impero il cristianesimo, contro il paganesimo, il cristianesimo ariano e ogni altra forma di eresia cristiana.
- Nel 381 il co-imperatore d'occidente Graziano sposta la
capitale dell'impero romano d'
Occidente da Treviri a
Milano.
Nel 382 - Concilio di Roma in cui papa Damaso I sancisce il primato di Roma in qualità di sede apostolica. In un periodo piuttosto burrascoso per il cristianesimo e nonostante le accuse a proprio carico, grazie alla sua forte personalità, Damaso si batté per il riconoscimento della supremazia della sede episcopale di Roma e difese con vigore l'ortodossia cattolica contro tutte le eresie. In due sinodi romani (368 e 369 o 370) condannò fermamente l'apollinarismo e il macedonianismo. Nel secondo dei due sinodi scomunicò Aussenzio, il vescovo ariano di Milano (che comunque mantenne la sede fino alla morte, nel 374, quando fu sostituito da Ambrogio). Il sinodo di Antiochia del 378 stabilì la legittimità di un vescovo solo se riconosciuto tale da quello di Roma, e forte di questo diritto (e spalleggiato dal vescovo Ambrogio di Milano che coniò, per l'occasione, la formula "Dove è Pietro, là è la Chiesa") depose immediatamente tutti i vescovi ariani. Nella lotta contro l'arianesimo, che fu sensibilmente ridotto anche per la favorevole politica degli imperatori Graziano in Occidente e Teodosio I in Oriente, si avvalse anche del grande aiuto di San Girolamo, ardente predicatore dell'ortodossia. Il momento era favorevole al dogmatismo cattolico, come è dimostrato dalla convocazione del Concilio di Costantinopoli (381), dove Damaso inviò i suoi legati e nel quale, oltre alla ferma condanna di tutte le eresie, venne affermata la divinità dello Spirito Santo e ribadito, in una formulazione più precisa, il "simbolo niceno" già affermato nel concilio di Nicea del 325. Damaso sollecitò san Girolamo (che fu anche suo segretario privato per qualche tempo) ad intraprendere la revisione delle antiche versioni latine della Bibbia, nota come "Vulgata". Grazie al suo impegno, la Chiesa orientale, nella persona di Basilio di Cesarea (nei confronti del quale Damaso nutrì però sempre dei sospetti), ne implorò l'aiuto e l'incoraggiamento contro l'arianesimo che laggiù era trionfante. Sulla questione dello scisma meleziano ad Antiochia di Siria, Damaso, con Atanasio di Alessandria prima e poi Pietro II di Alessandria (che ospitò a Roma durante l'esilio) parteggiò per la fazione di Paolino, considerato più rappresentativo dell'ortodossia di Nicea; alla morte di Melezio, Damaso cercò di assicurare la successione a Paolino nella sede episcopale di Licopoli. Il pontefice sostenne, inoltre, l'appello dei senatori cristiani all'Imperatore Graziano per la rimozione dell'altare della Vittoria dal Senato, fatto lì ricollocare dall'imperatore Giuliano e sotto il suo pontificato fu emanato il famoso "Editto di Tessalonica" di Teodosio I, (27 febbraio 380), che definiva il credo niceno (e quindi il Cristianesimo nella formulazione romana) come religione di stato. Oltre all'affermazione della formula nicena, che dunque toglieva di mezzo le dottrine ariane, l’editto definiva per la prima volta i Cristiani seguaci del vescovo di Roma “cattolici”, bollando tutti gli altri come eretici e come tali soggetti a pene e punizioni. Quando, nel 379, l'Illiria si staccò dall'Impero romano d'Occidente, Damaso si affrettò a salvaguardare l'autorità della Chiesa di Roma nominando un vicario apostolico nella persona di Ascolio, vescovo di Tessalonica. Questa fu l'origine dell'importante vicariato papale legato a quella sede. Damaso invocò il "testo petrino" (Matteo 16,18), e fu il primo papa a definire la chiesa romana "sede apostolica" (sedes apostolica), definizione utilizzata per tutto il millennio successivo e che rivendicava alla chiesa romana una posizione monopolistica con sovranità e primato su tutte le altre chiese. In contrapposizione con i decreti del Concilio di Costantinopoli I, il Concilio di Roma (382) decretò che la chiesa romana non era stata creata da un decreto sinodale, ma era stata fondata da due apostoli, san Pietro e san Paolo. Altra affermazione del Concilio romano fu quella secondo cui la chiesa romana era stata fondata per volontà divina. Il risultato ideologico conseguito da questo Concilio fu che la giustificazione storica e politica del primato della chiesa romana fu sostituita dall'affermazione di una legge divina che aveva fatto degli apostoli i suoi fondatori. La formula utilizzata nel Concilio per la prima volta "primato della chiesa romana" ebbe effetti decisivi nella storia papale successiva: da Damaso in poi, infatti, si nota un marcato aumento del volume e dell'importanza delle pretese di autorità e di primato da parte dei vescovi romani. Questo sviluppo dell'ufficio papale, specialmente ad Occidente portò un grande aumento dello sfarzo, che riguardava molti membri del clero romano, i cui costumi erano duramente redarguiti da san Girolamo, provocando il 29 luglio 370 un editto dell'imperatore Valentiniano I indirizzato al papa, che vietava ad ecclesiastici e monaci (e più tardi anche vescovi e monache) di perseguire vedove ed orfani per ottenerne regali e lasciti. Il papa impose che la legge fosse strettamente osservata. Damaso morì l'11 dicembre 384.
- Da
QUI: Nell'autunno del 382 le
legioni di
stanza nelle
Gallie, preoccupate dalla mancanza di un comandante
supremo che fronteggi l'inesauribile impeto delle invasioni
barbariche,
acclamano imperatore Magno
Massimo, un generale ispanico
cattolico e grande amico di Teodosio. Contemporaneamente da Milano
Graziano promulga una serie di
editti che
minano alle radici la
tradizione religioso-politico
romana: viene abolita la nomina per il
mantenimento delle
Vestali, vengono confiscati i beni a tutti i
collegi sacerdotali pagani e viene
rimosso l'
altare della
Vittoria
nel senato romano, sul quale giuravano fedeltà i senatori. Graziano
dispone che i sussidi tolti a sacerdoti e vestali vadano a favore dei
baiuli (facchini), vespillones (becchini) e tabellari (postini). Dal
canto suo
Ambrogio vieta i
refrigeria, i banchetti che si celebravano
sulla tomba nell'anniversario della nascita di un defunto. Ci resta
un'interessante descrizione del rito e della fatica a rinunciarvi
nelle Confessioni di S. Agostino (6, 2), relativamente alle abitudini
della propria madre Monica a Milano. Come monumenti imperituri di
tanto fervore cattolico, Graziano e Ambrogio promuovono a Milano la
costruzione di due basiliche extra-murane ma non cimiteriali, una a
sud, oggi nota come S. Nazaro e SS. Apostoli, l'altra a nord, S.
Simpliciano.
-
Teodosio I, nella sua carica di imperatore d'Oriente, accetta di concludere
con i
Goti un
foedus stipulato il 3 ottobre 382, trattato che li autorizzava a stanziarsi lungo il corso del
Danubio, nella diocesi di Tracia e di godervi un'ampia
autonomia. In seguito
molti di loro avrebbero militato stabilmente
nelle
legioni romane, altri avrebbero partecipato a singole
campagne militari in qualità di federati, altri ancora, riuniti in
bande di mercenari, avrebbero continuato a cambiare alleanza,
finendo col diventare un motivo di grande e perdurante instabilità
politica.
Nel 383 - Il 25 agosto, Graziano, co-imperatore romano (con Valentiniano II) d'Occidente su Gallia, Spagna e Britannia, è assassinato a Lugdunum (Lione) dal magister equitum di Magno Massimo, Andragazio. Magno Massimo, anche noto come
Magno Clemente Massimo e Massimiano (335 - 388), era un generale e usurpatore dell'Impero romano.
 |
Solidus di Magno
Massimo: Classical
Numismatic Group, Inc. QUI, |
La sua figura, rielaborata e romanzata, è entrata a far parte del
ciclo bretone del
Mabinogion in cui viene indicato con il nome
di
Macsen Wledig. Originario della Hispania come l'imperatore
Teodosio I, Massimo aveva combattuto con Teodosio il Vecchio, padre
di Teodosio I, nella campagna in Britannia del 368-369 e si era distinto per le sue qualità militari contro i Pitti. Nella primavera del 383,
Magno Massimo era stato proclamato
imperatore dalle legioni di stanza in
Britannia:
le ragioni dello scontento erano l'ammissione nell'esercito romano di
contingenti di barbari, in particolare
Alani assunti con paghe
elevate. Era sbarcato quindi in Gallia per affrontare in battaglia
l'imperatore Graziano, nei pressi di Parigi. Dopo cinque giorni di
scaramucce, lo scontro era stato deciso dal passaggio della cavalleria
dei
Mauritani (la Mauretania era una provincia romana dal 33
d.C. e i Romani chiamavano con il nome
Mauri tutti i popoli
nativi del Nord Africa) seguita da altre truppe di Graziano, dalla
parte di Massimo. Graziano era fuggito allora verso sud, ma venne raggiunto
presso Lugdunum dal
magister equitum di Massimo Magno,
Andragazio e lì ucciso. A questo punto, Magno
Massimo si ritrova padrone della
Gallia, della
Britannia e
dell'
Hispania, ma non osa muovere guerra al giovane
imperatore
Valentiniano II (371-392), fratellastro di Graziano
e signore dell'
Italia e dell'
Africa, poiché era amato
dalle legioni e protetto dal generale Bautone. Magno Massimo
immaginava, tra l'altro, che quando costui avesse raggiunto la maggiore età,
avrebbe certamente tentato di far valere la legittimità del suo
diritto dinastico a regnare su tutto l'Occidente, probabilmente
appoggiato da Teodosio. In ogni caso Massimo pone la propria
capitale
ad Augusta Treverorum (
Treviri) ed invia un'ambasciata
a Teodosio, imperatore in Oriente, per proporre un
trattato di
amicizia. In quel momento
Teodosio era preoccupato per gli
avvenimenti della frontiera orientale, dove i persiani avevano rotto
il trattato con Costantinopoli e premevano sui confini, pertanto, pur
desideroso di vendicare il cugino Graziano (a cui, tra l'altro, era
debitore del titolo imperiale), ritenne più opportuno non impegnarsi
su altri fronti e
accettò di
riconoscere Massimo
imperatore, confermandogli la sovranità sulla prefettura gallica
e riconoscendolo console per il 384, ma solo in Occidente; acconsentì
inoltre l'erezione di statue di Massimo al fianco di quelle dedicate
a se stesso.
- Da
QUI: Il 25 agosto 383 viene
assassinato il ventiquattrenne
Graziano nel corso di un banchetto organizzato in suo onore a Lugdunum (Lione). Anche in questo caso le fonti storiche sono discordanti: secondo alcuni nel banchetto fu assassinata tutta la famiglia imperiale, cioè anche
Costanza e il
bambino che era nato nel
379. Secondo altri Costanza era già morta e Graziano si era risposato con Leta. Il vescovo Ambrogio non ne fa menzione. Se l'eliminazione dell'intera famiglia risponde a verità, prenderebbe corpo l'ipotesi della
lotta dinastica piuttosto del problema del
controllo militare.
Giustina teme che l'
alleanza
Teodosio-
Massimo sia fatale anche al figlio e rinforza
l'
esercito goto, ma il giovane Valentiniano II è schiacciato
fra la pressione materna, quella del generale
franco Bautone
che vuole governare a suo nome e quella psicologica del vescovo
Ambrogio. Non fa in tempo a sottoscrivere il ripristino dell'ara
della Vittoria in senato, che
Ambrogio gli scrive in maniera
così sottilmente
minacciosa da fargli annullare il decreto. E
così anche quando ordina la restituzione dei fondi ai collegi
sacerdotali, Ambrogio riesce a bloccare l'esecuzione del decreto.
Nel 384 - Magno Massimo,
per inasprire i rapporti con Valentiniano II, di cui sospettava che
raggiunta la maggiore età avrebbe fatto valere il suo diritto a
regnare su tutto l'Occidente, si inserisce nella diatriba tra
ariani e cattolici, appoggiando quest' ultimi mentre
Giustina, madre di Valentiniano II che esercitava di fatto il
potere a causa della minore età del sovrano, perseguiva una politica
favorevole agli ariani,
essendo ariana essa stessa. Per ergersi a campione del
cattolicesimo niceno, nel 384 Magno
Massimo dà udienza, nell'Aula Palatina di Augusta, a
Martino di Tours, il famoso S. Martino dell'11 novembre
(Sabaria, 316 circa - Candes, 8 novembre 397, vescovo originario
della Pannonia che esercitava il suo ministero in Gallia, tra i primi
santi non martiri proclamati dalla Chiesa cattolica), a proposito
della presunta eresia di Priscilliano di Avila
(Galizia, 340 - Treviri, 385) vescovo spagnolo fondatore del
Priscillianesimo, dichiarato eretico dal primo concilio di Saragozza
dopo che si era rifugiato in Hispania dove predicava le sue idee, che
riscuotevano un gran successo fra le donne e le classi popolari, che
avversavano l'unione fra Chiesa e Impero oltre alla corruzione e
all'arricchimento del clero. Martino di Tours prese le difese del
Priscillianesimo, forse mal sopportando un processo dell'autorità civile su un tema ecclesiale.
- Nello stesso 384, Teodosio I invia il generale romano di padre vandalo Stilicone presso lo Scià persiano sasanide Sapore III per negoziare la pace e la spartizione dell'Armenia. La missione ebbe successo e, tornato a Costantinopoli, Stilicone fu promosso al rango di comes sacri stabuli e si sposò con Serena, figlia di Onorio, un fratello defunto di Teodosio, quindi anche lei di origine ispanica, descritta da Claudiano come bionda, bellissima, ma anche ambiziosa, autoritaria e senza scrupoli. Alla morte dei genitori era stata
adottata come figlia da Teodosio, che l'adorava: era l'unica capace di arrestare le sue collere esplosive, di allietare le sue depressioni, di lenire le sue febbri. La giovane donna era cresciuta consapevole del suo fascino e del suo potere, che esercitò a Costantinopoli dando parecchio filo da torcere alla pia Flaccilla, la prima moglie di Teodosio e poi forse anche a Galla, la seconda moglie. Elia Flavia Flaccilla ( ... -
Costantinopoli, 386) prima moglie dell'imperatore Teodosio I gli
aveva dato una figlia, Pulcheria, morta infante, Arcadio (Hispania,
377 circa) e Onorio (9 settembre 384). Dall'unione di Serena e Stilicone nasceranno invece Eucherio e due femmine, Maria e Termanzia che andranno in spose, in momenti successivi, all'imperatore d'occidente figlio di Teodosio Onorio, nonostante le sue tendenze fossero risaputamente omosessuali. Flavio Stilicone (359 circa - Ravenna, 22 agosto 408) fu il magister militum romano, d'origine vandala da parte di padre, che di fatto governò la parte occidentale dell'impero romano dalla morte di Teodosio I fino alla sua esecuzione. Stilicone era nato nell'odierna Germania da padre vandalo, ausiliario romano ufficiale di cavalleria sotto l'Imperatore Valente, e da madre cittadina romana. Tuttavia si considerò sempre un romano, sebbene, come molti germani, fosse di confessione religiosa ariana, considerata eretica dal resto del Cristianesimo. Parlava correttamente le tre lingue principali dell'epoca: il germanico d'uso corrente (una sorta di lingua franca per le tribù nomadi barbare), il latino e il greco (idioma prevalente nell'Impero Romano d'Oriente). Aveva seguito a Costantinopoli la carriera dei militari palatini: tribunus, comes stabuli sacri, comes domesticorum ed infine generale in capo di tutto l'esercito.
- Da QUI: Alla fine del 384 Giustina fa arrivare a Milano Mercurino, vescovo ariano di Durostorum (Silistra, sul Danubio in Romania), deposto da Teodosio, di probabile origine gota, discepolo di Ulfila. Giustina tenta di organizzare una chiesa ariana da contrapporre a quella cattolica, ed è guerra aperta tra lei e il vescovo.
Nel 385 - Per ingraziarsi
l'appoggio dei cattolici, Magno Massimo ordina la
decapitazione di Priscilliano, dietro istigazione dei
vescovi spagnoli (si tratterà del primo cristiano ucciso per
eresia). Il fragile equilibrio tra Massimo e Teodosio fu
mantenuto dal vescovo di Milano Ambrogio, la cui fortissima
personalità e il riconosciuto carisma gli consentirono, nonostante
le divergenze religiose, di affiancare l'imperatrice Giustina
come tutore del giovane imperatore Valentiniano II. Ancora nel
385/386 le relazioni tra Massimo e Teodosio si svolgevano su un
tenore conciliante, forse perché Teodosio, che non aveva ancora
risolto il problema con l'impero persiano ed era preoccupato dai
voltafaccia di Gildone, figlio di Nubel, capo di un clan di Mauri e
ufficiale romano in Africa, il granaio di Roma dalla divisione
dell'impero, ruolo che prima era stato svolto dall'Egitto, che ora riforniva solo la capitale d'Oriente, Costantinopoli. Nel 386 comunque, il prefetto del pretorio di Gallia di
Massimo, Euodio, esercitava il consolato assieme al figlio di
Teodosio, Onorio ed era riconosciuto anche nei territori dell'Impero
d'Oriente.
Nel 386 - Da QUI: Il 23 gennaio 386 Valentiniano II emana da Milano una costituzione rivolta al prefetto pretorio Eusiginio che condanna l'integralismo di Ambrogio e in cui si concede diritto di culto pubblico agli ariani, pena di morte a chi si opponeva (Cod. Theod. XVI 1.4). Ambrogio viene invitato a lasciare Milano e a trovarsi una sede di sua scelta. La replica di Ambrogio è nel sermone che pronunciò nel marzo contro il suo rivale ariano Mercurino Aussenzio: "Imperator enim intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam est (Perché l'imperatore è all'interno della Chiesa, non al di sopra della Chiesa)" (Ep. XXI), frase che valse ad Ambrogio la scelta a patrono della città. La reazione di Giustina, per mano del figlio, non tarda a farsi sentire: Ambrogio deve presentarsi con giudici di sua scelta davanti al consistoro per sostenere un contraddittorio con Mercurino Aussenzio. Ambrogio rifiuta e invita provocatoriamente il giovane imperatore a trasferirlo pure d'ufficio se non teme la guerra civile. L'esistenza del vescovo si fa durissima ed è seguito a vista dalla polizia imperiale. Per la Pasqua la corte chiede la basilica ecclesìa nova, ma i fedeli cattolici occupano già dalle Palme le tre basiliche, nova, vetus e Porziana. Per tenere svegli ed emotivamente eccitati i fedeli, Ambrogio introduce a Milano i canti antifonati, che rimarranno nella tradizione liturgica ambrosiana. L'occupazione, cominciata venerdì 27 marzo, si protrae fino a giovedì 2 aprile, poi Giustina demorde e decide di andare a festeggiare la Pasqua nella più tollerante Aquileia. A giugno è la volta di Ambrogio a sferrare un colpo basso: in maggio aveva consacrato la basilica degli Apostoli; il mese dopo, dovendo consacrare anche la basilica che da lui prese il nome e avendo predisposto la sua sepoltura sotto l'altare maggiore, la reazione ariana e imperiale è immediata: forse che il vescovo aveva avuto la presunzione di costruirsi un mausoleo per sé? Allora Ambrogio il 17 giugno 386 dice di aver rinvenuto presso la basilica dei SS. Nabore e Felice i corpi di due decapitati anonimi, che chiameranno Gervasio e Protasio, e li farà seppellire presso di sé: "Poiché non ho meritato personalmente di essere martire, ho almeno ottenuto questi martiri per voi" (Ep. XXII, 12). La provocazione nei confronti degli ariani era chiara, poiché l'arianesimo negava il culto dei martiri o dei santi o più in generale delle reliquie. In occasione delle "invenzioni" si alzavano le grida degli invasati dai demoni, che in questo modo attestavano l'autenticità dei corpi dei martiri. Dopo la "confessione" demoniaca, gli invasati erano liberati dagli spiriti immondi. Gli ariani si facevano beffe di tutto questo trambusto: "Nella corte una moltitudine di Ariani, che attorniavano Giustina, derideva la grazia divina che il signore Gesù mediante le reliquie dei suoi martiri s'era degnato di conferire alla Chiesa cattolica, e andava raccontando che Ambrogio s'era procacciato con denaro alcuni uomini che fingessero d'essere vessati da spiriti immondi e tormentati da Ambrogio stesso e dai martiri. E così parlavano gli Ariani con linguaggio di giudei, certo loro consimili" (Paolino, 15, 1-2). Il modello dell'invenzione è quello usato dall'imperatrice Elena, madre di Costantino, nel ritrovare sul Golgota la S. Croce, avvenimento celebrato da Ambrogio nell'orazione funebre per Teodosio. Nel novembre del 386 Giustina
è esasperata dagli intrighi di Ambrogio e quindi si trasferisce
temporaneamente ad Aquileia e intanto studia le modalità per
il passaggio definitivo della capitale da Milano a
Roma. Il vuoto lasciato dalla corte imperiale a Milano provoca
la fatale discesa di Massimo, stanco anche lui della scomoda sede di
Treviri.
Nel 387 - Magno Massimo,
infastidito sia dall'opera conciliante di Ambrogio che per il
continuo rafforzamento delle guarnigioni a difesa dei valichi
alpini contro di lui, coglie l'occasione dell'infiltrazione di
barbari in Pannonia per cui convince Donnino, ambasciatore di
Valentiniano II, ad inviare di un contingente di rinforzi per
fronteggiare l'invasione. Dopo aver scritto al nuovo vescovo romano
Siricio (dal 384 Papa della Chiesa, che lo venera come santo), per
una sorta di benestare all'intervento contro la corte di Milano
che si professava apertamente ariana, nell'estate del 387
varca le Alpi (i cui valichi erano stati liberati per far passare i
rinforzi verso la Pannonia) con un esercito ben più numeroso di
quanto ufficialmente pattuito e si presenta sotto le mura di Milano.
Valentiniano II, la sorella Galla e la madre, che solo all'ultimo
momento si rendono conto di quanto sta accadendo, fuggono prima ad
Aquileia e poi a Tessalonica, presso Teodosio, che da pochi mesi
aveva concluso la pace con l'impero persiano ed era dunque libero di
occuparsi finalmente dell'usurpatore Magno Massimo, che per
giustificare il suo gesto, dichiarava di aver agito solo in nome
della difesa della fede cattolica. Di lì a poco, muore Giustina e
Valentiniano si converte al cattolicesimo mentre
Teodosio, rimasto da qualche tempo vedovo, ne sposa la sorella Galla.
Nel giro di pochi mesi da tutto l'impero vennero reclutate truppe per
l'esercito teodosiano, una parte del quale, al comando di Arbogaste,
mosse direttamente verso la Gallia per affrontare Vittore, il figlio
di Magno Massimo lasciato a presidio del territorio, mentre il grosso
delle truppe, agli ordini dello stesso Teodosio, puntava verso Siscia
(l'odierna Sisak) in Pannonia, quartier generale di Massimo.
Valentiniano, nel frattempo, puntava verso Roma via mare. Messo alle
strette, Magno Massimo tentò la strada del complotto, ma i suoi
emissari, che avrebbero dovuto fomentare la ribellione tra le truppe
barbare di Teodosio ed uccidere lo stesso imperatore, furono scoperti
ed uccisi. La marcia senza ostacoli dell'esercito teodosiano colse di
sorpresa la guarnigione di Siscia, che fu travolta (battaglia della
Sava); nella successiva battaglia di Poetovio le truppe di Massimo
furono sbaragliate. Con le poche truppe rimastegli fedeli, a causa
delle continue defezioni a favore dell'esercito teodosiano, Massimo
si rifugiò ad Aquileia. Mentre i rinforzi dalla Gallia non
arrivavano poiché impegnati dalle truppe di Arbogaste, in Italia
l'usurpatore gallico non godeva di molti consensi e d'altra parte le
truppe barbare erano per loro natura propense a stare dalla parte del
vincitore, che poteva assicurare un cospicuo bottino. Teodosio arrivò
prima che Massimo potesse concepire un piano di difesa, e dopo pochi
giorni di assedio la guarnigione e la cittadinanza si ribellarono a
Massimo, che fu
catturato e portato a Teodosio, che lo abbandonò alla furia
omicida dei soldati. In Gallia suo figlio Vittore fu sconfitto e
ucciso forse dallo stesso Arbogaste, mentre la flotta teodosiana
distruggeva quella di Massimo, al cui comando era Andragazio,
l'esecutore materiale dell'assassinio di Graziano, che si suicidò
gettandosi in mare. Valentiniano II si ritrovava quindi imperatore
di tutto l'occidente, almeno nominalmente, in quanto era in
realtà sotto la tutela del magister equitum d'origine franca Arbogaste, con cui aveva rapporti piuttosto tesi.
- Da
QUI: Il vuoto lasciato dalla corte imperiale
a Milano provoca la fatale
discesa di
Massimo, stanco anche lui della
scomoda sede di Treviri. Giustina coi figli fugge a Salonicco
nell'estate del 387 e richiede l'
intervento armato di
Teodosio. Il
prezzo preteso da Teodosio è alto: prima di tutto Giustina e i
regali rampolli devono abbracciare il
cattolicesimo poi, quale
garanzia, gli deve essere concessa
Galla, appena pubere.
Giustina sarebbe passata attraverso le fiamme del fuoco eterno pur di conservare l'impero al figlio Valentiniano e accetta senza troppe riflessioni tutte le condizioni. Ricevuta una flotta per tornare in Italia, s'imbarca sulla nave col figlio pronta a dar battaglia, ma non rivedrà più le coste italiane perché una provvidenziale
morte le impedirà di assistere anche alla rovina dell'amato Valentiniano II. Le accuse contro Giustina continueranno
anche dopo la sua morte. Paolino (biografo di Ambrogio) ci informa
infatti che un tale Innocenzo, sottoposto a tortura dal giudice in un
processo di stregoneria, confessò che i maggiori tormenti gli
venivano inflitti dall'angelo custode di Ambrogio, perché ai tempi
di Giustina era salito di notte sul tetto della chiesa per aizzare
gli odi della gente contro il vescovo e ivi aveva compiuto sacrifici. Aveva anche mandato demoni a ucciderlo, ma non erano neppure riusciti ad avvicinarsi a lui, perché una barriera di fuoco difendeva la casa; un altro era arrivato armato fino alla camera, ma il braccio si era paralizzato finché non aveva confessato che il mandante era stata Giustina (Vita Ambr. § 20). Durante l'esilio di Giustina e Valentiniano II a Salonicco, nell'autunno del
387,
Galla viene data precipitosamente in
moglie a
Teodosio, vedovo da due anni e quarantenne, che ha già due figli, Arcadio e Onorio. Galla ha circa
tredici anni. Il matrimonio serve a sancire la
legittimità della presenza di
Teodosio sul
trono d'Oriente, mentre per l'Occidente si tenta di recuperare il trono a Valentiniano II. La manovra fu così plateale che bisognò subito ammantarla di romanticismo. Zosimo, storico bizantino vissuto alla metà del V sec., racconta che
Teodosio stava esponendo al consistoro la possibilità di un accordo col suo antico
amico Magno Massimo, quando entrò Giustina con Galla, che suscitò a Teodosio
un “colpo di fulmine”. Giustina acconsentì a concedere la figlia in matrimonio solo a condizione che Teodosio vendicasse la morte di Graziano, dichiarando guerra a Massimo. Alcuni vollero vedere in Galla doti che difficilmente oggidì potremmo attribuire a una tredicenne: Galla, grazie alla sua avvenenza e al grande fascino personale, avrebbe esercitato un grande ascendente sul marito
Teodosio, che solo
per lei avrebbe combattuto contro il
suo amico Massimo. Come età Galla è molto più vicina ai figli di Teodosio che non al marito: ha solo tre anni più di Arcadio e la loro convivenza nel palazzo di Costantinopoli si dimostra subito problematica. Verso la fine del
390, anzi, i rapporti tra i due si erano fatti talmente gravi da rendere necessario il richiamo di Teodosio da Milano per placare gli animi.
Galla potrebbe essere stata convinta della
superiorità dinastica che vantava rispetto ad
Arcadio e
Onorio, sebbene lei stessa non fosse che la figlia di un ex generale pannonico e di una infaticabile arrampicatrice sociale (ma di dinastia costantiniana). La soluzione fu che lei si
trasferisse con la piccola
Placidia in un palazzo che da lei prese il nome, la
domus Placidiana (Marcellinus Comes, Chronicon).
- Nel 387 Teodosio I sposa la sua seconda moglie Galla, quando i due avevano rispettivamente quaranta e sedici anni circa. Teodosio aveva già avuto tre figli dal precedente matrimonio con Flaccilla (Pulcheria Teodosia morta infante, Arcadio e Onorio) e da Galla avrà inizialmente un figlio, di nome Graziano, morto infante. Galla (374 - 394) era una dei quattro figli dell'imperatore romano Valentiniano I e della sua seconda moglie Giustina, ed era quindi sorellastra dell'imperatore Graziano, figlio di Valentiniano I e della sua prima moglie Marina Severa, associato al trono dal padre già nel 367 e sorella di Grata, Giusta e di Valentiniano II, proclamato augusto alla morte del padre nel 375, a soli quattro anni e sotto la reggenza della madre Giustina. Galla crebbe nella famiglia imperiale presso la capitale di Milano. Dopo la morte di Graziano nel 383 e in seguito all'attacco dell'usurpatore delle province galliche Magno Massimo, fuggì nel 387 con la madre e i fratelli a Tessalonica, presso l'imperatore Teodosio I, associato al trono da Graziano nel 379. Qui Giustina fece comparire la bellissima Galla in lacrime davanti al quarantenne imperatore, il quale la chiese in sposa: Giustina pose la condizione che Teodosio intervenisse in Italia per ricollocare Valentiniano sul trono e questi accettò. Il matrimonio fu celebrato quello stesso anno e Teodosio si recò in Occidente a combattere Massimo. Divenuta imperatrice, Galla si era trovata ad essere, a tredici anni, la madre adottiva dei figli del primo matrimonio di Teodosio, Arcadio (che aveva dieci anni) e Onorio. Nel 388 diede alla luce il primo figlio, Graziano, morto però ancora infante. Tra il 388 e il 391 Teodosio rimase in Italia, dove rimise sul trono Valentiniano; nel frattempo Galla e Arcadio, che vivevano a Costantinopoli nel Gran Palazzo, entrarono in contrasto, tanto che nel 390 Galla fu allontanata dal palazzo ma a quanto pare non definitivamente, poiché quando nel 392 nacque Galla Placidia e morì Valentiniano II, fratello di Galla, secondo la testimonianza dello storico Zosimo, lei "riempì la reggia con le sue grida". Morì nel 394 per le conseguenze di un altro parto a cui non sopravvisse neppure il bambino, Giovanni. Come la madre Giustina, Galla era probabilmente ariana.
Nel 388 - In ottobre, l'imperatore d'oriente Teodosio I assegna la sede di Milano al piccolo
figlio Onorio (augusto d'occidente) che, avendo solo cinque anni, resta a Costantinopoli mentre a Milano va la nipote Serena,
che avrà considerato il cambio di sede un male indispensabile
per tenere sotto controllo Grata e Giusta, sorelle di
Valentiniano II, facili prede di qualunque arrampicatore privo di
scrupoli. Anche Teodosio si stabilisce a Milano, dove aveva fissato la propria residenza Valentiniano II, la capitale dell'impero d'occidente, dimorandovi, salvo brevi interruzioni, per oltre due anni, fino
all'aprile del 391. Intensa fu in questo periodo l'attività
legislativa dell'imperatore ispanico, tesa a combattere gli abusi:
gratificazioni non dovute che i funzionari esigevano, produzione di
monete false, violenze compiute da schiavi talvolta istigati dai loro
stessi padroni, vendita di bambini da parte di genitori ridotti in
miseria, campi saccheggiati di notte dai militari che oltretutto si
dedicavano a tendere anche imboscate sulle strade. Fece anche una
legge che dichiarava nulli i codicilli e le clausole mediante
i quali venivano attribuiti lasciti all'imperatore o a membri
della sua famiglia, che fu particolarmente lodata da Quinto Aurelio
Simmaco. Milano era anche la sede episcopale di Ambrogio, sicché il vescovo poteva mantenere contatti regolari col supremo potere secolare. In occasione degli scontri che ebbero inevitabilmente a verificarsi, Ambrogio difese con tanta fermezza lo «ius (il diritto) sacerdotale» che possiamo riconoscere in lui il primo campione della Chiesa che sia riuscito a tracciare, in sede teorica e pratica, una netta linea di demarcazione tra le giurisdizioni secolare e spirituale. Gli ariani avevano fatto molti proseliti a Milano fino al regno di Teodosio I che, con l'editto del 380, aveva inflitto loro un colpo mortale in tutto il mondo romano. Durante il periodo di maggiore influenza ariana, il governo imperiale, cedendo alle pressioni degli scismatici, aveva ordinato ad Ambrogio di ceder loro la sua basilica episcopale. Egli rifiutò motivando il rifiuto con la teoria che «i palazzi, e non le chiese, son sotto la giurisdizione dell'autorità secolare», e che «le cose divine sono al di sopra del potere imperiale». Ambrogio ebbe così partita vinta e si tenne la basilica.
- Da
QUI: Le gravidanze di
Galla si susseguono, ma con esito infelice. Il primo figlio nasce nell'estate 388 e si chiama
Graziano, poco opportunamente potremmo dire, visto che era stato Teodosio a
relegare l'omonimo fratellastro di Galla a
Treviri e a provocarne la morte. Il piccolo seguì presto la sorte dello zio. Era una ben strana sorte quella di
Galla: lei, la
legittima erede (poiché figlia di
Giustina, costantiniana discendente da Crispo o Costanzo) dell'impero
esiliata dal
palazzo per i suoi attriti con il figliastro Onorio, dove stava
invece Serena, di cui lo zio era lo stesso Teodosio e il marito Stilicone. Come
un tempo l'infelice Elena, moglie dell'imperatore Giuliano, Galla era condannata a veder morire i suoi figli maschi.
- Nel 388/392 nasce Elia Galla Placidia (Costantinopoli, 388/392 - Roma, 27 novembre 450), imperatrice romana figlia dell'imperatore Teodosio I (che regnò dal 378 al 395) e della sua seconda moglie Galla, figlia di Giustina, che era verosimilmente appartenente alla dinastia costantiniana, probabilmente tramite sua madre, che
potrebbe essere stata o figlia di Crispo, il
primogenito di Costantino I (anche se identità e destino del figlio
di Crispo ed Elena non sono noti; è stato proposto comunque che
fosse una femmina e che fosse la madre dell'imperatrice Giustina da
Harlow e altri) o di Giulio Costanzo (fratellastro di Costantino). In Galla Placidia si riunivano quindi tre dinastie imperiali romane, la costantiniana, la valentiniana e la teodosiana. Suo nonno materno era l'imperatore Valentiniano I, suoi zii materni gli imperatori Graziano e Valentiniano II; entrambi i suoi due fratellastri (Arcadio e Onorio) sarebbero stati imperatori e dei due mariti che ebbe, uno era Ataulfo, re dei Visigoti e l'altro Costanzo III, imperatore romano d'Occidente assieme ad Onorio. Furono in seguito imperatori il figlio di Galla Placidia, Valentiniano III e suo nipote Teodosio II, figlio di Arcadio. All'inizio degli anni 390 Galla Placidia ricevette il titolo di nobilissima, che le dava una dignità pari a quella dei fratelli e delle proprietà che l'avrebbero resa finanziariamente indipendente. Claudiano, panegirista di Stilicone, descrive la bambina vestita
d'oro e incoronata a fianco dei fratellastri in occasione della
cerimonia d'incoronazione ad augusto del piccolo Onorio
il 10 gennaio 393 a Costantinopoli: dovevano sembrare poco più
di sontuose mascherine di carnevale, lui a nove anni con la corona
raggiata in testa e i simboli del comando, lei una pupattola di
quattro anni rifulgente d'oro. Sul cocchio che dal circo li
ricondusse al palazzo mancava mamma Galla, forse impedita dalla
gravidanza che doveva concludersi con la prematura morte di Giovanni.
Nel 389 - Dopo Maria nata nel 385, da Stilicone e Serena nasce Eucherio: l'evento fu considerato di buon
auspicio ed essendo Serena sua figlia adottiva, Teodosio assaporò la
gioia di essere nonno.
Nel 390 -
In giugno, la popolazione di Tessalonica (l'odierna Salonicco)
si ribella e impicca il magister militum
dell'Illirico e governatore della città, Buterico, reo di aver
arrestato un famoso auriga e di non aver permesso i giochi annuali.
Teodosio ordina una rappresaglia; viene organizzata una gara di
bighe nel grande circo della città a pochi giorni dai fatti e chiusi gli accessi, vengono trucidate circa 7.000 persone. Un misfatto analogo di proporzioni anche maggiori sarà perpetrato non molto tempo dopo da Giustiniano, a Costantinopoli. Quando giunse la notizia in Occidente, l'opinione pubblica ne fu profondamente commossa. Ambrogio, vescovo di Milano ne valutò tutta la gravità e mosso dal principio che «anche l'imperatore è nella Chiesa, non al disopra della Chiesa» e scrisse a Teodosio una lettera sdegnata, imponendogli di espiare l'ingiusto massacro con mesi di penitenza e una richiesta pubblica di perdono. Grande fu la meraviglia dell'imperatore all'inaudita pretesa del prelato, ma infine, minacciato di scomunica, si arrese e deposte le insegne imperiali, si sottopose pubblicamente al rito espiatorio nella basilica milanese. Nel Natale del 390, l'imperatore poté tornare a comunicarsi. Tutto ciò accadeva nel IV secolo, solo pochi decenni da quando la Chiesa era uscita, dalle catacombe, alla luce della legalità. Fu un'altra vittoria, ancor più clamorosa, di Ambrogio; secondo molti storici l'inasprimento della politica religiosa di Teodosio nei confronti del paganesimo fu in gran parte dovuta all'influenza che Ambrogio ebbe su di lui e sicuramente, dopo questi fatti, la politica religiosa dell'imperatore si irrigidì notevolmente.
- Dalla strage di Tessalonica, Teodosio vieterà i Giochi Olimpici, ponendo fine a una storia durata più di 1000 anni. Interpretando i Giochi olimpici come una festa pagana, Teodosio ne decise la chiusura, influenzato da Ambrogio. A determinare tale decisione contribuì anche l'ormai intollerabile livello di corruzione tra gli atleti, che falsava le competizioni. Inoltre gli imperatori cristiani Valentiniano
II, Teodosio I e Arcadio dichiarano il sesso omosessuale illegale
e coloro che ne erano accusati dovevano essere condannati alla morte
sul rogo, ossia bruciati vivi in pubblico.
 |
Abside con croce nella basilica
paleocristiana di Santa
Pudenziana a Roma. |
- La
croce,
diventata il simbolo del culto cristiano dopo l'editto di Milano, emanato dagli imperatori Costantino e Licinio nel 313,
si inizia a trovare nelle chiese primitive: uno degli esempi più significativi è la croce gemmata realizzata a mosaico (fine del IV - inizio del V secolo), posta sopra il Calvario, nell'abside della basilica paleocristiana di Santa Pudenziana in Roma. Nel mosaico, risalente a circa il 390, è rappresentato Cristo in trono circondato dagli apostoli e da due donne che gli porgono una corona ciascuna, secondo alcuni le sante Pudenziana e Prassede. Al centro del mosaico appare una
croce ricoperta di gemme che, secondo la tradizione, sarebbe stata fatta erigere dall'imperatore Teodosio II nel 416 sul Calvario e accanto svettano i quattro Viventi dell'Apocalisse (l'angelo, il bue, il leone e l'aquila). Altre rappresentazioni di croci sono nei mosaici che ornano l'arco trionfale di Santa Maria Maggiore a Roma ed in quelli del Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna.
- Nel 390, un giovane principe dei goti Tervingi (da lì in poi chiamati Visigoti) della
dinastia dei Balti, il ventenne Alarico, guida i Visigoti, gli Unni
ed altre tribù provenienti dalla sponda sinistra del Danubio, nell'invasione della Tracia, saccheggiandola.
Nel 391 - L'imperatore Teodosio I interviene personalmente contro Alarico ma cade in un'imboscata sul fiume Maritsa (fiume dell'Europa sudorientale che
scorre in Bulgaria, Grecia e Turchia europea), dove rischia la vita.
 |
L'anziana vestale Emilia, custode
del fuoco sacro nel tempio di Vesta,
|
-
Tra il 391 e il 392 sono emanati una serie di decreti (noti come
decreti teodosiani) che attuano in pieno l'editto di
Tessalonica: viene interdetto l'accesso ai templi pagani e
ribadita la proibizione di qualsiasi forma di culto che non sia il cristianesimo di fede nicea, compresa l'adorazione delle
statue. Furono inoltre inasprite le pene amministrative per i
cristiani che si fossero riconvertiti al paganesimo e, nel decreto
emanato nel 392 da Costantinopoli, l'immolazione di vittime nei
sacrifici e la consultazione delle viscere erano equiparati al
delitto di (lesa) maestà, punibile con la condanna a morte. I
templi pagani furono oggetto di sistematica distruzione violenta
da parte di fanatici cristiani e monaci appoggiati dai vescovi locali
(in molti casi con l'appoggio dell'esercito e delle locali autorità
imperiali) che si ritennero autorizzati dalle nuove leggi: si veda,
per esempio, la distruzione del tempio di Giove ad Apamea, a cui
collaborò il prefetto del pretorio per l'oriente, Materno Cinegio.
L'inasprimento della legislazione con i "decreti teodosiani"
provocò delle resistenze presso i pagani. Ad Alessandria d'Egitto
il vescovo Teofilo ottenne il permesso imperiale di trasformare in
chiesa un tempio di Dioniso, provocando una ribellione dei pagani,
che si asserragliarono nel Serapeo (che conteneva quello che rimaneva della famosa
biblioteca) e compiendo violenze contro i cristiani. Quando la
rivolta fu domata, per rappresaglia il tempio di Dioniso fu distrutto. Teodosio infatti, lo stesso che aveva proclamato il cristianesimo religione ufficiale dell’Impero, pensava che dovesse essere la Provvidenza a sottomettere il cuore degli uomini, trasformando “ogni ferocia in dolcezza”, come riferiva il filosofo ed alto funzionario dello Stato Temistio. Da allora, nell'Impero Romano non ci sarebbe più stata libertà di pensiero e di culto al di fuori dell'ortodossia cristiana.
- In seguito alla riforma teodosiana, il termine Eparchia è stato utilizzato nell'Impero romano d'Oriente per indicare una circoscrizione amministrativa equivalente alla provincia latina. Tali entità scomparvero poi nel VII secolo con l'istituzione dei temi (thémata in greco).
Per eventuali approfondimenti vedi "Storia dell'Europa n.37: dal 374 al 391 e.v. (d.C.)"
QUI.
Nel 392 -
Il 15 maggio, il ventunenne imperatore d'occidente Valentiniano II viene trovato
impiccato ad un albero. Arbogaste, suo tutore e magister equitum d'origine franca, spedisce il corpo di Valentiniano a
Milano e Teodosio scriverà ad Ambrogio, vescovo di Milano, di
organizzarne il funerale. Ambrogio compose per l'occasione l'orazione
De obitu Valentiniani consolatio. Il cadavere di Valentiniano fu
pianto dalle sorelle Giusta e Grata e fu disposto in un sarcofago di
porfido vicino a quello del fratello Graziano, molto probabilmente
nella cappella di Sant'Aquilino della basilica di San Lorenzo.
Teodosio I rimaneva così signore di tutto l'impero ma il 22 agosto, il comandante romano di origine franca Flavio Arbogaste, magister militum (capo dell'esercito) d'occidente che da più parti era ritenuto coinvolto nella morte di Valentiniano II, appoggiato sia dalle
potenti tribù dei Franchi che dal Senato di Roma, che cercava di opporsi al crescente potere della Chiesa cattolica, fa eleggere imperatore
d'occidente, a Lione, Flavio Eugenio (345 circa - 6 settembre 394),
che non essendo però stato riconosciuto dall'imperatore collega
d'oriente Teodosio I, viene generalmente considerato un usurpatore
del trono imperiale.
- Da QUI: L'ultima immagine che abbiamo di Galla
la dipinge Zosimo al momento in cui le fu comunicata la morte
del fratello Valentiniano II nel 392: "Galla
riempì la reggia delle sue grida". Nella sua laconicità la
nota di Zosimo è piena di pathos, vi si avverte la disperazione, la
rabbia, il rancore verso il marito che aveva causato - direttamente o
indirettamente - per la seconda volta la morte di un suo fratello.
Sappiamo solo che Galla morirà nella primavera 394
in occasione di un altro parto. Ma neppure il pio vescovo Ambrogio
trovò una parola di conforto per lei, che non compare fra le anime
del paradiso, né per il neonato. Forse, come un'eroina di una
tragedia greca, Galla aveva preferito togliere la vita al bambino che
aveva in grembo, sacrificando anche se stessa, pur di privare il
marito della discendenza e punirlo per la morte di Valentiniano.
Forse era uscita di senno, che per la mentalità dell'epoca
equivaleva ad essere posseduta dal demonio. Il silenzio con cui
l'hanno avvolta gli storici lascia penetrare solo l'eco delle sue
urla dai recessi della reggia. Alla morte di Valentiniano II
il 15 maggio 392, anche le sorelle rimaste a vivere nel
palazzo di Milano appaiono straziate dal dolore. Il giovane
imperatore era stato trovato impiccato, ma si sospettò
immediatamente che l'apparente suicidio servisse a mascherare
l'assassinio per strangolamento (Paolo, Historia). Una morte in
battaglia sarebbe stata più comprensibile, ma due fratelli
assassinati lasciavano le sorelle attonite, soprattutto se il
mandante prendeva nei loro incubi le sembianze del cognato
Teodosio. Lui aveva assegnato entrambi i fratelli alla
pericolosa sede delle Gallie, lui forse aveva soffiato sulle
illusioni di potere di avidi barbari e funzionari corrotti. La
scomparsa di una personalità dominante come quella di Giustina aveva
lasciato i figli privi di guida. Giusta e Grata si
erano unite saldamente al fratello, sperando di formare una
coalizione invincibile. Nell'orazione funebre che Ambrogio pronuncia
per il funerale del giovane imperatore si accenna a questo vincolo
affettivo fortissimo: "Quale affetto Valentiniano ha nutrito per
le sorelle. In loro trovava riparo, in loro consolazione, in loro
rilassava l'animo suo e ristorava il suo cuore oppresso dalle
preoccupazioni. Baciava alle sorelle mani e capo, dimentico della sua
dignità imperiale e tanto più sovrastava gli altri in virtù del
suo potere, tanto più si mostrava umile con le sorelle. Nel
beneficio della vostra presenza poneva ogni suo conforto, così che
non sentiva troppo la mancanza di una sposa. Perciò differiva le
nozze, poiché lo saziava il tenero affetto della vostra
gentilezza.". Valentiniano II si sposò, ma non
compare mai citata la moglie. Le sorelle, a due
mesi dalla morte, erano così inconsolabili da meritare un affettuoso
ma risoluto rimprovero da Ambrogio: "Voi desiderate abbracciare
il suo corpo, vi stringete con le vostre persone al suo tumulo. Quel
tumulo sia per voi la dimora di vostro fratello, sia esso il palazzo
imperiale dove riposano quelle membra a voi care. Non avete motivo di
affliggervi oltre misura per vostro fratello: era nato uomo, era
soggetto alla fragilità umana. Ma ammettiamo pure che fosse doveroso
manifestare con gemiti il proprio dolore. Fino a quando si dovrebbe
prolungare il tempo del lutto? Per due mesi interi vi siete strette
ogni giorno intorno alla spoglia di vostro fratello..." ora
basta, impone Ambrogio. E così, con l'immagine del lutto e del
dolore, anche Grata e Giusta svaniscono dalla storia non lasciando
altra traccia che le loro lacrime.
- Nel 392 i Tervingi (Visigoti) di Alarico sono circondati sulla Maritsa in Tracia dal generale Stilicone, in veste di magister militum (capo dell'esercito) d'oriente ma Teodosio li perdona e li lascia tornare nella loro provincia rinnovandogli il trattato del 382.
Nel 393 - L'imperatore d'occidente, poi considerato usurpatore Flavio Eugenio giunge a Roma dove mette in atto, pur essendo cristiano, una politica di tolleranza verso i "pagani" della religione romana, che sotto la guida di Virio Nicomaco Flaviano, riprendono il potere. Flavio Eugenio permise la riapertura dei templi pagani come il tempio di Venere e Roma, la restaurazione dell'altare della Vittoria nella curia romana e la celebrazione di feste religiose della religione romana. Questa politica religiosa, palesemente in contraddizione con i decreti anti-pagani del 391-392, creava tensioni con Teodosio I (che non lo aveva riconosciuto come suo collega e che era un fervente cristiano) e con il potente vescovo milanese Ambrogio, che lasciò la sua sede all'arrivo della corte imperiale di Eugenio.
Nel 394 - Il 5 settembre, l'esercito dell'imperatore d'occidente considerato usurpatore Flavio Eugenio, comandato dal franco Arbogaste, viene sconfitto dall'esercito di Teodosio I nella battaglia del Frigido (l'attuale fiume Vipacco vicino a Gorizia) e l'impero ha in Teodosio I, nuovamente, un unico padrone. Arbogaste si uccise per sfuggire alla
cattura mentre Flavio Eugenio fu messo a morte per decapitazione
come traditore. Il vandalo-romano Stilicone, all'epoca magister militum d'oriente, aveva messo insieme l'esercito che sotto la guida di Teodosio aveva vinto la Battaglia del Frigido e aveva inoltre alle proprie dipendenze il visigoto Alarico, che guidava un consistente numero di foederati goti e che costituivano l'avanguardia dell'esercito, che subirono gravissime perdite. Stilicone si distinse talmente al Frigido che Teodosio vide in lui l'uomo a cui poter affidare la difesa dell'Impero.
- Nel 394 Galla, seconda moglie di Teodosio e madre di Galla Placidia, muore neanche ventenne, a seguito di un parto in cui morì anche il bambino, Giovanni e nello stesso anno Teodosio si reca in Occidente a combattere l'usurpatore Eugenio Flavio. Teodosio lascia a Costantinopoli il piccolo Arcadio (augusto dell'impero d'oriente) mentre si fa seguire a Milano da Onorio (augusto dell'impero d'occidente) e Galla Placidia, entrambi poi lì affidati alle cure dell'ambiziosa Serena, la nipote prediletta di Teodosio. Quando alla fine dell'anno l'imperatore si
ammala gravemente a Roma, sentendo approssimarsi la fine manda a
chiamare Serena col piccolo Onorio. La nipote Serena viene
investita in questa occasione di un ruolo non contemplato
giuridicamente ma affidatole di fatto: è la tutrice di
Onorio, come un tempo Giustina lo era stata di Valentiniano
II. Ma mentre Giustina era l'imperatrice-madre, Serena è solo una
cugina destinata a reggere col marito semibarbaro (Stilicone) la parte
occidentale dell'impero in vece di Onorio.
Nel 395 - Il 17 gennaio Teodosio I, l'ultimo imperatore a reggere entrambe le parti dell'impero, muore. Nell'inverno del 394 si era ammalato di idropisia e dopo poche settimane era morto a Milano, affidando l'educazione spirituale di Onorio e Galla Placidia ad Ambrogio mentre la nipote Serena è la tutrice di Onorio e Stilicone custode e difensore dello stesso Onorio, mentre a suo dire l'aveva nominato protettore (parens) di entrambi i figli Arcadio e Onorio. La storia sembra ripetersi per il vescovo di Milano che, misogino qual'era (sofferente di repulsione o di avversione nei confronti delle donne), deve confrontarsi per la seconda volta con un'imperatrice. Rispetto a Giustina i rapporti con Serena potevano essere migliori almeno dal punto di vista confessionale, poiché Serena era cattolica. Ma fra Stilicone e Ambrogio sembra aleggiasse un'ostilità espressa più dai fatti che dalle parole, al punto che dalla corte neppure le basiliche cristiane erano ritenute luoghi sacri e potevano quindi essere invase da soldataglie. Comunque Stilicone, i cui figli avuti da Serena facevano parte della dinastia teodosiana e avrebbero potuto reclamare il trono, affermando di essere stato nominato custode di entrambi i figli di Teodosio, incrinerà definitivamente i rapporti fra la corte orientale
dell'Impero e quella occidentale, poiché in realtà a fungere da protettore di Arcadio sarà, fino al momento della propria morte, il Prefetto del Pretorio d'Oriente Flavio Rufino, sostituito successivamente da Eutropio. L'Impero romano è così diviso in una parte orientale, affidata ad Arcadio e una occidentale governata da Onorio. In realtà però, il governo effettivo era nelle mani di Rufino e poi di Eutropio in Oriente e del generale Stilicone in
Occidente. Il 27 febbraio del 395 si tennero i solenni funerali di Teodosio celebrati da Ambrogio, che pronunciò il "De Obitu Theodosii". Le esequie si svolsero seguendo per la prima volta il rito cristiano. L'8 novembre di quello stesso anno la salma di Teodosio venne tumulata nella basilica degli Apostoli di Costantinopoli. Vi rimarrà fino al saccheggio della città del 1.204 da parte di crociati (i veneziani si presero parecchi souvenir insieme alle spoglie di san Marco). Teodosio I fu l'ultimo imperatore a regnare su di un impero unificato e fece del cristianesimo la religione unica e
obbligatoria dell'Impero; per questo fu chiamato Teodosio il Grande dagli scrittori cristiani e dalle Chiese orientali è venerato come santo (San Teodosio I il Grande, commemorato il 17 gennaio). Nella definitiva divisione dell'Impero in una parte occidentale (Prefettura del pretorio delle Gallie con due diocesi in Gallia, una l'Hispania e un'altra la Britannia, la maggior parte della Prefettura del pretorio d'Italia formata da quattro diocesi: due diocesi in Italia, una l'Illiria e l'altra l'Africa), mentre all'Oriente toccarono la Prefettura del pretorio d'Oriente e due diocesi illiriche. Le diocesi dell'Illirico orientale erano state trasferite all'Impero d'Oriente sotto Teodosio I da Graziano e il mantenimento di questa assegnazione sarà fonte di continue dispute iniziate subito dopo la morte di Teodosio poiché saranno rivendicate per l'Occidente da Stilicone.
 |
Cartina dell'Impero Romano nel 395,
alla morte di Teodosio I, diviso in 2:
l'Impero Romano d'Oriente con
capitale Costantinopoli e l'Impero
Romano d'Occidente, con capitale
Roma, e dal 402 sarà Ravenna.
Sono indicate le varie città e regioni
dell'impero e le varie popolazioni
al di fuori di esso. |
- Per ragioni amministrative e probabilmente a causa delle tensioni
fra le due corti dell'impero dovute alle rivendicazioni di Stilicone,
e cioè sia di essere stato nominato tutore di entrambi gli
imperatori che la riassegnazione delle diocesi dell'Illirico
orientale all'Occidente, l'Impero Romano si divide definitivamente fra Impero Romano d'Occidente con imperatore Onorio, figlio di Teodosio I, i cui tutori erano Serena e Stilicone e Impero Romano d'Oriente con imperatore Arcadio, il figlio maggiore di Teodosio I, il cui tutore era Flavio Rufino. Flavio Onorio (Costantinopoli, 9 settembre 384 - Ravenna, 15 agosto 423) era il figlio terzogenito dell'imperatore Teodosio I e della sua consorte Elia Flaccilla, originari ambedue della provincia romana dell'Hispania; Arcadio e Pulcheria Teodosia (morta ad appena sette anni d'età), erano rispettivamente suo fratello e sua sorella maggiori. Il padre lo aveva onorato del titolo di nobilissimus puer e conferito il consolato per l'anno 386, quando Onorio aveva due anni. Flavio Arcadio (377 circa - Costantinopoli, 1º maggio 408) era il figlio maggiore di Teodosio I ed Elia Flaccilla, originari ambedue della provincia romana dell'Hispania e fratello di Onorio. A 17 anni Arcadio si era trovato a reggere il governo dell'Oriente, sotto la guida del prefetto Flavio Rufino, mentre il padre muoveva con l'esercito contro l'usurpatore Flavio Eugenio. Subito dopo la morte di Teodosio, Rufino aveva ottenuto il potere nell'Impero romano orientale esercitando la sua influenza sul giovane e debole Arcadio, a cui voleva far sposare la figlia, ma le sue ambizioni erano frustrate da un altro ministro imperiale, il praepositus sacri cubiculi Eutropio; Arcadio fu dominato fino
all'ultima parte della sua vita da Antemio, suo prefetto del
pretorio, che farà pace con Stilicone ad Occidente. Arcadio era più
preoccupato di apparire come un pio cristiano che delle questioni
politiche o militari, detenendo nominalmente il controllo dell'impero
fino alla sua morte, avvenuta per malattia il 1º maggio 408. La parte orientale dell'impero è ricca, grazie alle produzioni di cereali dell'Egitto e dell'Africa nord-orientale, i commerci della Siria, le produzioni agricolo-artigianali e manufatturiere di Siria, penisola anatolica e Grecia; inoltre la cultura, di stampo ellenistico, ha in Alessandria d'Egitto il centro più evoluto del mondo conosciuto. La parte occidentale ha come risorse agrarie solo la Sicilia e il nord Africa centrale, mentre è continuamente minacciata da invasioni di popolazioni germaniche, dirottate a occidente dalle solide mura e dalle politiche di Costantinopoli. Mentre aristocratici e notabili di tradizione e formazione romana entrano nel tessuto amministrativo della cristianità, le gerarchie e le formazioni dell'esercito sono sempre più composte da esponenti di quelle popolazioni barbariche che minacciano l'integrità dell'impero. Il pagamento dei loro servizi nei territori di confine impoverisce progressivamente l'impero e indebita sempre più un'amministrazione che non ha risorse. Per questi motivi, l'impero romano d'Oriente, che verrà poi chiamato bizantino dagli storici dal XVI secolo, sopravviverà per quasi mille anni all'impero romano d'Occidente.
La dicitura 'impero bizantino', è stata introdotta nel 1557 dallo storico tedesco Hieronymus Wolf, che in quell'anno diede alle stampe il libro "Corpus Historiae Byzantinae", poi è apparsa nel 1648 nelle pubblicazioni "Byzantine du Louvre" (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae) e nel 1680 nella "Historia Byzantina" di Du Cange, che diffusero l'uso del termine "bizantino" tra gli autori illuministi francesi fra cui Montesquieu. Con questo nome gli studiosi moderni e contemporanei hanno chiamato l'Impero romano d'Oriente, il cui nome è stato adottato fin dal regno dell'imperatore Valente (dal 364 al 378 d.C.), area di cultura prevalentemente greca separata dalla parte occidentale dell'impero, di cultura quasi esclusivamente latina con contaminazioni celto-germaniche, dopo la morte di Teodosio I nel 395. Non c'è accordo fra gli storici sulla data in cui si dovrebbe cessare di utilizzare il termine "romano" per sostituirlo con il termine "bizantino", anche perché solo nel 565 si assisterà alla morte di Giustiniano I, ultimo imperatore di madrelingua latina. Resta comunque il fatto che per gli imperatori bizantini e per i propri sudditi, il loro impero si identificava sempre con quello di Augusto e Costantino il Grande, fondatore di Costantinopoli e nato fra l'altro proprio nella serba Sirmio, dal momento che 'romeo' e 'greco', fino al XVIII secolo, erano per essi sinonimi.
Solo dopo il 610 il greco diventa lingua ufficiale dell'impero, con Eraclio I, che si proclama inoltre Basileus (in greco Βασιλεύς, Re) dell'impero, non più Augustus come era stato in uso fino ad allora.
 |
Cartina dell'Impero Romano nel 395:
i confini, la linea di demarcazione fra
Impero d'Oriente e d'Occidente,
le regioni altamente cristianizzate,
le aree di diffusione del cristianesimo
e le regioni non evangelizzate;
le sedi dei principali concili
con le date, le strade dell'Impero,
le maggiori città. |
Gli
abitanti dell'impero romano d'
Oriente definivano se stessi "
romani" (Rhōmaioi, Romei), il loro stato Basileia Rhōmaiōn, cioè "Regno dei Romani" o semplicemente Rhōmania, anche se di lingua greca. Gli stessi musulmani, conquistandone i territori, fondarono il sultanato di "
Rum", mentre gli europei occidentali venivano definiti "latini" (dalla lingua usata). Per corruzione dall'arabo Rūm (attraverso le modifiche in
Hrūm e quindi in sogdiano, una variante dell'iranico parlata in Sogdiana,
Frōm) derivò il termine cinese Fulin (pinyin: Fúlĭn Gúo, "
Paese di Fulin"). Con questo termine, sebbene con varianti grafiche, le storie dinastiche cinesi definirono l'impero bizantino dal tempo degli annali della dinastia Wei, scritti dal 551 al 554, fino agli annali della dinastia Tang scritti nel 945. Il termine
"
bizantino", derivato da Bisanzio, l'antico nome
della capitale imperiale Costantinopoli, non venne
mai utilizzato
durante tutta la durata dell'impero (395-1.453). Il
latino, piuttosto diffuso presso le classi alte di
Costantinopoli fino almeno all'età marcianea (Flavio Marciano imperatore romano d'Oriente dal 450 al 457), rimase comunque
lingua ufficiale dell'Impero d'Oriente: Eraclio I lo sostituì
con il greco intorno al 625. Nelle fonti papali del VI-VII-VIII secolo, l'Impero romano d'oriente era definito "
Sancta Res Publica" o "
Res Publica Romanorum":
solo
con la
rottura dei
rapporti tra
Papa e
Imperatore d'Oriente in
seguito all'Iconoclastia (a metà dell'VIII secolo) coloro che venivano fino
a poco tempo prima definiti "Romani" divennero per la
Chiesa di Roma "Greci" e la "
Res Publica Romanorum"
si trasformò in
Imperium Graecorum (Impero dei Greci), termine che poteva rimandare all'
accezione spregiativa di "
pagano".
- La
divisione fra Ostrogoti e Visigoti ebbe luogo tra il III e IV sec. nel Ponto, quando i
Visigoti (goti dell'ovest), allora noti come
Tervingi, riconobbero l’autorità dei
Balti, mentre gli
Ostrogoti (goti dell'est), prima noti come
Greutungi, avevano riconosciuto quella degli
Amali, considerati come i più valorosi tra i loro guerrieri. I goti
Tervingi, secondo il loro antico mito, erano emigrati dalle rive del mar Baltico nella Russia meridionale, sul Dnestr e sul Mar Nero e in realtà si erano formati come popolo solo in quelle regioni. Dal 395 i goti
Tervingi, divennero i
Visigoti, quando riconobbero l’autorità dei
Balti (nome che deriva dal termine gotico balþa (baltha), che significa "audace", che divenne la loro dinastia reale, sopravvalendo sugli Amali Ostrogoti per prestigio e potere, e che espresse tra il 395 ed il 531 i seguenti re dei Visigoti: Alarico I (395 - 410), Ataulfo (410 - 415) che sposando
Galla Pacidia ne fece una regina
visigota, Walia (415 - 419), Teodorico I (419 - 451), Torismondo (451 - 453), Teodorico II (453 - 466), Eurico (466 - 485), Alarico II (485 - 507), Gesalico (507 - 511), Amalarico (507 - 531). Lo storico inglese Edward Gibbon, nel suo “History of the Decline and Fall of the Roman Empire”, cita che questa stirpe ha lasciato una traccia nella provincia gota della
Settimania nell'appellativo storpiato di
Baux e una branca di questa famiglia la troviamo poi nel
regno di
Napoli. I signori di Baux (nei pressi di Arles) e di 79 cittadine subordinate, furono indipendenti dai conti di Provenza.
- Nonostante il sacrificio delle truppe visigote di Alarico alla battaglia del Frigido, che il 5 settembre 394 avevano costituito l'avanguardia dell'esercito di Teodosio I subendo gravissime perdite, dopo la morte dell'imperatore il 17 gennaio 395, Stilicone rispedisce i Visigoti nella loro provincia e non sarà più pagato il tributo annuale che Roma versava loro. Questi fatti, secondo lo storico Giordane, contribuirono a compromettere la pace che era stata raggiunta tra Goti e Romani e a far ricominciare le ostilità. I Visigoti allora, proclamato loro re Alarico, invadono la Tracia, la Macedonia, la Tessaglia, la Beozia e l'Attica finché non sono fermati dal generale Stilicone. L'imperatore d'oriente Arcadio intima però a Stilicone di rientrare in Occidente e all'esercito romano-orientale di rientrare a Costantinopoli, lasciando solo un contingente alle Termopili per difendere la Grecia. Inoltre, cercando di danneggiare il rivale Stilicone, magister militum dell'Impero romano d'occidente, Flavio Rufino consiglia ad Arcadio di richiamare le sue truppe dall'occidente e sarà proprio in quel trasferimento che il 27 novembre del 395 rimarrà ucciso, proprio dalle stesse truppe orientali, Flavio Rufino stesso. Sarà proprio l'accusa di aver tramato per l'assassinio di Rufino una delle motivazioni per cui Stilicone verrà condannato a morte da Onorio nel 408. I Visigoti, probabilmente grazie ad un tradimento, guadagnarono il famoso passo delle Termopili, attraversarono la Beozia e l'Attica e occuparono Il Pireo, costringendo Atene alla resa, pur senza saccheggiarla. Poi si diressero a Eleusi, dove distrussero il tempio di Demetra, determinando la definitiva interruzione delle celebrazioni dei Misteri Eleusini.
Nel 396 - Tutto il
Peloponneso è occupato dai
Visigoti:
Corinto,
Argo,
Sparta e molti altri siti subiscono violenze e devastazioni.
Nel 397 - Stilicone, pur essendo ora magister militum d'occidente, sbarca a Corinto con un esercito, caccia i Visigoti dall'Arcadia e li accerchia ad Elice. Propone quindi loro un'alleanza contro l'impero d'oriente, permettendogli di ritirarsi sulle montagne settentrionali dell'Epiro. Intanto Serena, moglie di Stilicone, alla fine del 397 sacrifica la prima figlia Maria sull'altare dinastico, dandola in moglie a Onorio. L'assenza di figli, dovuta principalmente alle tendenze di Onorio, risaputamente omosessuale, fu imputata a sortilegi operati da Serena per assicurare l'eredità a suo figlio Eucherio. L'accusa ci suggerisce che l'immagine popolare di Serena fosse piuttosto offuscata e che di lei si vedesse solo la grande ambizione personale.
 |
| Illirico ed Epiro, da QUI. |
Nel 399 - L'imperatore d'oriente
Arcadio, al fine di svilire l'alleanza di Stilicone coi
Visigoti, alleanza propedeutica ad una guerra civile nei propri confronti, nomina il loro re Alarico
magister militum dell'
Epiro, che già aveva occupato grazie a Stilicone, gli offre
denaro e
conclude così una nuova pace, deviando ad Occidente le mire dei Visigoti. Alarico approfitta della collaborazione con l'impero d'oriente per rafforzarsi e riarma i Visigoti dagli arsenali romano-orientali.
- Un destino simile a quello
dell'eunuco Eusebio (condannato a morte nel 361 d.C. dall'imperatore Giuliano detto l'Apostata) ebbe l'eunuco praepositus sacri cubiculi
Eutropio, al servizio dell'imperatore Arcadio (377-408 d.C.),
figlio di Teodosio I ed erede al trono d’Oriente. Per sostituirsi a
Rufino, consigliere di fiducia del principe, Eutropio fece uccidere
costui, incamerando le sue proprietà. Eutropio convinse poi Arcadio
a sposare Eudossia, figlia del generale Bautone, e fece esiliare o
dichiarare nemici dell'Impero tutti i suoi oppositori, compreso il
generale Stilicone. Il potere e la ricchezza di Eutropio
aumentarono al punto che dopo la nomina a patricius nel 398
d.C., ebbe anche il consolato l’anno dopo. Per la prima
volta un eunuco occupava una carica così alta,
scandalizzando la corte imperiale. Fu invece
san Giovanni Crisostomo (344-407 d.C.), patriarca di Costantinopoli,
a difendere, con una serie di omelie, l'operato di Eutropio che
tuttavia fu condannato all'esilio a Cipro, da dove con
un pretesto venne fatto tornare a Costantinopoli e fatto
giustiziare (nel 399 d.C.). I beni del praepositus
furono confiscati e la sua figura venne presa dal poeta Claudio
Claudiano (370-404 d.C.), come simbolo di tutti gli inganni,
tradimenti e vizi propri degli eunuchi.
Nel 400 - I Vandali Asdingi lasciano la Pannonia, spinti alla colonizzazione di nuove terre dall'avanzata delle truppe unne.
- Visto che il matrimonio fra la figlia Maria e l'imperatore Onorio non generava figli, a causa dell'impotenza dovuta alle tendenze omosessuali di Onorio, Serena organizza il fidanzamento di Galla Placidia con il figlio Eucherio che aveva avuto da Stilicone e all'epoca i due avevano rispettivamente otto e undici anni.
Nel 401 - Sotto la spinta di altri popoli germanici, i Vandali Asdingi, che già si erano convertiti all'arianesimo, si spingono fino alla Rezia, saccheggiandola e Stilicone riesce a fermarli temporaneamente. I Visigoti, passando da Aemona (Lubiana in Slovenia), arrivano in Italia e da Aquileia si dirigono a Milano, alla corte dell'imperatore Onorio, per ottenere una sovvenzione e una provincia in cui stabilirsi.
 |
Europa dal IV al VI sec., con i percorsi
delle invasioni e delle espansioni
degli Alani, gruppo dei Sàrmati e delle
popolazioni Germaniche dei Goti
(Ostrogoti e Visigoti), Vandali,
Svevi, Juti, Angli e Sassoni,
popolazioni spinte a est
dagli Unni, che giungevano
su cavalli dalle steppe
nordasiatiche. |
Nel 402 - Dopo Milano, l'imperatore Onorio elegge
Ravenna come
capitale dell'
Impero Romano d'Occidente visto che ormai Roma, dove ancora è insediato il Senato Romano, è troppo esposta ad eventuali scorrerie mentre Ravenna, con le paludi che ne ostacolano l'accesso e il porto alle spalle che garantisce una via di fuga via mare, è più sicura.
- Nel
402 i Visigoti sono fermati a Pollenzo, nel
cuneese, da Stilicone, che nomina Alarico magister
militum, purché lasci l'Italia. La "Notitia
Dignitatum", il ruolo organico dell'amministrazione civile e
militare del tardo impero romano, attesta la presenza nei primi anni
del V secolo di 15 colonie militari di Sàrmati anche in
Italia, soprattutto nella pianura del Po, sotto il comando di
un Praefectus Sarmatarum gentilium. Secondo quel documento una
di queste guarnigioni era stanziata nell'odierna provincia di Cuneo,
a Pollentia (oggi Pollenzo), nota per essere stata teatro nel
402 della battaglia tra i Visigoti di Alarico e i Romani, fra le cui
fila erano presenti cavalieri Sarmato-Alani. In seguito si sarebbero
spostati sul più sicuro e poco distante altopiano alla confluenza
fra il Tànaro e la Stura di Demonte, dove oggi sorge il piccolo
paese di Salmour che si ipotizza derivi il nome da
quell'antico insediamento (Sarmatorium). Dopo essere usciti
dall'Italia, i Visigoti non si allontanano dai confini.
Nel 403 - I Visigoti di
Alarico rientrano in Italia e assediano Verona, dove sono
sconfitti da Stilicone, che li costringe a rinnovare il patto di
alleanza contro l'impero d'oriente e a rientrare in Epiro; ma ben
presto abbandonano l'Illiria per stabilirsi tra il Norico e la
Pannonia. Sembra che Stilicone intendesse usare
Alarico come alleato contro l'Impero romano d'Oriente per spingere
l'imperatore d'oriente Arcadio a cedere all'Impero d'Occidente l'Illirico orientale, trasferito all'Impero d'Oriente sotto Teodosio I dall'imperatore Graziano.
Nel 405 - San Girolamo traduce e pubblica la Bibbia in Latino, chiamata Vulgata mentre Stilicone ordina la distruzione
dei libri sibillini, le cui profezie cominciavano a essere utilizzate
per attaccare il suo governo..
Nel 405/406 - Radagaiso, un condottiero
ostrogoto, a capo di una vasta coalizione di tribù germaniche (Goti,
Vandali Asdingi, Quadi, Suebi, Burgundi), Alani sarmatici e tribù celtiche, tra la fine del 405 e gli inizi
del 406 invade l'Italia. Con una folta schiera di guerrieri,
Radagaiso devasta l'Emilia e la Toscana ed assedia Fiesole.
Interviene allora il generale Stilicone che, al comando dell'esercito
romano rafforzato da schiavi liberati e truppe ausiliarie guidate
dall'unno Uldino e dal visigoto Saro (Sarus in latino), infligge una sconfitta decisiva
al nemico nei pressi di Fiesole il 23 agosto 406. Radagaiso abbandonò
l'esercito e tentò la fuga portandosi dietro un abbondante bottino
ma fu catturato e messo a morte insieme ai suoi figli presso Firenze.
Nel 406 - Le province della Britannia
romana si ribellano. Le guarnigioni non erano state pagate e
avevano deciso di scegliere il proprio capo. Le loro prime due
scelte, Marcus e Graziano, non avevano soddisfatto le loro
aspettative e furono uccisi.
- Alla fine del 406, Stilicone invia
Alarico in Epiro, stringendo con lui una nuova alleanza contro l'Impero
d'Oriente: l'intenzione di Stilicone era farsi consegnare da Arcadio
l'Illirico orientale. Per difendere l'Italia o per attaccare l'impero d'Oriente però, vennero sguarnite le frontiere della Gallia e proprio il 31 dicembre del 406, attraversando il Reno ghiacciato presso Mogontiacum, Vandali, Alani e Suebi o Svevi, invadono la provincia.
 |
Carta delle migrazioni dei popoli
in Europa nel III e IV sec. |
- Il
Reno, che
rappresentava il confine (
limes in latino) fra l'impero romano e le popolazioni germaniche dell'Europa centrale,
invalicabile per l'assenza di ponti, alla fine del 406
si ghiaccia completamente e il 31 dicembre, presso Mogontiacum (Magonza, l'attuale Meinz che sorge alla confluenza del Meno e del Reno, nei pressi di Francoforte sul Meno), viene varcato da
Vandali,
Alani,
Burgundi e
Suebi (o Svevi) alla ricerca di un futuro nella società romana. I federati Franchi Salii combattono contro gli invasori, dirottando la loro spinta principale a sud
della Loira, ma è l'
inizio dello
sgretolamento dell'
impero romano d'
occidente. Tempo prima, assieme agli
Alani
ed ai
Suebi (fra cui i
Quadi), i
Vandali Asdingi si erano spostati lungo il
limes da Augusta (Augsburg) in direzione del fiume Meno, dove a
loro si erano uniti i
Silingi (Vandali unitisi ai Burgundi nel III
secolo) e da qui avevano raggiunto il Reno, dove erano stati
affrontati dai
Franchi, federati dei Romani, nella
battaglia di Treviri dove avevano provocato gravi
perdite ai Vandali, ma sopraggiungendo gli Alani le sorti della battaglia si erano capovolte. Al capo dei Vandali Asdingi,
Godigisel, che aveva perso la vita nel corso della battaglia, successe il figlio
Gunderico che guidò i
Vandali della tribù degli Asdingi
oltre il Reno il 31 dicembre del 406, a
Magonza, che fu
rasa
al suolo, poi attraversarono rapidamente la Gallia, razziando i
villaggi e le città che incontravano lungo il loro cammino
sino
ad arrivare
ai Pirenei, dove si fermarono di fronte
ai passi fortificati e si riversarono nella
Gallia Narbonense. L'avanzata divenne un'invasione e scatenò il caos. Assieme alle tribù vandale degli Asdingi e di
parte dei Silingi (il resto dei Silingi era rimasto nelle
terre ancestrali della Pannonia e della Slesia finendo per
fondersi con gli
Slavi) si scatenarono sul territorio gallico
anche
Suebi e
Alani,
seguiti da
Burgundi e
Alemanni. L'immagine resta di
portata storica epocale, in quanto
questi popoli non sarebbero mai più usciti dall'Impero e vi avrebbero fondato, insieme agli stessi Visigoti,
i primi regni romano-barbarici. L'invasione, secondo la tradizione storica, causò immani massacri.
Nel 407 - All'inizio dell'anno, l'esercito romano in Britannia acclama l'usurpatore Costantino (ricordato come Costantino III o Costantino I d'Inghilterra) come imperatore. Temendo un'invasione germanica e alla disperata ricerca di un certo senso di sicurezza in un mondo che sembrava andare rapidamente a pezzi, l'esercito romano in Gran Bretagna cerca maggiore sicurezza in una leadership militare forte e abile e sceglie come leader un uomo che prende il nome dal famoso imperatore Costantino il Grande, salito al potere attraverso un colpo di stato militare in Britannia. Flavio Claudio Costantino, meglio noto come Costantino III (... – 411), è stato usurpatore dell'Impero romano d'Occidente (407 - 411) contro l'imperatore Onorio. Fu incluso tra i sovrani leggendari della Britannia (come Costantino II) nelle cronache gallesi e nella Historia Regum Britanniae di Goffredo di Monmouth, secondo la quale salì al potere dopo l'assassinio di Graciano Municeps. Goffredo dice che dopo questo omicidio la Britannia era sull'orlo della guerra civile e allora gli abitanti dell'isola chiamarono in soccorso i cugini di Municeps dalla Bretagna. Il sovrano di questa terra, Aldroeno, mandò suo fratello, Costantino II, che respinse gli Unni e i Pitti, che avevano invaso la Britannia. Ebbe tre figli: Costante, Ambrosio Aureliano e Uther Pendragon. Egli fece intraprendere a Costante la vita ecclesiastica. Regnò per cinque anni, ma fu deposto da Vortigern, che era il suo siniscalco. Questa storia si ritrova molte volte nel ciclo arturiano, compreso il "Merlino" di Roberto di Boron e nel Lancillotto in prosa, anche se con molte contraddizioni. Costantino era un soldato comune, ma dotato di una certa abilità. All'inizio del 407, acclamato imperatore, Costantino si mosse rapidamente e attraversò la Manica a Bononia (Boulogne) e (gli storici hanno ipotizzato) portò con sé tutte le truppe mobili rimaste in Gran Bretagna, privando così la provincia di ogni protezione militare di prima linea, motivando così la scomparsa delle legioni dalla Britannia all'inizio del quinto secolo. Le forze romane in Gallia si scherarono con lui, seguite dalla maggior parte di quelle in Hispania. Le forze di Costantino vinsero diversi scontri con i Vandali e si assicurarono rapidamente il limes del Reno.
- La notizia falsa di un presunto decesso di Alarico e l'usurpazione di Costantino III trattennero Stilicone dal raggiungere l'alleato Alarico in Epiro per condurre una guerra civile contro l'Impero romano d'Oriente per il possesso dell'Illirico orientale. Le diocesi dell'Illirico orientale erano infatti state trasferite all'Impero d'Oriente sotto Teodosio I dall'imperatore Graziano, ed erano quindi rivendicate per l'Occidente da Stilicone. Gli storici moderni si sono ripetutamente chiesti se l'invasione dell'Illirico fosse un piano da lungo tempo meditato, o piuttosto il risultato di eventi specifici, se non della disperazione. Autori più datati come John Bagnell Bury ritengono che Stilicone rivendicasse l'annessione dell'Illirico Orientale alla pars occidentis fin dal 395, mentre autori come Hughes, Mazzarino e Cesa, basandosi sui panegirici di Claudiano (opere di propaganda del regime stiliconiano che in alcuni passi sembrano riconoscere come legittimo il governo di Arcadio sull'Illirico Orientale), concludono che solo dopo la sconfitta di Radagaiso nel 405-406 Stilicone concepisse questa strategia come l'unica via di uscita, mentre prima si era illuso di poter mantenere unità d'intenti tra le due parti dell'impero. I potenti senatori romani si opponevano al reclutamento massiccio di barbari nell'esercito, non ritenendoli affidabili, ma allo stesso tempo non volevano fornire i contadini che coltivavano le loro terre, né pagare le tasse che avrebbero consentito all'impero di reclutare altrove i soldati. Per difendere l'Italia Stilicone aveva sguarnito la Britannia e la frontiera del Reno, lasciata forse ai soli federati Franchi, chiaro sintomo di una coperta troppo corta. Sentendosi indifese, o volendo cogliere l'opportunità data dal momento di debolezza e di crisi, alcune zone dell'impero se ne stavano allontanando, e tra queste la Britannia. Non è infatti del tutto certo chi abbia abbandonato chi, se Roma la Britannia o la Britannia Roma. Altre zone della Gallia erano infestate dai Bagaudi e si sarebbero presto staccate (come l'Armorica). L'effetto negativo era doppio, servivano soldati per controllare queste zone ribelli, ma il loro allontanamento privava allo stesso tempo la pars occidentis di fonti di reclutamento e introiti fiscali.
- Stilicone era pronto per la campagna contro l'impero d'Oriente nell'Illirico, contando anche sull'alleanza con Alarico e i suoi Visigoti, ma prima arrivò la notizia poi rivelatasi falsa che Alarico fosse deceduto, e Stilicone cercò di accertarsene; poi gli giunsero lettere di Onorio provenienti da Roma, che lo informavano dell'usurpazione di Costantino III e a tale notizia, il generale romano fu costretto ad annullare la spedizione illirica e a ritornare a Roma per stabilire le mosse future. Per cui, intenzionato a recuperare il possesso della Gallia, nel 407 Stilicone invia nella regione un'armata condotta dal generale romano di origini gote Saro (in latino Sarus; ... - 412), fratello di Sigerico (futuro re dei Visigoti per sette giorni), per porre fine all'usurpazione di Costantino III: Saro, attraversate le Alpi, ottenne alcuni successi iniziali, come la sconfitta e l'uccisione dei due generali di Costantino III, Giustiniano e Nebiogaste. Costantino III stesso fu assediato da Saro nella città di Valentia per sette giorni ma la città resistette all'assedio e ben presto accorsero in soccorso dell'usurpatore i rinforzi condotti dal franco Edobico e dal britannico Geronzio; all'arrivo di tali rinforzi, Saro fu costretto a levare l'assedio dopo soli sette giorni e tentare la ritirata, ma fu assalito e sconfitto dai due generali e riuscì a stento a sfuggire alla cattura. La ritirata frettolosa dell'esercito sconfitto di Saro verso l'Italia fu ostacolata durante l'attraversamento delle Alpi dai briganti Bagaudi, che consentirono all'esercito romano di tornare in Italia solo a patto che venisse loro ceduto tutto il bottino di guerra.
Nel 408 - Serena, in attesa che suo figlio Eucherio possa sposare Galla Placidia, temporeggia e alla morte della figlia Maria, fa sposare a Onorio l'altra figlia, Termanzia.
- In maggio, l'usurpatore Costantino III fa di Arles la propria capitale, dove nomina Prefetto Apollinare, il nonno di Gaio Sollio Sidonio Apollinare (Lugdunum, 5 novembre 430 circa - Clermont-Ferrand, 486), nobile gallo-romano, alto funzionario dell'Impero romano, poeta, epistolografo, vescovo di Alvernia e santo. Il suo rango e le sue conoscenze fecero sì che fosse al centro della vita pubblica della sua epoca.
- Stilicone è informato che Alarico aveva lasciato l'Epiro e che aveva collocato il suo accampamento a Emona, città situata tra la Pannonia Superiore e il Norico. Il re dei Visigoti aveva ricevuto lettere da Onorio che gli avevano annunciato l'annullamento della spedizione e gli avevano ordinato di rientrare in territorio romano-occidentale. Alarico, arrabbiato per l'annullamento della spedizione senza che avesse ricevuto alcuna ricompensa o almeno un rimborso spese per il mantenimento delle sue truppe per tutto il tempo trascorso in Epiro in attesa di Stilicone, decide di marciare in Norico, da dove invia messaggeri a Stilicone che gli chiedono 4.000 libbre d'oro, non solo come ricompensa per i servigi prestati all'Impero d'Occidente in Epiro ma anche come rimborso spese per il viaggio dall'Epiro al Norico, e minaccia di invadere l'Italia nel caso questa richiesta non sia soddisfatta. Stilicone, all'arrivo dei messaggeri di Alarico a Ravenna, li trattenne nella nuova capitale della parte occidentale e si dirige a Roma, dove intende consultarsi con l'Imperatore e con il Senato romano riguardo al pagamento di Alarico. Il senato, riunitosi al palazzo imperiale, discusse se dichiarare guerra al re dei Visigoti oppure pagargli la somma di denaro: la maggior parte dei senatori erano propensi per la guerra mentre Stilicone e pochi altri erano di opinione contraria e votarono per la pace con Alarico. Quando i senatori propensi alla guerra chiesero a Stilicone perché propendeva per la pace e conseguentemente al disonore del nome romano, in quanto essa veniva comprata con del denaro, il generale romano rammentò che Alarico era intervenuto in Epiro per assistere l'Impero d'Occidente nel tentativo di sottrarre all'Impero d'Oriente l'Illirico orientale e il piano avrebbe già avuto successo se non fosse intervenuta Serena, sua moglie, che volendo evitare una guerra civile tra le due parti dell'Impero, era riuscita a indurre Onorio a fermare la spedizione. Stilicone mostrò inoltre al senato una lettera dell'Imperatore a riprova di quanto aveva affermato. Il senato, ascoltate le argomentazioni di Stilicone, accettò di versare ad Alarico le quattromila libbre d'oro e soltanto un senatore di nome Lampadio, secondo la tradizione, ebbe il coraggio di affermare che «questa non è una pace, ma un contratto di servitù». Secondo Zosimo, Stilicone intendeva inviare Alarico in Gallia per combattere l'usurpatore Costantino III, e avrebbe avuto l'approvazione di Onorio, che scrisse persino ad Alarico, ma l'esecuzione di Stilicone mandò a monte tutto. Una volta versate le 4.000 libbre d'oro ad Alarico, Onorio decise di recarsi dapprima a Ravenna e poi a Pavia, dove voleva visionare l'esercito che doveva essere inviato contro l'usurpatore Costantino III. Onorio intendeva lasciare Roma per stabilirsi a Ravenna, sembra per suggerimento di Serena, che temeva che se l'Imperatore fosse rimasto a Roma avrebbe avuto un rischio maggiore di essere catturato da Alarico nel caso avesse invaso l'Italia e riteneva, al contrario, Ravenna maggiormente sicura. Giustiniano, avvocato consigliere di Stilicone, temendo che se Onorio si fosse recato a Pavia il rischio di una rivolta delle truppe romane di stanza a Pavia, avverse a Stilicone, sarebbe stato elevato, tentò di distogliere l'Imperatore dal viaggio senza però riuscirci.
- Stilicone parte dunque per Ravenna, ma il viaggio a Pavia di Onorio, che è una pericolosa banderuola pronta a cambiare al primo vento, dà fastidio a Stilicone. Appena arrivato a Ravenna il magister provoca una agitazione tra i soldati con l’appoggio di Saro, ufficiale barbaro a lui fedele. Onorio, tuttavia, non si fece intimorire e partì per Bologna, dove scrisse a Stilicone, che all'epoca si trovava a Ravenna, ordinandogli di punire i rivoltosi. Quando però Stilicone annunciò la sua intenzione di punirli con la decimazione, i soldati con un pianto dirotto ottennero che il generale scrivesse all'Imperatore, chiedendo di non punirli, ottenendo così il perdono dall'Imperatore e scampando pertanto alla punizione. Stilicone raggiunse quindi Onorio a Bologna, dove i due ebbero una discussione accesa: Onorio, essendosi spento per malattia il I° maggio suo fratello Arcadio, intendeva infatti andare a Costantinopoli per assicurare la successione al nipote Teodosio II, figlio di Arcadio mentre Stilicone cercava di convincerlo che la presenza dell'Imperatore in Italia in questi frangenti così delicati (con Alarico e Costantino "III" in agguato) era necessaria e che sarebbe andato lui stesso in Oriente a sistemare le cose. Stilicone consigliò inoltre Onorio di negoziare con Alarico per stringere una nuova alleanza con lui: il generale intendeva impiegare i foederati Visigoti di Alarico in Gallia contro l'usurpatore Costantino III insieme alle legioni romane, sperando che con l'aiuto di Alarico sarebbe riuscito a recuperare la Gallia. Convinto da Stilicone, Onorio scrisse ad Alarico e alla corte d'Oriente e partì da Bologna per raggiungere Pavia. Partito Onorio, Stilicone si preparò per partire per Costantinopoli ma, narra Zosimo, tardò ad eseguire ciò che aveva promesso.
- Nell'estate del 408, le forze romane in Italia si riuniscono per attaccare l'usurpatore Costantino "III" mentre lui temeva che i cugini di Onorio in Hispania avrebbero organizzato un attacco da quella direzione mentre le truppe al comando di Sarus e Stilicone lo attaccavano dall'Italia, con una manovra a tenaglia. Quindi pensò di colpire per primo in Hispania e convocò il figlio maggiore, Costante, dal monastero dove abitava, lo elevò a Cesare e lo mandò con il generale Geronzio verso l'Hispania, dove sconfissero i cugini di Onorio con poca difficoltà. Didimo e Veriniano, furono catturati e altri due, Lagodius e Teodosiolus, fuggirono; il primo a Roma e Teodosiolus a Costantinopoli. Costante lasciò la moglie e la casa a Saragozza sotto la cura di Geronzio e tornò ad Arles per riferire al padre.
 |
Dittico con Stilicone, la moglie
Serena e il figlio Eucherio.
Monza, tesoro del duomo. |
- Nel frattempo, la fazione della corte di Onorio contraria alla politica di Stilicone, favorevole al compromesso con i Visigoti e avversa all'Impero d'Oriente, capeggiata dal cortigiano Olimpio, originario del Ponto Eusino, decide di passare all'azione per provocare la rovina di Stilicone. Olimpio, durante il viaggio dell'Imperatore Onorio verso Pavia, comincia a suscitare sospetti in Onorio sulla fedeltà di Stilicone, affermando che avesse pianificato l'assassinio di Rufino, stesse brigando con Alarico, che avesse invitato i barbari nel 406 in Gallia e che intendesse dirigersi a Costantinopoli con l'intenzione di mettere sul trono imperiale il figlio Eucherio. Giunto poi a Pavia,
Olimpio ripeté gli stessi discorsi, volti a
screditare Stilicone,
all'esercito radunato a Pavia, spingendolo pertanto alla rivolta.
- A Ravenna e a Milano il partito antibarbarico o antigermanico aveva tessuto la sua strategia. Il 13 agosto a Ticinum (Pavia), proprio nel momento in cui Onorio, nel passare in rassegna le truppe, le stava incitando a dare il massimo nella guerra contro l'usurpatore Costantino III, al segnale di Olimpio, un civile abile negli intrighi di palazzo e nuovo favorito di Onorio, insorgono all’idea di essere nello stesso esercito assieme ai Visigoti di Alarico, un nemico pagato con soldi dello stato, il medesimo Alarico che avevano combattuto nelle passate battaglie sul suolo italico. Scoppiano gravissimi tumulti; davanti all’imperatore i soldati si gettano sugli alti dignitari stiliconiani del governo, compiono una strage e saccheggiano la città. Si narra che Onorio, nel tentativo di porre fine alla rivolta, si togliesse la porpora e il diadema e vagasse per la città nel tentativo di fermare i soldati, riuscendoci con molta fatica. È un vero colpo di stato: la fazione antigermanica prende un effimero sopravvento. Onorio terrorizzato fugge a Milano. Nomina frettolosamente magister officiorum Olimpio e prefetto al pretorio d’Italia il cattolico Mallio Teodoro. Ormai è rottura tra Onorio e Stilicone, l’imperatore infatti dà ordine ai suoi ufficiali di arrestarlo.
- Stilicone, che è a Bologna, si rende
conto che la sua politica è finita. In un primo momento pensa di
dirigersi verso Pavia, ma quando viene a sapere che Onorio
offre la sua copertura alla rivolta della fazione
antigermanica, vi rinuncia. Da leale soldato tiene fede al giuramento
fatto a Teodosio e rifiuta di marciare alla testa delle truppe
foederate contro i reggimenti romani di Ticinum (Pavia). Dà anzi
l’ordine di chiudere le porte delle città del nord Italia onde
impedire alle famiglie dei soldati Goti di raggiungere i loro
parenti. Con questa disposizione permette al governo di cautelarsi
contro la ribellione delle truppe barbariche e gli ostaggi civili
diventano un efficace deterrente contro un inizio di guerra civile
tra milizie dello stesso impero. A Bologna, durante
la notte il capo goto Saro
furente massacra la
guardia del corpo di
Stilicone (composta da Unni di
Pannonia) ed ha con lui un misterioso colloquio
nella sua tenda, probabilmente per convincerlo a spodestare Onorio e
il partito anti-germanico.
- Stilicone, distrutto moralmente e psicologicamente, va a Ravenna. Qui trova l’appoggio delle milizie foederate subito accorse, con la possibilità di scontri con la guarnigione della città. Non riuscendo più a conferire con Onorio per persuaderlo dell'infondatezza delle accuse di tradimento, Stilicone riesce a trovare riparo in una chiesa, dove entrano le truppe di Onorio presentando a Stilicone una prima lettera scritta da Onorio, in cui veniva ordinato semplicemente il suo arresto e la detenzione in carcere, ma non la sua esecuzione e lo inducono ad uscire dalla chiesa. Non appena Stilicone uscì dalla chiesa tuttavia, i soldati gli lessero una seconda lettera, nella quale veniva ordinata la sua esecuzione per presunto tradimento. Non appena fu letta la seconda lettera, i soldati barbari fedeli a Stilicone erano sul punto di intervenire per salvare il generale dall'esecuzione, ma Stilicone li fermò all'istante, accettando il suo destino. Stilicone sarà giustiziato il 23 agosto del 408 da Eracliano. Nelle città dell'impero d'occidente le truppe romane regolari si scatenarono contro i parenti dei soldati visigoti e vi furono massacri.
- Alla notizia le milizie foederate non rispondono più al governo imperiale. Circa trentamila soldati di origine barbarica si uniscono alle forze di Alarico. È un momento di totale confusione: l’esercito è diviso. Olimpio assume la direzione della politica imperiale e scatena l’epurazione contro gli stiliconiani: Deuterio, capo dei ciambellani di corte e Pietro, capo dei notai, vengono arrestati, torturati e uccisi a bastonate. Onorio allontana dal trono la moglie Thermantia (figlia di Stilicone e che aveva sposato all’inizio dell’anno) e ordina l’uccisione del figlio di Stilicone, Eucherio, che fugge inutilmente a Roma trovando breve asilo in una chiesa. Naturalmente vi sono ripercussioni anche in Gallia dove, in agosto, viene ucciso il prefetto stiliconiano Limenio. In Italia viene ucciso il prefetto Longiniano, collega di Curzio. Gli stiliconiani uccisi nella rivoluzione di agosto erano tutti funzionari in carica.
- Ma neanche in questo momento Alarico pensa di dare il colpo mortale. Chiede un riconoscimento in denaro, due ostaggi, Aezio figlio di Giovio, prefetto dell’Illirico, e Giasone figlio di Gaudenzio già comes d’Africa. Promette di ritirarsi in Pannonia. Onorio respinge le richieste, ma trascura di preparare l’esercito per una prevedibile reazione militare del capo goto. Sul fronte interno lo squagliamento e la disintegrazione dell’esercito continua: Saro, il comandante più amato dalle truppe visigote non viene recuperato ma si mantiene fedele all’impero. Come comandanti Olimpio assegna Turpilione alla cavalleria, Varane alla fanteria e Vigilanzio al corpo dei domestici.
- Apprese le mosse della coppia Onorio-Olimpio, Alarico dalla sua sede nel Norico prepara per bene la spedizione: fa venire dalla Pannonia Ataulfo, fratello della moglie, con una moltitudine di Unni e Goti ma non lo aspetta. In autunno entra in e supera agevolmente Aquileia. Oltrepassa il Po e raggiunge, con una passeggiata militare, Ecubaria (Monteveglio o Vigarano Mainarda o Mirandola), roccaforte vicino a Bononia (Bologna). Aggira Ravenna, passa per Rimini poi da Ancona e punta deciso (per la Via Salaria) verso Roma.
- In seguito all'esecuzione di Stilicone, Olimpio si impossessa del controllo dell'Impero, ricevendo la carica di magister officiorum e ottenendo dall'Imperatore che le alte cariche dello stato fossero assegnate a uomini di sua fiducia. Il regime di Olimpio si occupò anche di perseguitare i famigliari e i partigiani di Stilicone, molti dei quali furono processati, interrogati affinché confessassero i presunti piani di tradimento di Stilicone e, nei casi in cui non ci fossero confessioni, giustiziati. Onorio divorziò da Termanzia, figlia di Stilicone, e ordinò l'esecuzione di un altro figlio del generale, Eucherio, il quale, pertanto, si rifugiò in una chiesa di Roma. A Roma il comes sacrarum largitionum Eliocrate ricevette addirittura l'ordine di confiscare e vendere i beni di chiunque avesse ottenuto magistrature nel periodo della reggenza di Stilicone. Come se non bastasse, in seguito alla presa di potere da parte di Olimpio, assunse il controllo dello stato la fazione antibarbarica contraria all'imbarbarimento dell'esercito e alla negoziazione con Alarico: ciò, tuttavia, provocò effetti deleteri per l'Impero, con un indebolimento dell'esercito. Infatti, forse per ordine di Olimpio, le truppe di presidio delle città massacrarono le mogli e i figli dei soldati barbari al servizio dell'Impero e ne saccheggiarono le case. I soldati barbari, informati della notizia, per vendicarsi dei Romani che avevano trucidato le loro famiglie, decisero di disertare e allearsi con Alarico. Secondo Zosimo, Alarico fu così rinforzato da 30.000 soldati barbari che fino a poco tempo prima avevano servito Roma e Stilicone. Peter Heather ritiene invece che la cifra di 30.000 soldati si riferisca all'intero esercito di Alarico, avanzando l'ipotesi che Zosimo possa aver frainteso su questo punto la propria fonte, cioè Olimpiodoro di Tebe. Onorio, rimasto privo di una valida forza militare con cui opporsi ai barbari e all'usurpatore Costantino III, decide nel 408 di associare quest'ultimo al trono riconoscendolo co-imperatore e associandolo al consolato per l'anno successivo.
- Il successivo sacco di Roma del 410 per opera dei Goti di Alarico, dimostrò che cosa valesse l'impero senza le milizie e i comandanti germanici ed ebbe così inizio l'epoca dei regni germanici nelle provincie romane. Dopo otto secoli un esercito straniero entrava di nuovo a Roma. Nella navata centrale della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, si può vedere un sarcofago paleocristiano in marmo chiamato Sarcofago di Stilicone. Risulta tuttavia inverosimile, per il luogo e il modo in cui fu ucciso, che il generale sia stato sepolto a Milano; il nome della tomba si deve probabilmente ad una tradizione popolare. Un nuovo esercito romano era in preparazione in Italia per una seconda campagna contro l'usurpatore Costantino III, ma quando Stilicone venne giustiziato per ordine di Onorio (il 22 agosto 408), il generale romano di origini gote Saro e i suoi uomini abbandonarono l'esercito, lasciando l'imperatore senza protezione, arroccato nell'inespugnabile Ravenna con l'esercito dei Visigoti di Alarico I libero di muoversi in Etruria.
- Eucherio, Serena e Termanzia fuggirono a Roma, ma l'antipatia del Senato romano verso Serena e il figlio ne decretò la morte. Serena aveva sfidato le antiche divinità romane sottraendo una collana alla statua di Giunone per adornarsene: era una sacrilega e non poteva essere aiutata. Termanzia si ritirò in un monastero, mentre sua madre e suo fratello venivano decapitati. A orchestrare la regìa delle accuse era stata Galla Placidia, che finalmente poteva vendicarsi di essere stata segregata e strumentalizzata per diciannove anni da Serena (Zosimo, V, 38). Contro Placidia si sono schierati gli storici a noi contemporanei, bollandola del titolo di delatrice. Certo era una donna che aveva meditato e accarezzato la sua vendetta nelle interminabili giornate passate alla corte di Milano, in un'adolescenza priva di gioie e di affetti. La Nemesi (personificazione della giustizia, in quanto garante di misura e di equilibrio, divinizzata nell'antichità classica e modernamente intesa come fatale punitrice della tirannide e dell'egocentrismo attraverso le alterne vicende della storia; vendetta orchestrata dagli eventi) a volte assume questo aspetto.
Nel 409 - Un'ambasceria guidata da Attalo, membro del Senato romano, giunge a Ravenna il 17 gennaio 409 con lo scopo di perorare la causa del
sovrano visigoto. Non ha successo ma Attalo è comunque onorato dall'imperatore Onorio della carica di comes sacrarum largitionum, grazie all'influenza di Olimpio, membro della corte che aveva causato la caduta e la morte di Stilicone. Prisco Attalo (fl. 394 - 416) è stato un senatore romano, due volte usurpatore dell'Impero romano, la prima volta nel 409 - 410 e la seconda nel 414 - 415, elevato a quella carica dal sostegno dei Visigoti. Greco dell'Asia di rango senatoriale, Attalo era uno dei più influenti membri del Senato romano, pagano e interessato agli indovini. Nel 398 aveva fatto parte di un'ambasceria del Senato romano presso l'imperatore Onorio che chiedeva l'esenzione dei senatori dal reclutamento nell'esercito, esenzione che ottennero. Il re dei Visigoti
Alarico I, per tutta risposta, eleva Attalo al soglio
imperiale, in opposizione a Onorio, che si era rinchiuso a Ravenna.
In quell'occasione, Attalo si fa battezzare ed estende i diritti delle gerarchie, cattolica e ariana, nomina Alarico
magister utriusque militiae, che lo pone a capo delle
gerarchie militari e civili mentre suo fratello Ataulfo riceve il rango di guardia
imperiale a cavallo. Attalo rappresentava gli interessi della nobiltà
senatoriale, all'epoca in conflitto con Onorio, contrasto che negava l'autorità di Attalo nell'impero e in regioni dell'Italia. Avvenne così la defezione di Eracliano, il comes
Africae, fedele a Onorio che controllava la diocesi d'Africa, dalla
quale giungeva l'indispensabile rifornimento di grano per la
città di Roma: allo scopo di indebolire Attalo, Onorio aveva
ordinato a Eracliano di interrompere la fornitura, causando la
carestia in città. Attalo, di concerto con Alarico, preparò una
spedizione contro Eracliano, poi quella stessa estate si mosse verso
Ravenna accompagnato dal re visigoti, mettendo sotto assedio la
capitale di Onorio. L'imperatore assediato offrì ad Attalo di
condividere il potere, ma questi si rifiutò, continuando l'assedio;
fu però costretto a ritornare a Roma, in quanto la sua capitale
soffriva per la mancanza di rifornimenti di grano causati dal blocco
ordinato da Eracliano, che aveva sconfitto le forze inviategli contro
da Attalo. Quando Attalo si rifiutò di affidare a un capo goto il
comando di una seconda spedizione contro Eracliano, poiché
intenzionato a trattare con Onorio, Alarico lo depose, spogliandolo
dei paramenti imperiali e incarcerandolo insieme al figlio Ampelio e progettò di mettere in atto il
sacco di Roma.
- Nell'autunno del 409, mentre Burgundi e Alemanni si stanziano in Gallia, i Vandali Asdingi e Silingi con Alani e Suebi si dirigono verso i Pirenei per superarli e penetrano in Hispania, probabilmente con la complicità del governatore romano della penisola iberica, Geronzio, che si era ribellato a Roma e mirava a crearsi uno stato indipendente. Per due anni queste popolazioni, tre di origine germanica e gli Alani che erano una popolazione sarmatica, si aggirarono per le fiorenti campagne iberiche, abbandonandosi al saccheggio ed alle devastazioni: « Imperversando i barbari per la Spagna, e infuriando il male della pestilenza, l’esattore tirannico e il soldato depredano le sostanze nascoste nelle città: la carestia infuriò, così forte che le carni umane furono divorate dal genere umano: le madri uccisero o cuocerono i propri nati mangiandoseli. Le bestie feroci, abituate ai cadaveri uccisi con la spada, dalla fame o malattia, uccisero qualsiasi essere umano con le forze che gli rimanevano, si nutrivano di carne, preparando la brutale distruzione del genere umano. E la punizione di Dio, preannunciata dai profeti, si verificò con le quattro piaghe che devastarono l’intera Terra: ferro, carestia, peste e le bestie. » (Idazio, Cronaca, anno 410). In particolare gli Svevi o Suebi di re Ermerico, devastarono per due anni le province occidentali e meridionali.
Nel 410 - I Visigoti, capeggiati da Alarico, conquistano e saccheggiano Roma. Quando Onorio sembrava
dunque aver riportato una vittoria su Alarico, un suo
ex-generale, Saro, attaccò proditoriamente e a sua
insaputa Alarico, il quale, sentendosi tradito
dall'imperatore, rimise l'assedio a Roma per la terza
volta (agosto 410). La città cadde il 24 agosto e fu messa a sacco,
il famoso sacco di Roma, spogliata dei suoi beni
preziosi e, soprattutto, dei viveri. La notte del 24 agosto 410, la
Porta Salaria fu aperta a tradimento e i Goti poterono finalmente
penetrare nell'Urbe e saccheggiarla per tre giorni interi. Alarico
permise a ognuno dei suoi seguaci di impadronirsi di quanta ricchezza
possibile, e di saccheggiare tutte le case dell'Urbe; ma, per
rispetto nei confronti dell'Apostolo Pietro, ordinò che la basilica
di San Pietro avrebbe costituito un luogo di asilo inviolabile.
Quando i Visigoti di Alarico lasciarono l'Urbe, portarono con
loro anche un prezioso ostaggio, Galla Placidia, da
utilizzare per costringere Onorio a cedere alle loro richieste:
iniziarono così diversi anni di prigionia per la
giovane principessa, all'epoca diciottenne. I Visigoti lasciarono
Roma carichi di bottino dopo tre giorni di saccheggio e Alarico,
passando da Capua e da Nola in Campania (dove Galla Placidia conobbe
il vescovo Paolino di Nola, anch'egli fatto prigioniero, cui in
seguito scrisse una lettera conservatasi) che fu devastata, si
diresse poi in Lucania e da lì in Calabria (l'antico Bruzio), a
Reggio. La sua intenzione era invadere con una flotta, dapprima la
Sicilia e poi l'Africa, il granaio dell'Impero. Secondo il pagano
Olimpiodoro tuttavia, una statua pagana eretta nei pressi dello
stretto di Messina, con la funzione di impedire il passaggio ai
Barbari, lo avrebbe indotto a rinunciare all'invasione e a ritirarsi
più a Nord. Secondo il cristiano Orosio, invece, una provvidenziale
tempesta disperse e affondò le navi quando erano già in parte
cariche e pronte a partire, inducendo il re goto a rinunciare ai suoi
piani per poi riprendere la strada verso nord, lungo la
quale, nei pressi di Cosenza, si ammalò improvvisamente e morì.
Secondo la leggenda, tramandata da Giordane, venne seppellito con i
suoi tesori nel letto del fiume Busento a Cosenza. Gli
schiavi, che avevano lavorato alla temporanea deviazione del corso
del fiume, furono uccisi perché fosse mantenuto il segreto sul luogo
della sepoltura. Ad Alarico succedette il cognato
Ataulfo, che successivamente avrebbe sposato Galla Placidia,
sorella di Onorio.
- I Visigoti, dopo essere entrati in Italia più volte per ottenere una sovvenzione e una provincia in cui stabilirsi e aver tentato a più riprese un accordo con l'imperatore d'occidente Onorio, che si era trincerato a
Ravenna, dopo la morte di Stilicone (408), spazientiti, ritornano a Roma per la terza volta e il 24 agosto 410 e grazie ad un traditore ignoto che aveva lasciata aperta la porta Salaria, entrano e saccheggiano Roma (il primo Sacco della Roma imperiale, dopo quello dei Celti Senoni di Brenno del 390 a.C.)
per tre giorni. L'episodio avviene dopo anni di promesse (non mantenute) di terre ad Alarico da parte dell'imperatore romano d'occidente come pagamento per i servizi militari prestati dai Visigoti.
 |
Il pettorale del giudizio o della
decisione trafugato a Gerusalemme
dai Romani, da QUI |
Nel saccheggio viene trafugato anche il tesoro di Salomone, che i Romani trafugarono a loro volta nel 70 d.C. a Gerusalemme, quando la rasero al suolo. Come si può vedere nei bassorilievi dell'arco trionfale di Tito, il tesoro trafugato includeva anche la Menorah, l'immenso candelabro d'oro a sette braccia e il pettorale d'oro con le pietre preziose corrispondenti alle 12 tribù d'Israele. Gli invasori Visigoti portarono via in pratica tutte le ricchezze della Città Eterna. Narra lo storico Procopio che
Alarico s'
impadronì dei «
tesori di Salomone, re degli Ebrei, mirabili a vedersi perché quasi tutti adorni di smeraldi, che anticamente erano stati presi a Gerusalemme dai Romani ». I Visigoti lasciarono Roma
carichi di bottino e tentarono di passare in Sicilia per impadronirsi poi dell'Africa, il granaio dell'Impero, ma una tempesta disperse e affondò le loro navi, già in parte cariche e pronte a partire. Allora ripresero la via del nord, ma in Calabria, nei pressi di Cosenza,
Alarico si ammalò improvvisamente e
morì.
- Nel 410, dopo aver adottato un atteggiamento più pacifico, i conquistatori dell'Hispania che avevano sfondato il limes del Reno alla fine del 406, che non erano più di 30.000, ottennero da Roma lo status di foederati in cambio del giuramento di fedeltà all'imperatore d'occidente Onorio.
 |
Invasione di Iuti, Angli e Sassoni
nella Britannia romana, da QUI. |
- Dallo stesso 410, visto che i Romani avevano abbandonato la Britannia, i germani
Iuti,
Angli e
Sassoni invadono la
Britannia. L'
invasione dei Germani (Angli,
Sassoni, Juti e altri) nella
Britannia, anche indicata come la
colonizzazione anglosassone della Britannia, è l'insieme delle
migrazioni avvenute nel V secolo d.C. di parecchie genti germaniche
dalle coste occidentali dell'Europa continentale per insediarsi in
Britannia, l'attuale Gran Bretagna. Non sono note date precise, ma si
sa che l'invasione iniziò al principio del V secolo,
dopo che
le
truppe romane lasciarono la
Britannia nel
410, con l'iniziale sbarco dei Sassoni in prossimità del Vallo di
Antonino, e proseguì per i decenni successivi. Il loro arrivo è
chiamato
Adventus Saxonum nei testi latini, una definizione
utilizzata per la prima volta da Gildas verso il 540. L'
Adventus
Saxonum è considerato il
punto di
inizio della
Storia dell'
Inghilterra ed è tradizionalmente ritenuto
un'invasione piuttosto che una colonizzazione, con date che
differiscono e circostanze solamente ipotizzate. Qualunque possa
essere la migliore data di inizio, una misura del successo iniziale
che gli Anglosassoni ebbero giunse nel 441, quando la
Cronica
gallica del 452 registrò che la Britannia cadde sotto la
dominazione sassone dopo aver subito molti disastri e razzíe,
intendendosi con questo che per quella data tutti i contatti con la
costa britannica erano stati interrotti. Il dibattito, sia fra gli
studiosi sia in altri ambiti, è tuttora aperto in merito alle
modalità e alle ragioni per le quali gli insediamenti anglosassoni
ebbero successo, così come riguardo a quali fossero i rapporti fra
Anglosassoni e Britanni romanizzati, in particolare in che misura i
nuovi venuti cacciarono o sostituirono gli abitanti già presenti. I
Britanni non romanizzati (
Celti) che vivevano nell'ovest e nel
nord della Britannia restarono in gran parte
estranei
all'insediamento degli Anglosassoni. L'unica fonte scritta affidabile
e utile riguardante le genti note con il nome di Anglosassoni e i
luoghi da cui provenivano è la
Historia ecclesiastica gentis
Anglorum, scritta verso il 731 dal Venerabile Beda. Essa
identifica i migranti come Angli, Sassoni e Juti e afferma inoltre
che i Sassoni venivano dall'Antica Sassonia e gli Angli dall'Anglia,
che si trovava tra le terre di origine di Sassoni e Juti. Si ritiene
ragionevolmente che l'Anglia corrisponda all'antico
Schleswig-Holstein (lungo l'attuale confine tra Germania e
Danimarca), includendo l'attuale Angeln. Lo Jutland era la patria
degli Juti e la costa tra i fiumi Elba e Weser è il punto d'origine
dei Sassoni. Quando gli anglo-sassoni si trasferirono in Gran Bretagna, alcuni dei
nativi gallesi celti (welsh, dalla parola germanica Welschen che designa gli "stranieri", parola che deriva dal nome della tribù celtica dei Volci Tectosagi che erano appunto confinanti e talvolta in guerra con le tribù germaniche e pertanto stranieri per questi)
attraversarono la
Manica e si stabilirono nella
Bretagna Armoricana, nell'attuale Francia, portandosi la loro lingua madre che diventò in seguito il bretone, che rimane ancora oggi parzialmente intelligibile con il gallese moderno ed il cornico.
















































































































.jpg)




















































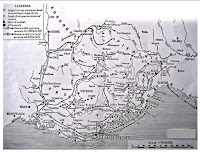



















































.jpg)














































Nessun commento:
Posta un commento